Editoria 2025: 21 libri per l’estate consigliati da Oubliette Magazine
“Le giuro che fra due anni avremo davanti a noi tutto il mondo in preda alle convulsioni. Io sono un destino.” ‒ Friedrich Nietzsche
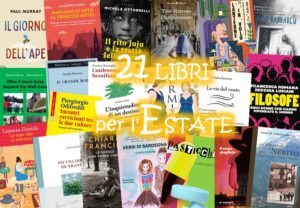
“Io sono un destino”: così Friedrich Nietzsche parlò di sé in una lettera a Georg Brandes nel 1888 (“Lettere da Torino”, Adelphi) quando, colmo della stessa esaltazione che lo portò al fatidico crollo mentale del gennaio 1889, scriveva senza sosta ad amici, conoscenti, editori per illustrare la produzione filosofica degli ultimi mesi.
Un profeta (dal greco antico προφήτης, “colui che parla prima”) che annunciò il decadimento della cultura europea e la possibilità dell’andare oltre, anche se ancora oggi ‒ ahinoi ‒ questa prospettiva è ben lontana dagli obiettivi dei più (“οἱ πολλοί” esclamerebbe Eraclito!).
“La mia vita giunge ora al suo culmine: ancora un paio d’anni e la terra tremerà come per una folgore immane. ‒ Io ti giuro che ho la forza di cambiare il computo del tempo. Nulla di quello che esiste rimarrà in piedi, sono più dinamite che uomo.” ‒ (dalla lettera a Paul Desseun, “Lettere da Torino”, Adelphi)
È ormai tradizione di Oubliette Magazine celebrare il solstizio d’estate con una selezione di 21 libri, editi nell’anno corrente, consigliati dalla redazione e da alcuni stimati lettori di Oubliette Magazine.
Se avete il piacere di unirvi a noi per raccomandare un libro che ritenete valido, potete inserire il vostro consiglio a fine articolo nella sezione Commenti indicando il titolo, l’autore, la casa editrice e qualche riga di esplicazione.
Editoria 2025 ‒ 21 libri per l’estate
“Il giorno dell’ape” di Paul Murray
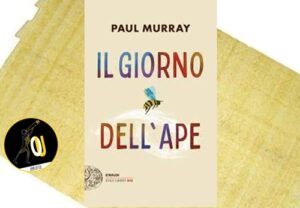
Il giorno dell’ape di Paul Murray (Einaudi, 2025), il romanzo che dall’inizio dell’anno, dopo aver ottenuto premi e riconoscimenti vari, continua a suscitare dibattiti a non finire, contiene a mio giudizio un non trascurabile errore: nel titolo. L’originale è The bee sting, “La puntura (o morso) dell’ape”.
Perché tradurre con Il giorno dell’ape? Non sembra avere molto senso, né maggiore consonanza con la storia che si racconta. Richiama peraltro, e inutilmente, titoli consimili, come Il giorno della civetta di Sciascia, Il giorno dello sciacallo di Forsythe, Il giorno della locusta di West. Sarebbe interessante sapere su chi ricade la responsabilità del titolo d’un’opera straniera; qui esiterei ad attribuirla al traduttore, lo scrittore Tommaso Pincio, peraltro bravissimo in questa difficile prova.
Probabilmente col titolo italiano si è voluto porre l’accento sul giorno delle nozze tra due dei quattro protagonisti, Dickie e Imelda, una sposa, costei, che proprio quel giorno arriva in chiesa trafelata col volto nascosto da un velo, perché punta da un’ape, dirà.
È una menzogna, una delle tante menzogne che puntellano e strutturano questo inquietante romanzo. E non è la prima, giacché quelle nozze spericolate altro non sono che il risultato di altre menzogne.
La menzogna, che assilla e inchioda ciascun personaggio, sembra imporsi come presupposto necessario per continuare a esistere all’interno di più vicende. Che non potrebbero procedere se la verità venisse affrontata. E qui il lettore viene esortato a riflettere su quante menzogne riguardino la propria stessa vita, su quante sia necessario talora covarne per mantenere equilibri, per non recare sofferenze, o per conservare un profilo cui è impossibile rinunciare al punto in cui la propria esistenza è approdata.
Murray ne Il giorno dell’ape, attraverso una tecnica magistrale, suddivide la tragedia affidando a ciascun protagonista la narrazione della parte che gli compete. Si ha così una quadripartizione dei punti di vista, ogni volta con cambi di tono e di respiro, ciascuno straordinariamente adeguato al carattere del personaggio che lo esprime.
E al quale di volta in volta si conforma la stessa scrittura. Può sorprendere la mancanza di punteggiatura in Imelda, che lascia in effetti perplessi, ma non concordo con chi parla di flusso di coscienza con richiami a Molly Bloom dell’Ulisse di Joyce. Né dirò la mia; qui lascerei libero ogni lettore di cogliervi il suo significato.
(Consigliato da Riccardo Garbetta)
“Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo” di Francesca Romana Recchia Luciani

Testo che si inserisce nel filone delle riflessioni sul ruolo delle donne nella cultura e nella società, Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo è un saggio della professoressa Francesca Romana Recchia Luciani, edito nel 2025 da Ponte alle grazie.
Saggio che si propone di riscoprire e valorizzare il contributo delle donne alla storia del pensiero filosofico, è organizzato in capitoli, ciascuno dedicato a una figura femminile. In una combinazione di elementi biografici, contesto storico e analisi delle idee di ciascuna, l’autrice ripercorre la loro vita e le loro opere, restituendo loro il posto che meritano nella storia della filosofia.
Attraverso le biografie e il pensiero delle dieci protagoniste citate, l’autrice evidenzia come il loro operato sia stato spesso oscurato o marginalizzato. Offrendo ai lettori, al contempo, una panoramica della storia della filosofia, ponendo l’accento sul fenomeno del femminismo e sulla parità di genere.
Donne tutte, dalle diverse peculiarità e distinte caratterialità, ma che hanno avuto in comune la voglia di ripensare il mondo attraverso la filosofia, sapere dei saperi. Con uno stile chiaro e accessibile, l’autrice collega filosofia, storia, letteratura e femminismo, in modo coinvolgente, in un equilibrio tra narrazione biografica e analisi filosofica.
Testo che si presta ad una lettura gradevole, seppur talvolta il contenuto non sia di immediata fruizione per un lettore non molto avvezzo alla questione filosofiche, mette in luce come le filosofe citate nel libro abbiano affrontato le sfide del loro tempo, lasciando un’impronta fondamentale nella storia del pensiero filosofico. Creando un quadro d’insieme ricco e articolato, che invita a ripensare la storia della filosofia e a interrogarsi sulle ragioni dell’esclusione delle donne da questa disciplina.
In conclusione Filosofe non è solo un libro di filosofia, ma un’opera che contribuisce al dibattito contemporaneo sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella cultura. Dimostrando come il pensiero filosofico delle donne abbia influenzato non solo la filosofia, ma anche la letteratura, la politica e la società.
(Consigliato da Carolina Colombi)
“Il grande Bob” di Georges Simenon
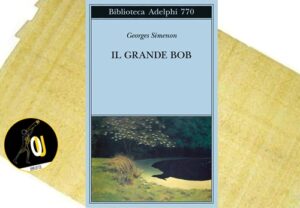
«‒ È lei, Charles? ‒ Non ho riconosciuto subito la voce, che pure mi è familiare. Senza aspettare la risposta, Lulu ha aggiunto: ‒ Bob è morto.»
Questa la telefonata che Charles Coindreau, medico e amico di famiglia dei Dandurand riceve alle dieci passate di mattina nel suo ambulatorio. Il dottore, che si attiva immediatamente per capire come sia morto il “Grande Bob”, come veniva affettuosamente chiamato Robert dagli amici, impara che questi era morto annegato a Tilly, mentre andava a pescare in un tratto della Senna in cui l’unico luogo significativo è il Beau Dimanche, una locanda bazzicata più che altro da pescatori e canoisti, soprattutto nei week end, nella quale da almeno quindici anni si recavano i Dandurand per divertirsi o rilassarsi, frequentemente in compagnia dei Coindreau.
Coindreau, tuttavia, trova strano che Bob avesse deciso di passare, da un giorno all’altro, dalla schiera dei dormiglioni a quella dei pescatori.
Ci vorrà poco per capire che si era trattato di suicidio, anche se, a Coindreau, come a tutti coloro che avevano conosciuto Bob, sembrava impossibile che uno come lui si fosse suicidato.
Bob era un frequentatore del Chez Justin un caffè, vicino a casa, dove si recava spesso a giocare a pelote con i suoi amici più cari, sempre allegro e disponibile con tutti. A Bob volevano tutti bene, a cominciare da sua moglie: Lulu, ancora una bella donna, la quale gestiva la sartoria dietro casa, dove abitavano, nei pressi di Montmartre. Bob era anche un forte bevitore, ma questo a Lulu non infastidiva, anzi, beveva spesso un bicchierino volentieri anche lei, perché l’aiutava a “tenersi su”.
A Lulu non interessava nemmeno che Bob avesse delle amanti (in genere ragazze facili, mercenarie) poiché erano storie che finivano subito. Tra queste c’era anche la giovane Adeline, aiutante nell’atelier, con la quale avrà a sua volta una fugace relazione lo stesso Coindreau. Nell’indagare, il medico scoprirà tanti risvolti inaspettati della vita di Bob, finanche sconvolgenti.
Bob, il protagonista di questo romanzo, è una persona che molti definirebbero un fallito, ma che, invece, Simenon, magistralmente, riesce a raccontare facendolo assurgere quasi a un mito.
“Il grande Bob” (Adelphi, ristampa 2025), a mio parere tra i più interessanti di Georges Simenon, dimostra ancora una volta quanto egli sia stato geniale, sempre capace di descrivere i risvolti psicologici dell’animo umano fin nei suoi più profondi recessi.
(Consigliato da Algo Ferrari)
“La parlate de ‘na vote a Nerito” di Anna M. Cortellini
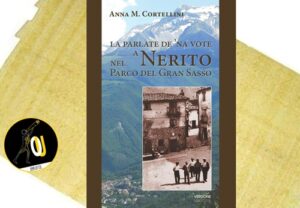
Il libro dal titolo: “La parlata de na vote a Nerito” di Anna M. Cortellini, edito da Verdone Editore nel 2025, nasce dopo una lunga gestazione e ‒ pagina dopo pagina ‒ consente al lettore di tornare indietro nel tempo, agli anni dell’infanzia in cui il linguaggio era spontaneo e carico di magnetismo e per questo, il recupero del dialetto come manifestazione dell’identità, non deve rappresentare solo un procedimento sulla conservazione della memoria e sulla ricerca storica ma fare in modo di restituire al futuro una lingua viva e vitale piena di significati con tutta la sua potenza narrativa.
I capitoli abbracciano molteplici tematiche a volte emozionanti, come nel caso delle poesie altre, descrivono pezzi di vita molto divertenti: “[…] ‘Ndonie Lunghe, l’asculane, va’nnenze a la Croce;/ cummanne, motte’n file e azz la voce:/ Cammenete apprisse a li Sande,/ San Paule arrete e San Pitre avande.” (da “La Precissione de San Pitre e Paule”, un episodio realmente accaduto).
Questo dizionario è un vero e proprio viaggio alla ricerca del tesoro linguistico del nostro dialetto. Dentro lo scrigno dei ricordi di Anna M. Cortellini ci sono 30 anni di trascrizione dei termini, all’inizio di tipo archivistico, successivamente ripresa con più vigore, dopo aver compreso di non avere più interlocutori parlanti a causa dello spopolamento del territorio e dal bisogno di preservare la sua lingua mediante un dizionario che testimoniasse una traccia della sua esistenza. A tal proposito, l’autrice, nel suo lungo e paziente lavoro di ricerca volto a salvare il patrimonio linguistico si racconta nell’introduzione: “[…] Mentre scrivevo mi accorgevo che le stesse parole trasudavano significati che andavano oltre il vocabolo, quasi un concerto in cui si fondevano ricordi, orizzonti, sensazioni, paure. Ero affascinata e annotavo tutto su una vecchia rubrica. […]”
Nel sommario, dopo l’introduzione di Anna M. Cortellini e la presentazione di Berardina Clemente, seguono: “Il fuoco di Natale di Nerito”, “La Precissione de San Pitre e Paule”, il “Dizionario”, “Il cantastorie dei soprannomi e casati” della generazione novecentesca di Nerito, “Detti e proverbi”, “Esercizi commerciali” fino agli anni ’60 circa, “Artigiani”, “Le vie del sudore”, “Il bosco di San Pietro”, “Fonetica e Grammatica”, un CD di 30 minuti in cui viene spiegata la pronuncia dialettale e le illustrazioni grafiche, realizzate da Martina Di Felice.
(Consigliato da Carina Spurio)
“Pasticche” di Chiara Fiorillo
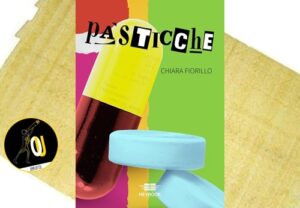
Se state cercando una lettura estiva che non sia un mattone da trascinare sotto l’ombrellone, ma qualcosa di più simile a una serie di assaggi intensi, allora “Pasticche” (HeyBook, 2025) di Chiara Fiorillo è la raccolta che fa per voi.
Trentatré racconti brevi, ciascuno un piccolo universo, scritto con uno stile che incanta, sorprende e – come promesso nella quarta di copertina – lascia un retrogusto duraturo. L’autrice, mai troppo invadente ma costantemente presente, gioca con le parole come con ingredienti da pasticceria: un pizzico di dolcezza, un filo d’amarezza, e lampi imprevedibili di ironia.
Non aspettatevi trame complesse o finali a effetto: qui la forza è tutta nell’atmosfera, nel dettaglio catturato, nella memoria riemersa come una conchiglia nella sabbia. Sono racconti da leggere in pochi minuti ma che, come certe conversazioni sulla spiaggia al tramonto, restano impressi.
C’è la delicatezza di Panni al vento, dove il ricordo di un’infanzia affollata si mescola alla nostalgia di una solitudine mai avuta, o Caleidoscopio, che cattura un momento casuale in treno e lo trasforma in un flashback di desiderio, malinconia e possibilità mancate.
C’è Teresa, donna concreta e un po’ epica, che lava le scale dal basso verso l’alto come se salisse una montagna tutta sua, e Collant anni ’80, con una protagonista teneramente impacciata, che corre dietro a un amore adolescenziale mai dichiarato, dentro un mondo fatto di fuseaux e autobus affollati.
Alcuni racconti colpiscono più per la loro ambientazione e crudezza, come Vicolo cieco, ambientato nella Rocinha di Rio, dove una piccola commissione diventa viaggio iniziatico tra povertà, amicizia e pericolo. O Il Pub, in cui l’attesa di un’amica in un locale fuori dal tempo diventa occasione per un bilancio di vita tra moquette scozzese e ricordi incisi nel legno.
Ogni racconto, quindi, è come una pasticca da sciogliere lentamente tra le dita o sotto la lingua dei pensieri. Perfetti per un’estate fatta di attese al gate, piedi nella sabbia, treni sonnolenti e sere lunghe. Non servono segnalibri: “Pasticche” si legge seguendo l’umore del giorno. E ogni giorno ce n’è una che calza a pennello.
(Consigliato da Cinzia Milite)
“Conferenze brasiliane” di Franco Basaglia
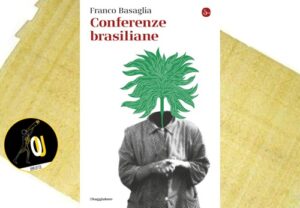
“Abbiamo dimostrato che l’impossibile diviene possibile…” ‒ Franco Basaglia, Rio de Janeiro, 28 giugno 1979
Perché è importante tornare a leggere e studiare l’opera di Franco Basaglia? Perché ancora non lo abbiamo fatto come avremmo dovuto, e perché è importante che le giovani generazioni possano attingere ad una dimensione etica della cura che affranchi la loro visione dal paradigma tecnicistico e stigmatizzante oggi nuovamente imperante. Il testo delle Conferenze brasiliane (Il Saggiatore, 2025) è utile allo scopo, fornendo al lettore la possibilità di esercitare il proprio saper essere nella cura attingendo ad una possibilità di cura che ha permesso all’Italia di essere modello nel mondo [OMS. 2003].
L’atteggiamento con cui Basaglia affronta il momento di impasse dopo la promulgazione della legge 180 si mostra innovativo già solo nel modo di articolare il confronto. Basaglia, anziché leggere una relazione, articola un confronto con i suoi interlocutori attraverso la pratica del domandare e del rispondere che ricorda la filosofia antica, procedendo senza far appello al sapere già noto e rimettendo ogni volta al centro la persona e il suo bisogno.
“Una cosa è considerare il problema una crisi e una cosa è considerarlo una diagnosi, perché la diagnosi è un oggetto mentre la crisi è una soggettività.” ‒ Franco Basaglia, San Paolo, 18 giugno 1979
L’aver cura torna ad essere sollecitudine ed esercizio di consapevolezza di sé, degli altri e del mondo [Socrate, Alcibiade, IV sec a.C.]: una pratica di virtù e di riappropriazione individuale, sociale e comunitaria. In questo modo di porsi Basaglia rappresenta il pioniere di una nuova visione, senz’altro unica nella sua epoca, che richiama a quella fenomenologia che è prima di tutto assunzione di un impegno nel ripensare il medesimo e far emergere i pregiudizi che guidano l’agire.
La cura diviene analisi del linguaggio, del costume e della storia; approfondimento delle strutture della pre-comprensione che articolano il sapere e, nondimeno, accoglienza e ascolto dell’altro, della sua storia, del suo ritmo e spazio vissuto, e possibilità di comprensione dei significati [Di Adamo, La grammatica del tempo e la vulnerabilità vissuta. Università di Firenze, in «Iride», 1-6 (2025)].
Nelle Conferenze traspare la cifra di Basaglia quale maestro del pensiero e pioniere di un modo di articolare il pensare e il dialogo che sa tenere insieme psichiatria, pedagogia, filosofia, antropologia e politica [Basaglia, Scritti 1953-1980, 2017], oggi importante per la costruzione di una nuova psicologia [Di Adamo, Della Cura, 2024].
(Consigliato da Loredana Di Adamo)
“Oltre il muro Gaza ‒ Beyond the Wall Gaza” di Beatrice Benet e Shadi AlQarra
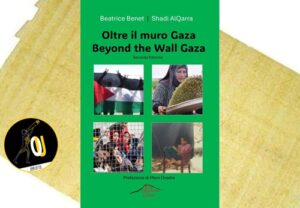
“Gaza è un’anima pura, è il battito del cuore di ogni essere libero. Ogni muro sarà demolito, un giorno, ma il silenzio è l’accettazione del male.”
“Oltre il muro Gaza” di Beatrice Benet e Shadi AlQarra (seconda edizione edito da Tomarchio Editore, 2025) è più di un libro. È un frammento, in quanto solo una minima parte di quello che sta accadendo in questo momento, ma anche uno specchio, un monitor che mette a confronto la nostra realtà di sentirci e di sentirci liberi a casa nostra mentre ci troviamo comodi seduti su una poltrona. Ne “Oltre il muro di Gaza”, tutto ciò che vi è narrato e testimoniato con le foto, avviene a poche ore di distanza da noi.
Il lettore riceve il primo input, la prima stimolazione che lo porterà a leggere pagina dopo pagina questo interessante testo, lo riceve nel primo versicolo della prefazione di Moni Ovadia.
“Oltre il muro Gaza” è un libro prezioso di immagini e di scritti che ci interrogano, ci chiamano alla nostra responsabilità di essere umani per non farci complici volontari o involontari di uno dei più atroci crimini del secolo scorso che perdura con feroce accanimento nel nostro secolo.
“Oltre il muro Gaza” è un’opera letteraria composta come un puzzle dove le tessere che lo compongono sono prodotte da occhi, sorrisi, storie di mamme e di figli che stanno vivendo un incubo. Tramite i loro sguardi, i loro racconti, ci rendono partecipi di quello che accade.
“Baba, lo sai che è il secondo anno che non vado a scuola? Quando finirà tutto questo? E come farò a rimettermi a pari con gli studi dopo tutti questi mesi?” […] (La bambina con il libro)
Beatrice Benet insieme al coautore fotografo palestinese Shadi AlQarra non ci presentano un volume che ha come scopo principale quello di fare un’analisi dei fatti ma bensì un invito a prendere coscienza della resistenza di questo popolo e di lasciare un messaggio per sensibilizzare le coscienze.
(Consigliato da Rosario Tomarchio)
“Il rito Juju e la tratta delle donne nigeriane” di Michela Ottobrelli

“Il rito Juju e la tratta delle donne nigeriane” è un saggio di Michela Ottobrelli edito da Gli Scrittori della porta accanto nel 2025. Le vediamo, anche se distogliamo lo sguardo. Sono vicine, nelle strade che percorriamo, anche se le percepiamo come “altro”. Sono le ragazze nigeriane che si prostituiscono sette giorni su sette, sotto la neve, la pioggia e il sole rovente. Hanno il cellulare, sono capaci di usare i social, ma sono condannate a anni di sfruttamento. Perché non chiedono aiuto? Perché non denunciano di essere state ingannate, spesso da parenti, con la promessa di un lavoro migliore? Perché non scappano e cercano di affrancarsi da una condizione di schiavitù?
Michela Ottobrelli nel “Il rito Juju e la tratta delle donne nigeriane” ci offre spiegazioni dettagliate frutto di un’accurata indagine storica della complessa situazione di un paese vasto e multietnico e di una puntuale indagine legislativa, statistica e antropologica. Un lavoro preciso e ben documentato, la cui importanza si evince anche dalla nutrita bibliografia e sitografia che conclude il testo.
Le ragazze nigeriane sono vincolate da un antico rituale, il Juju, appunto, connesso con l’antica magia ma anche con la criminalità, per cui, se vengono meno al giuramento e non pagano, con il loro lavoro, l’ingente debito con le Maman, saranno perseguitate dagli Spiriti.
Nei santuari dedicati alla dea Aleyaya, infatti, uno stregone celebra un rito potente, creando amuleti e utilizzando indumenti o parti del corpo della vittima, come capelli, denti, peli pubici, che vengono bolliti insieme a elementi simbolici, come metalli, terra, sangue di animali.
La ragazza, dopo aver mangiato il cuore di un gallo e aver giurato, è convinta che sarà protetta da malattie sessualmente trasmissibili e ne sarà preservata e potenziata la bellezza, ma sa anche che questo vincolo non lo può spezzare se non saldando il debito.
(Consigliato da Emma Fenu)
“Il corpo sbagliato” di Francesca Spanu
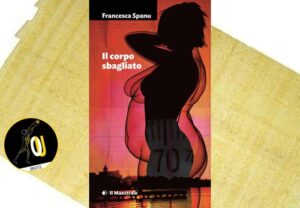
Forse non ero pronto per un libro che sa essere anche duro. O meglio il libro è morbido, accogliente come il salotto di casa, ma la storia è dura. È dura, e fa male, e fa commuovere, e fa scoraggiare, e fa sperare, e fa stringere il cuore da trascinarti via. È la storia di Cecilia, una giovane donna malata di obesità. È la storia di una donna bellissima dentro un corpo troppo appesantito che occulta la sua bellezza. Ma poi il corpo cambia repentinamente, nel tempo di un’operazione chirurgica e della riabilitazione, ma il sospirato normopeso diventa un calvario tutto da scalare.
Il libro è Il corpo sbagliato (Edizioni Il Maestrale 2025) di Francesca Spanu. È una storia vera? È un romanzo di formazione? È il racconto di un amore tossico? No, via dalle etichette, via dalle definizioni preconfezionate. Il libro è tutto questo, e molto altro, e va scoperto inoltrandosi nella lettura, come inoltrarsi in un bosco oscuro, che forse ci si perde, o forse si conquista la luce e la coscienza. Viaggio verso sé stessi, perché trovare quella bellezza esteriore che è accettazione da parte degli altri potrebbe essere dopante. Sembra che quando l’aspetto combaci con il sogno, l’anima vada sotto anfetamine. Peggio ancora se ciò che manda in fibrillazione è un amore tossico.
Ma le cose possono ancora cambiare, non diciamo come per non svelare troppo, ma il percorso del romanzo cattura attenzione e sensazioni, e ti tiene con il fiato sospeso quasi come un giallo, fino all’ultima pagina.
Ma allora è un giallo? Ritornano le domande sulle etichette. Forse, perché in un cero senso Francesca Spanu uccide la Cecilia obesa, e poi il colpevole è difficile da trovare.
L’unico genere letterario che l’autrice dichiara è: “Storia vera”, autentica, ma romanzata. E il resto è musica; musica di un’alta cifra di scrittura, giustamente densa, che ci fa entrare dentro le emozioni sempre forti della protagonista, e nel covo delle sue debolezze. Si soffre con lei, e il fraseggio delle sue sensazioni è sempre pieno, mai rigonfio.
E poi entriamo nelle atmosfere dei luoghi… Ecco, è lì il segreto: non entriamo nei luoghi ma nelle atmosfere dei paesaggi marini, della luce di Cagliari, degli interni notte, o dei momenti di passione raccontati in piano sequenza con poche, sapienti, pennellate.
(Consigliato da Pier Bruno Cosso)
“Ermione” di Valentina Ferrari
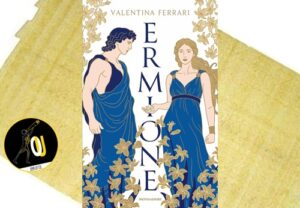
“Ermione” è un romanzo dal soggetto mitologico di Valentina Ferrari ed è edito per Mondadori (2025). È difficile non notare che i retelling, termine che si inizia a odiare, stanno davvero saturando il mercato.
Ne abbiamo letti molti. I primi usciti erano di una meraviglia assoluta, o almeno lo erano alcuni, mentre gli altri erano idee molto interessanti o deliziosi supporti per chi si avvicina alle storie della mitologia.
“Ermione” è arrivato in una polla ormai stanca di sentir parlare delle mura di Ilio. Stanca come lo erano i soldati dentro e fuori le mura, esausta come lo erano le rive dello Scamandro.
Con il libro in mano ero preparata ad un approccio senza passione e invece… La prosa di questo libro è evocativa, poetica e regge i sentimenti della protagonista. Ermione è la figlia di Elena. La figlia che ha abbandonato quando è fuggita da Menelao per seguire Paride. Una prole che vive nell’ombra di una madre che sembra risucchiare tutta l’aria che si respira in una stanza anche quando non è presente. Elena le ha regalato la bellezza ma non la forza accentratrice.
Questo è quello che crede Ermione ma non quello che le dicono le persone a lei più vicine, difatti sarà il cruccio di una Clitennestra già avviata sulla via della vendetta.
Come detto prima la prosa di questa biografia è lo specchio dello sforzo bulimico di attrarre a sé una madre che continua a sfuggire pur essendo in ogni ombra della vita di Ermione. È fedele alla storia del mito? Beh, fino a questo momento eravamo tutti voltati a guardare Ilio, la guerra, gli eroi, la disfatta, la tragedia e la tracotanza della bellezza distruttiva di Elena. Nessuno si ricordava di Ermione, fino ad ora.
“L’amore era l’insidia del dubbio e la pena della disillusione. L’amore era un’arma, che sceglievamo di usare contro gli altri o contro di noi. L’amore era non averne abbastanza, non darne abbastanza”. L’amore era un disequilibrio complesso e segnava il nostro punto di rottura.”
(Consigliato da Altea Gardini)
“Primmammore” di Titti Marrone
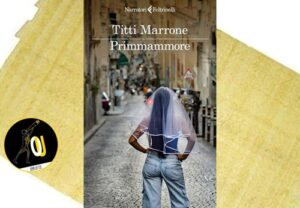
Da Truman Capote a Michelle Mc Namare fino a Emmanuel Carrère, il true crime e la sua declinazione, il reportage di cruenti fatti di cronaca, è da tempo diventato uno dei territori narrativi più interessanti da esplorare.
Traendo spunto da un terribile episodio avvenuto a Caivano il 24 giugno 2014, in “Primmammore”, Feltrinelli editore (2025), Titti Marrone racconta una storia di abusi e miseria che però trascende la cronaca per affrontare questioni annose e irrisolte come la sottomissione delle donne all’uomo all’interno di famiglie costrette a vivere in contesti di degrado morale prima ancora che urbano.
La tragica vicenda di Nina, una bambina di sei anni “affettuosa e desiderosa di coccole e abbracci come tutti i bambini che ora non vuole più essere toccata”, caduta dall’ottavo piano di una casa popolare sentina di traffici illeciti, un buco nero che fa risuonare la vena inferiore di sangue cattivo di personaggi segnati da una biografia dispari, e la conseguente indagine giornalistica condotta da Costanza, maestra di prima elementare della vittima, in collaborazione col figlio giornalista e con i carabinieri, è lo spunto per descrivere una sorta di mondo di sotto, dove l’omertà è il lubrificante che facilita l’eterno scorrimento di leggi contro natura e criminose in una città, Napoli, mutata radicalmente dopo il terremoto dell’Ottanta (“Quelle scosse avevano prodotto un sommovimento mai conosciuto prima, scagliando la città in fondo a un precipizio di affanni”) a causa della corruzione dilagante prodotta dal sodalizio tra funzionari statali e imprenditori legati alla camorra, insozzando la disperazione dei sopravvissuti rimasti senza casa con la bava dell’ingordigia di chi riuscì ad appropriarsi del denaro pubblico.
(Consigliato da Maurizio Fierro)
“Mariano Di Gesù al Princess Hotel” di Giuseppe Sorgi

Una inconoscibile ratio si nasconde dietro ogni azione; silenziosa, muove i fili dell’esistenza umana. Lo chiamiamo Caso, Destino o Provvidenza; quale ne sia il nome, questo Grande Burattinaio ci spinge verso ciò che deve essere. Metti due perfetti sconosciuti; si incrociano appena, scambiano qualche parola di cortesia. Potrebbe finire lì; se invece il Caso – o Destino o Provvidenza – ci mette lo zampino, quell’incontro è il preludio di un’avventura ad alto tasso adrenalinico. Giuseppe Sorgi autore, regista e attore teatrale, si diverte a vestire i panni del Grande Burattinaio; nel suo primo romanzo, Mariano Di Gesù al Princess Hotel (Salani Editore, 2025, pp. 252), due detective improvvisati risolvono un caso intricato.
Jole deve accompagnare i genitori a Edimburgo, per festeggiare le loro nozze d’oro; uno strazio, più che una vacanza. La madre ha un carattere complicato; il padre è succube della moglie. Si annuncia un soggiorno difficile; niente in confronto agli imprevisti che Jole affronterà. In poche ore, al Princess Hotel avvengono tre decessi. Possibile che si tratti di una fatale coincidenza? Non spetta certo alla donna indagare; ma un altro ospite italiano dell’albergo si è messo in testa di risolvere il mistero. Mariano Di Gesù, professore in pensione esuberante e ficcanaso, la coinvolge nella sua ricerca; la trascinerà in una serie di guai e situazioni surreali.
Mariano Di Gesù al Princess Hotel è una lettura perfetta per le vacanze; avvincente come un poliziesco, il plot è vivacizzato dalla vis ironica. Ma non finisce qui; il tono scanzonato sa assumere un accento intimista. Mariano è un fine psicologo; osserva, ascolta. Gli basta poco per arrivare all’anima delle persone; per tirarne fuori l’oscuro grumo irrisolto. Un’antica parola è il suo motto; Maieutica.
“È così difficile emanciparsi da se stessi […]. Maieutica, insegnava Socrate. Purtroppo non la insegna più nessuno, questo è tempo di cloni e per giunta cafoni. E comunque Socrate finì condannato a morte.”
È amara la visione di Mariano; nell’attuale panorama umano, troppi scorci desolanti. Una specie sciocca, la nostra; distruttiva e infestante. Alienus; estraneo. Come gli abitanti di altri mondi; come tanti abitanti di questo mondo.
La parola d’ordine è più che mai preziosa. Mariano docet: Maieutica!
(Consigliato da Tiziana Topa)
“L’inquietudine di un destino” di Filippo Casati

“«Diventare ciò che si è» significa portare allo scoperto, nel duplice senso dello svelare e del realizzare, la nostra necessità; significa trasmutare, mediante una sorta di procedimento alchemico, il puro fatto contingente del nostro esistere in destino, la bruta fattualità del passato in ciò che ha da ripetersi, in un «così volli che fosse, così voglio, così vorrò».” ‒ dall’introduzione de “L’inquietudine di un destino”
“L’inquietudine di un destino”, edito nel 2025 nella collana editoriale Il corpo della filosofia diretta da Rossella Fabbrichesi e Cristina Zaltieri per la casa editrice mantovana Negretto Editore, è un saggio di Filippo Casati che esamina la vocazione pedagogica ‒ una vera e propria nuova Bildung (formazione) ‒ che interessò, sin dagli esordi giovanili, il filologo, poeta e filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (1844 ‒ 1900).
“L’inquietudine di un destino” principia con la Prefazione di Cristina Zaltieri intitolata La Bildung come metamorfosi del mondo nell’uomo; segue l’Introduzione Come si diventa ciò che si è curata dall’autore; il Prologo suddiviso in Come si partorisce un centauro: critica della cultura e formazione dell’uomo negli scritti del periodo basileese e L’uomo in frantumi; la Parte Prima Uno sguardo nell’abisso: identità e genesi dell’umano; la Parte Seconda La sete dell’anello: il problema della Bildung fra natura e cultura; l’Epilogo suddiviso in Incorporare l’immane e Tramonto; una sezione dedicata alle opere di Friedrich Nietzsche; una corposa Bibliografia ed i Ringraziamenti finali. L’immagine di copertina è un acquerello di Giovanni Galafassi.
Filippo Casati, docente di filosofia e storia e nei licei, si occupa di attività di divulgazione culturale, ha precedentemente pubblicato lo studio Dall’individualità dispersa al grande tipo. Problema della decadenza e costruzione del Sé nel pensiero di Friedrich Nietzsche nella rivista online di filosofia Nóema. Con “L’inquietudine di un destino” si pone la questione della temporalità e della storicità della Bildung nella costruzione dell’individualità per l’impresa di ridiventare classici nell’epoca della tecnica. Il tema è sia ciclico sia attuale, infatti, in ogni secolo la ripresa del classico ‒ del mito e della filosofia della Grecia antica ‒ ha prodotto nuovi maestri e nuovi discepoli con lo scopo di un’assimilazione con le abilità tecniche dell’essere umano.
(Consigliato da Silvano Negretto)
“Le querce non fanno limoni” di Chiara Francini
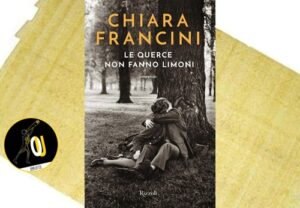
Chiara Francini attrice, conduttrice televisiva e scrittrice, ne “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli, 2025) racconta 50 anni di storia italiana compresi tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo in un romanzo epico, ma nello stesso tempo intimo e corale perché narra le vicende di molti personaggi presentati ognuno come fosse il protagonista, con cura e completezza tali da renderlo reale e indispensabile: “… Davanti alla panca lucida, ritto, c’è lui: Gigione, un omone dal naso di patata lessa ammaccata e la bocca aperta ma orba di fiato. Penseresti a un ictus, non fosse per due rigagnoli salati e vivi che gli ruzzolano giù per le gote…”
È una storia di passioni, di Resistenza, di lotte difficili, di quelle che lasciano cicatrici profonde, che possono sfasciare le famiglie o riunirle, ma sono quelle storie che, se le vivi, ti danno la forza di stare in piedi.
La protagonista indiscussa è Delia, ex partigiana, una donna in grado di affrontare la guerra, le perdite, l’amore costruendo il suo luogo ideale che diventa anche simbolico, un rifugio, uno spazio da condividere, un luogo dove non si perdano la speranza e la memoria: il Cantuccio.
La storia si svolge fra Firenze e Campi Bisenzio e al Cantuccio passano, intorno a Delia, tutti gli altri personaggi da Gigione a Irma, Mauro, Angela Carlo, Sandro, Lettèria e altri ancora che intrecciano con Delia le loro storie in una narrazione dove ogni pagina è intrisa di una lingua che alterna lirismo e parlato popolare rendendola una lingua viva capace di parlare, cantare, piangere, raccontare.
Ed è in questo modo che vengono raccontate l’infanzia vissuta in una famiglia patriarcale, le torture di Villa Triste, la Liberazione, per arrivare alla strage di piazza Fontana e tutto questo filtrato attraverso i gesti quotidiani, i silenzi con le troppe parole non dette, le pentole sul fuoco, l’avvicendarsi delle persone al Cantuccio.
È sicuramente un romanzo sull’eredità politica, affettiva ed anche ideologica, sulla memoria e soprattutto sul coraggio di guardare il passato per comprenderlo, per non farsi dolo travolgere dagli eventi, per trovare la forza e i motivi per andare avanti. Ma se lo si legge con attenzione, questo romanzo è ancora più profondo perché si interroga sull’esistenza, sul significato della parola resistere: alle ingiustizie, al dolore, alle delusioni, alla perdita dell’innocenza, al tempo che passa con la consapevolezza che solo combattendo si potrà avere una vita degna di essere vissuta.
(Consigliato da Beatrice Benet)
“Le vie del vento” di Fabio Soricone

Ho letto con molto interesse la silloge “Le vie del vento” (Tomarchio Editore, 2025) incuriosito dalle liriche che il poeta ha postato in vari contest Oubliette Magazine a cui ho avuto il piacere e l’onore di far parte della giuria. I versi di Fabio Soricone in questo libro sono una singolare mescolanza di passione e pensiero, di sentimento e razionalità, in cui l’erudizione e il concettismo non sono freddi artifici, ma complessi modi per esprimere le emozioni. Le metafore, tipiche della tradizione cristiana, espresse in modo non dogmatico, risplendono ugualmente e colpiscono per la loro profondità. Soricone non è panteista, Dio non viene assimilato al mondo, che ha creato dal nulla e al nulla ritornerà, con cicli ricorrenti di emanazione e riassorbimento, secondo quanto afferma anche la fisica moderna riguardo alla materia, il distacco dal contingente in “Le vie del vento” è continuo, eppure l’amore per la natura è fortissimo, l’amore e l’annullamento di sé nell’amata sono le condizioni dell’unione mistica.
“Ti predai un bacio/ ammaliato dalla tua logica/ incavata dolcemente negli occhi/ innamorato perdutamente/ di quei lineamenti/ che sortiscono leggere crespature/ nel silenzio del mio cuore” (“Saudade”)
Il poeta rappresenta l’incarnazione di Dio, tutto esiste per il presente, e subito scompare qui, ma è conservato nei piani alti dell’essere, nulla si perde: “[…] di fronte al massacro/ e più sono azzurri più disimparo a volare/ come se l’orizzonte della vita/ mi cingesse la gola/ e se un giorno volessi sapere quanti angeli/ finora abbiam perso/ guarda il cielo e conta le stelle/ oppure osserva il sole che nutre la terra/ e il numero dei suoi raggi/ contempla questo firmamento e l’architrave/ che sostiene il paradiso” (“Sacrificio degli angeli”)
L’artista descrive l’evoluzione fisica e soprattutto dell’anima, della coscienza, dunque tutto è animato nel cosmo; esiste un prima e un dopo per ogni uomo, prima di esistere come essere umano: “Tu,/ che mescoli vocalizzi di mare aperto/ al tepore dei canti nascosti,/ veglia sul fiore della nostra vita,/ ché l’estate è terminata/ e in un prolungamento di ombre/ sì ascondono i tuoi fiati./ Presto intorno a noi/ l’arancio del sole tramonterà sulle foglie/ dell’autunno./ È tempo di accogliere il pane sacramentato/ dei nostri baci./ Di toccarti la fronte come segno di salvezza.” (“Autunno”)
(Consigliato da Franco Carta)
“Eva e Barbablù” di Emma Fenu e Pier Bruno Cosso

Nella tradizione della fiaba classica, costruita in modo scarno, sappiamo che Barbablù ad un certo deve allontanarsi da casa: lascia le chiavi alla moglie dicendole che può invitare chi vuole e stare insieme a loro in qualsiasi stanza, tranne in una. Proprio per questo, curiosa, la donna infrangerà tale divieto. Le conseguenze sono note. Al ritorno lui si accorge che lei ha trasgredito, per via di una chiave insanguinata, e minaccia di ucciderla, lei però, temporeggiando, riesce a salvarsi invocando l’aiuto dei fratelli.
Nella versione di Emma Fenu e Pier Bruno Cosso intitolata “Eva e Barbablù” (Gli scrittori della porta accanto, 2025), gli oggetti con cui Barbablù teme e ricatta la sua sposa sono la mela, la porta e le chiavi: “Non tentarmi, Eva/ Non mangiare la mela./ Non aprire quella porta”. Non è un caso, secondo me, che queste parole, contenute all’interno dell’atto quinto, siano scritte in forma poetica al fine quindi di conferire loro maggiore enfasi.
La pièce si divide in otto atti anticipati da una prefazione e chiusi da una postfazione, entrambe a cura di Veronica Sicari, avvocata, scrittrice e operatrice nonché vicepresidente del Centro antiviolenza di Catania.
La prefazione parte dalla storia raccontata per spaziare a tutto tondo sul tema della violenza maschile sulle donne, vista come un fenomeno che, in quanto caratterizzato da una “matrice… culturale” necessita di un “percorso di prevenzione e mutamento della società”.
A corredo delle battute dei dialoghi tra i due protagonisti, ci sono le illustrazioni realizzate da Camilla Lilliu: esse sono in bianco e nero e sono poste prima di ogni atto, prima della premessa anteposta a quest’ultimo, costituendone così un’anticipazione non solo verbale (come la premessa) ma anche iconica molto forte anche per la sua semplicità, essendo costituita da disegni in bianco e nero.
(Consigliato da Filomena Gagliardi)
“Incontri ravvicinati tra le due culture” di Piergiorgio Odifreddi
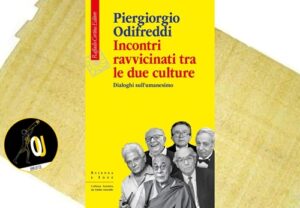
Incontri ravvicinati tra le due culture (Raffaello Cortina Editore, 2025) di Piergiorgio Odifreddi è una silloge di interviste fatte a personaggi di estrazione: “… scientifica e umanistica, per mostrarne la sostanziale unità dietro l’apparente separazione….” – così recita la nota presente nella quarta di copertina. L’autore afferma trattarsi di “un racconto, o un resoconto, di incontri con persone che vale la pena di incontrare e ascoltare, e che hanno reso la mia vita più piena e degna di essere vissuta.” – per cui, sempre in quell’epica targa posteriore del saggio s’accenna al senso racchiuso in Vivere per raccontarla di Gabriel Garcia Marquez – opera che ingurgitai nel 2004. Gabriel! Non avrei voluto intervistarti, ma parlarti a lungo sì, sparando, com’è d’uso fra due vecchi amici, una sciocchezza da bar dopo l’altra…
Dopo l’introduzione Incontrarli per ascoltarli, la regola adottata dall’autore è la seguente. Un titolo, tutto in maiuscolo, tipo il primo, che è: Il Divo Giulio, con, piazzato sotto in corsivo, nome e cognome dell’intervistato. A cui segue un sapido copricapo iniziale, in cui è descritto il soggetto, che a volte è ben noto alle masse, a volte per nulla, però rinomato nel suo campo; e le modalità e le ragioni dell’incontro. Segue poi una girandola di domande, compresa la prima, che pare sempre casuale e che è senz’altro stata a lungo meditata dal signor PierG, che è un tipo che sa organizzarsi! O, come dire, è strategica, tipo apertura iniziale negli scacchi. S’assiste poi a una sorta d’incontro di bigliardino fra PierG e l’intervistato. Lo scopo non è vincere la gara, semmai favorire i gol d’entrambi i contendenti. Il confronto, che non rischia mai di diventare conflitto, è strategico… e inoculato al lettore, che ogni volta si pone un quesito banale e irrisolvibile: trattasi almeno un po’ di fiction progettata a tavolino? Intendendo: l’attacco, la difesa, il contrattacco, la rimessa in gioco, la conclusione (che sempre pare come sospesa). Quando la palla svolazza fuori dall’assito, uno dei due concorrenti la va a raccogliere dal pavimento e la rigetta in campo. L’incontro si conclude all’improvviso, essendo scaduto il tempo.
Indico la trama del volume: sette sezioni: Politica, Religione, Arte, Scacchi, Letteratura, Filosofia, Scienza, ognuna con 12 interviste, a parte la 4ª, che ne ha 4. Segue l’Indice dei nomi e l’elenco degli Ultimi volumi pubblicati. Scanserò il primo ma divorerò il secondo!
(Consigliato da Stefano Pioli)
“Lanterne in volo” di Alec Ash
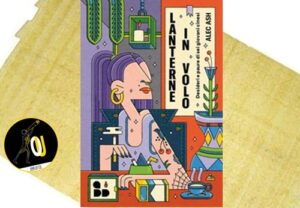
Alec Ash con “Lanterne in volo”, edito Add (ristampa 2025), dona ai lettori una narrazione, un reportage nel contesto storico a cavallo tra gli anni Ottanta novanta (più precisamente dal 1985 al 1995) con protagonisti sei giovani cinesi, che inseguono i loro sogni, una fase storica sociale che ingloba tutto e tutti in un vortice che causa mutamenti drastici, anche traumatici. Il titolo lanterne cinese riporta alla mente quella simbologia di un gesto di porta fortuna, lanciare in volo le lanterne dona a chi le lascia andare in volo e ai suoi cari energia positiva, lasciando andare ciò che è passato per aprirsi a un nuovo inizio, al cambiamento. Proprio come i giovani del tempo che abbandonavano le desolate campagne per ricostruirsi un futuro nelle grandi città, cominciando un percorso di studi o lavorativo.
Ricordi ben custoditi di una giovinezza che abbraccia le emozioni più svariate, in una realtà dove prevale l’autorità pressante dei genitori, il senso del dovere nell’impegnarsi nella ricerca di un lavoro sicuro e nel dover formare una famiglia entro una certa età in un continuo confronto con una realtà occidentale dagli scenari più allettanti, con una concreta forma di libertà e indipendenza che si possa manifestare in scelte e fatti. I sei giovani protagonisti sono alla ricerca del proprio futuro e vagano come trasportati dal vento proprio come le lanterne cinesi, con la speranza di liberarsi di un incombente passato per un presente migliore.
Alec Ash in un abile alternanza narrativa intreccia le storie dei protagonisti in modo frammentario e quasi casuale, portando il lettore a tuffarsi nelle loro vite in modo sussultorio, divenendo così protagonista di questa sceneggiatura che fa vivere una realtà orientale storica ben definita. Si aggrovigliano così le loro passioni, paure, conflitti, speranze sempre poste in contraddizione alle sfaccettature della società cinese, in un opposto di estrema ricchezza ed estrema povertà, in uno scenario politico che fa intuire una manipolazione anche dei movimenti studenteschi. Giovani generazioni apolitiche perché non trovano giustificazioni al fatto che un padre potesse lavorare per lo tesso partito che precedentemente aveva aggredito il nonno a sassate. Una generazione devastata dalle contraddizioni di una società che tutto travolge, nel bene e nel male, e che oltre la possibilità di intravedere un futuro migliore, non dà certezza del viaggio delle stesse lanterne.
(Consigliato da Simona Trunzo)
“Le cose che ci salvano” di Lorenza Gentile

Ho letto con grande piacere e un pizzico di emozione il libro “Le cose che ci salvano” di Lorenza Gentile (quarta edizione marzo 2025 ed. Feltrinelli). L’autrice ci regala una narrazione delicata e profonda, ambientata nei pressi dei suggestivi Navigli di Milano.
La protagonista, Gea, è una giovane donna di ventisette anni che vive una vita semplice e ritirata, limitando i suoi spostamenti al quartiere in cui abita. La sua esistenza è scandita da un’economia circolare personale: ripara oggetti destinati al macero e li redistribuisce, accompagnandoli con poesie, origami e citazioni, offrendo così piccoli momenti di bellezza e riflessione a chi li riceve.
La sua figura di Gea è al tempo stesso poetica e politica: è un’eroina della quotidianità che, scegliendo di vivere con poco, fuori dalle logiche del consumo, cerca di salvare ciò che gli altri scartano, sia oggetti che relazioni.
La metafora dell’“aggiustare” si estende dalla pratica manuale al tentativo simbolico di riparare i legami umani, il tessuto sociale, se stessa.
“La manutenzione è affetto per il mondo. È non dare niente per scontato. È spingere la morte un po’ più in là. Non bisogna mai smettere di amare le cose, se vogliamo che sopravvivano.”
Gea è circondata da una comunità eterogenea: un’anziana pseudo-portinaia, un pensionato silenzioso, una donna energica che gestisce una tavola calda e un adolescente con il sogno di diventare autista. Questi personaggi, sebbene diversi tra loro, rappresentano un microcosmo affettivo che sostiene Gea nella sua quotidianità.
Tuttavia, la giovane si sente spesso fuori posto, forse a causa di un’infanzia segnata da un padre ossessionato dalle catastrofi, che l’ha cresciuta preparandola al peggio.
In conclusione “Le cose che ci salvano” è un romanzo che celebra la resilienza, l’importanza dei legami umani e la bellezza delle piccole cose. Attraverso la storia di Gea, l’autrice ci invita a riflettere su come, salvando ciò che amiamo, possiamo a nostra volta essere salvati.
(Consigliato da Giovanna Fracassi)
“Fit una die de ‘eranu” di Vanna Sanciu
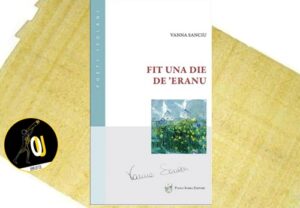
“Fit una die de ‘eranu” (Era un giorno di primavera) è il titolo della silloge poetica di Vanna Sanciu edita da Paolo Sorba Editore nel 2025. Le poesie sono scritte in lingua sarda con la traduzione in italiano. In questa raccolta la vita incontra la poesia: l’amore, il dolore, la felicità, la tristezza, scritte con la forma consueta della poesia sarda. Sa limba de su coro (la lingua del cuore) della poetessa. La sua poesia nasce infatti dalle radici della sardità che tiene ben stretta nel cuore.
È con la poesia che la poetessa risorge e ritorna a sperare e superare il dolore per la morte del fratello.
Abbraccia la stessa poesia dedicandole dei versi in “Poesia Amiga”. Scrive: “Compagna dai percorsi tormentati, vicino al Signore si trova la tua casa, tu canti l’amore per gli innamorati, con discrezione stendi veli di pietà”.
Nei suoi versi trionfa sempre l’amore nei suoi diversi significati: l’amore materno, quello filiale, l’amore quello misterioso. “Hai rapito il mio cuore e lo hai legato con un filo invisibile.”
Canta l’amore per il suo paese, per la sua terra, “Terra dipinta con una lingua preziosa nel tepore del focolare di cui eravamo padroni, ora mi rubano il latte materno, il futuro troverà la mia casa spoglia“.
Per la Sanciu la poesia è un mezzo per esplorare tematiche sociali, denunciando ingiustizie e oppressioni.
“Da una grata voleranno le nostre parole mute/ sulle ali della giustizia e dell’amore.” E ancora scrive: “Valori che non si possono comprare innaffiato nella primavera della vita con parole pronunciate come un pianto, ma non è stato vano: sono libera senza catene”.
Le poesie della Sanciu si trasformano in vene. E come nelle vene, anche nelle poesie scorrono lacrime ed emozioni. Te le senti arrivare addosso, e sono sempre più persuasa che con la poesia ha fatto l’incontro giusto.
Vanna Sanciu, è nata a Buddusò nel 1956, risiede a Olbia dal 1968. Ha esercitato la professione di insegnante di Scuola Primaria dove ha inoltre realizzato laboratori teatrali e poetici in Lingua sarda con i propri alunni. Dal 2015 fa parte del team di autori scelti di “OLBIAchefu”, rubrica culturale della testata giornalistica Olbia.it-Quotidiano Online. Scrive poesie e brevi racconti in italiano e in limba, variante logudorese. Ha partecipato ad alcuni Concorsi letterari dell’isola, riscuotendo importanti riconoscimenti.
(Consigliato da Giuseppina Carta)
“Versi di Sardegna – Quarta edizione” di AA.VV.
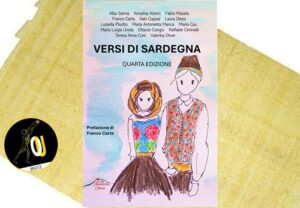
“Sandaliotis est appellata et Ichnussa, quod utrumque vestigii formam significat.” ‒ Marziano Capella, V secolo d.C.
Quando i primi navigatori costeggiarono l’isola di Sardegna ne scorsero la forma di un’orma. Il dibattito fra gli intellettuali, iniziato alle origini ed ancora vivo ai nostri giorni, su quale fosse il termine più antico ‒ tra Ichnussa e Sandàlion ‒ non ne muta il significato ed, anzi, ne conferma la struttura.
Così, con il progetto antologico “Versi di Sardegna”, si vuole mostrare un’orma tracciata in versi per dare ai lettori la possibilità di navigare nell’attuale panorama letterario presente sull’isola.
Giunto al quarto ciclo di presentazione dei poeti e delle poetesse della Sardegna, l’antologia “Versi di Sardegna ‒ Quarta Edizione” è stata pubblicata a giugno del 2025 dalla casa editrice Tomarchio Editore.
La quarta edizione dell’antologia vede al suo interno quattrodici voci ed altrettante raccolte così intitolate: Madre terra mia di Alba Sanna; La contadina scalza di Annalisa Atzeni; Maestrale di Fabio Masala; Sa bòghe nóstra di Franco Carta; Parentes e amigos de ammentare di Italo Cappai; Su ali d’ape di Laura Dessì; Visione di Luisella Pisottu; Un canto nell’aria di Maria Antonietta Manca; Dialogo con il tempo di Maria Cau; Voci di terra e vento di Maria Luigia Unida; Arretumbu ‘e tronu di Ottavio Congiu; Un abbraccio di sole di Raffaele Ciminelli; Il miracolo della bellezza di Teresa Anna Coni e Profumo ancestrale di Valerika Oliver.
“La Sardegna, terra di antiche tradizioni e straordinarie bellezze naturali, si distingue per la sua ricca produzione poetica. La poesia sarda, riflettendo le peculiarità linguistiche, culturali e sociali dell’isola, rappresenta un patrimonio inestimabile.” ‒ dalla prefazione di Franco Carta
La copertina raffigurante una coppia in abiti tradizionali è una illustrazione di Simona Trunzo. Oltre alle raccolte di poesie è presente uno speciale omaggio a Giacomo Leopardi ad opera di Franco Carta con la traduzione in sardo delle due liriche: “L’infinito” ed “Il passero solitario”. Presenti in antologia due special guest: Marco Leonardi ed AL III (Aldo Turnu).
(Consigliato da Alessia Mocci)
***
“Fa una scelta di buoni autori e contentati di essi per nutrirti del loro genio se vuoi ricavarne insegnamenti che ti rimangano. Voler essere dappertutto e come essere in nessun luogo. Non potendo quindi leggere tutti i libri che puoi avere, contentati di avere quelli che puoi leggere.”
Lucio Anneo Seneca ‒ “Lettere morali a Lucilio”
“Datta, dayadhvam, damyata/ Shantih shantih shantih” [Dai, compatisci, domina/ Pace]
Thomas Stearns Eliot ‒ “The Waste Land”
Info
Editoria 2024: 21 libri per l’inverno
Editoria 2024: 21 libri per l’estate
Editoria 2023: 21 libri per l’inverno
Editoria 2023: 21 libri per l’estate
Editoria 2022: 21 libri per l’inverno
Editoria 2022: 21 libri per l’estate
Editoria 2021: 21 libri per l’inverno
Editoria 2021: 21 libri per l’estate
Editoria 2020: 21 libri per l’inverno
Editoria 2020: 21 libri per l’estate
Editoria 2019: 21 libri per l’inverno
Editoria 2019: 21 libri per l’estate
Editoria 2018: 21 libri consigliati dell’anno



