“Anima Mundi” di Marsilio Ficino #15: Il mondo delle immagini
“Vedendo che tutti gli enti superiori provano piacere per ciò che vi è di simile a loro nelle realtà inferiori, e desiderando così colmarli con quanto è bene, secondo le loro forze, attraverso l’imitazione, essi offrono, per quanto possibile, un modo di agire conveniente agli enti superiori, introducendo occulti misteri nei simboli manifesti.” ‒ Marsilio Ficino
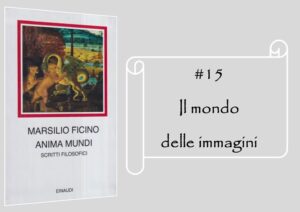
Quindicesima puntata della rubrica “Anima Mundi” che presenta il secondo capitolo della Parte Quarta Il tempo della magia suddivisa in Anima Mundi; Il mondo delle immagini; Sui demoni; Fatalia; Medicina del corpo, medicina dell’anima.
Il mondo delle immagini, secondo capitolo de Il tempo della magia, è a sua volta suddiviso in quattro sezioni: De vita, Parafrasi del «De mysteriis» di Giamblico, Commento alle «Enneadi» di Plotino ed un secondo De vita.
Nel 1486 Marsilio Ficino iniziò la stesura del commento alle “Enneadi”, subito dopo aver terminato la traduzione dell’opera. Fu sotto sollecitazioni di Giovanni Pico della Mirandola che Ficino si interessò di questo importante lavoro, dopo aver commentato la seconda Enneade, però, mise da parte il progetto per dedicarsi alla traduzione de “De Mysteriis” di Giamblico, “De sacrificio et magia” di Proclo, de “De somniis” di Sinesio ed altre opere di altri filosofi della scuola platonica.
La rubrica Anima Mundi propone al lettore una selezione di brani come invito ad intraprendere la conoscenza di Marsilio Ficino, il “nuovo” Orfeo che, a differenza del suo “predecessore”, ebbe successo perché dal suo viaggio portò seco “numerosi tesori”. Il filosofo Marsilio Ficino (1433-1499) è ricordato come il primo traduttore delle opere complete di Platone, seguace del neoplatonismo commentò le Enneadi di Plotino in modo esemplare (si ringrazia Pico della Mirandola), equiparò Ermete Trismegisto a Zoroastro, Pitagora, Orfeo, Filolao, Zalmoxis: ogni sapiente del passato fu sul tavolo di lavoro di Marsilio Ficino, vero promotore del pensiero umanista ed influente esponente del Rinascimento. Giamblico, Porfirio, Avicenna, Averroè, Niccolò Cusano, Macrobio, Agostino, Apuleio, Dionigi Aeropagita, Lucrezio, Dante Alighieri (et cetera) sono solo alcuni dei nomi degli autori che Marsilio Ficino interpretò e promosse come menti illustri da osservare da vicino per riuscire a “cogliere le cose superiori senza trascurare le inferiori”.
“La potenza della grazia soggioga e rapisce con la stessa violenza di un dio. Come insegnava Platone: chi incontra il bello incontra il frammento di un mondo altro.” – Raphael Ebgi
“Anima Mundi” (Einaudi, 2021) curato dal professore di Storia della Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Raphael Ebgi, autore dell’approfondita – ed appassionata –introduzione intitolata “Marsilio Ficino: l’amore del pensiero”; si presenta come una selezione di lettere, traduzioni, riflessioni e commenti del famoso filosofo connesso alla famiglia de’ Medici.
Nella prima puntata della rubrica si è scelto di pubblicare un brano estratto dall’introduzione di Raphael Ebgi, nella seconda si è presentata una delle due lettere presenti nel primo capitolo intitolato Un circolo lucreziano all’amico, poeta e suonatore di lira Antonio Serafico; nella terza si è optato per la pubblicazione di un estratto dalla Epistola sul divino furore all’amico e studioso di eloquenza Pellegrino Agli; nella quarta ci si è soffermati su un estratto tratto da Trattato di Dio et anima ed uno tratto da Le quattro sette dei filosofi; nella quinta puntata si è preso in oggetto un estratto della lettera all’amico Antonio Canigiani presente nel capitolo Virtù e fortuna; nella sesta puntata si è presentato il primo capitolo Platonismo e repubblicanesimo della Parte seconda del volume intitolata “Firenze Atene”; nella settima lo spazio è stato riservato ad un estratto dal secondo capitolo Pietas et sapientia della Parte seconda intitolata “Firenze Atene”, capitolo suddiviso in sei sottocapitoli; nell’ottava puntata si è scelto di sottoporre una selezione tratta dal terzo capitolo della Parte seconda intitolato Poeti platonici: Argomento allo «Ione» di Platone; nella nona si sono presentati due estratti dal capitolo De miseria hominis; nella decima Misteri d’Amore si presentano due estratti da El libro dell’amore e dalla Lettera ai confilosofi ed a Ermolao Barbaro; nell’undicesima Del bello o della grazia un estratto da Argomento all’«Ippia maggiore» di Platone; nella dodicesima Immortalità e resurrezione un estratto da Argomento al «Fedone» di Platone; nella tredicesima Il regno dei nomi un estratto da Argomento al «Cratilo» di Platone; nella quattordicesima Il tempo della magia si presenta un estratto dal primo Commento alle «Enneadi» di Plotino.
In questa quindicesima puntata Il mondo delle immagini si presenta Parafrasi del «De mysteriis» di Giamblico.
Estratto da Parafrasi del «De mysteriis» di Giamblico ‒ Il mondo delle immagini
“Esposizione dei simboli della teologia egizia.
Gli Egizi, imitando la natura dell’universo e la potenza demiurgica (fabrica/demiourgia) degli dèi, svelano anch’essi, in simboli, certe immagini di mistiche e arcane nozioni, al modo in cui la natura esprime le sue ragioni occulte in forme visibili, quasi per simboli, e gli dèi esplicano la verità delle idee in immagini manifeste.
Vedendo che tutti gli enti superiori provano piacere per ciò che vi è di simile a loro nelle realtà inferiori, e desiderando così colmarli con quanto è bene, secondo le loro forze, attraverso l’imitazione, essi offrono, per quanto possibile, un modo di agire conveniente agli enti superiori, introducendo occulti misteri nei simboli manifesti.
Nell’interpretarli, tralascia le voci e afferra il significato.
Quando nei loro culti dicono «fango» intendi questo corpo del mondo, e la materia, e la virtù generativa che è lì insita e che è come agitata e in un flusso costante; intendi anche la causa principale, stabilita come fondamento degli elementi e delle virtù elementali.
Dunque, lo stesso Dio, essendo causa della generazione e di tutta la natura, e di tutte le virtù che sono insite negli elementi, nella misura in cui sovrasta tutte le cose, lui che è immateriale, indivisibile, immobile e ingenerato, che è tutto da se stesso e tutto in se stesso, precede e conduce tutte queste cose, abbracciandole tutte in sé.
Per il fatto che abbraccia tutte queste cose, e conferire qualcosa di suo agli enti mondani, Dio rifulge per loro tramite. Ma poiché sovrasta tutte le cose, risplende come separato da tutti gli enti del mondo, procedendo nelle altezze da sé solo.
Lo conferma il simbolo successivo, che raffigura Dio seduto sul loto, i.e. su una pianta, a indicare che Dio supereccede, in virtù della sua sovranità, il fango del mondo, e non lo tocca, quando governa, ma esercita una sovranità intellettuale ed empirea. Tutto nel loto è infatti rotondo, tanto i suoi frutti quanto le sue foglie, a indicare cos l’azione circolare della mente che si comporta sempre allo stesso modo.
Dio, dunque, sussiste in se stesso, al di sopra di questa attività, superando una simile sovranità, santo e venerando, e riposando pienamente in se stesso, cosa che è indicata dall’atto di sedersi.
Analogamente, quando introducono Dio quale nocchiero, indicando con ciò la sovranità che governa il mondo; infatti al modo in cui il nocchiero al timone, come separato, con minimi spostamenti regge e dirige la nave, così Dio, sopra il mondo, produce le cause primarie dei movimenti a partire dai primi principi della natura.
Poiché tutte le parti del cielo, i segni zodiacali, ogni movimento dell’universo, lo stesso tempo secondo cui si muove il mondo, e infine l’insieme degli enti contenuti nel tutto accolgono le potenze che emanano dal Sole ‒ alcune intrecciate a queste cose, altre invece superiori a tale commistione ‒, per questo il mondo simbolico della significazione rappresenta anche queste potenze.
Esso mostra con parole che il Sole si configura in accordo con i segni dello zodiaco, e che le sue forme variano a seconda delle ore. Dimostra, al contempo, il suo immutabile trasmettersi ovunque tutt’intero e nello stesso istante. Ma poiché le cose che lo ricevono si rivolgono in diversi modi attorno all’invisibile dono di Dio, e ricevono dal Sole potenze multiformi, a seconda della loro specifica natura e dei loro movimenti, per questa ragione la dottrina simbolica vuole avvicinarsi, per mezzo dei molteplici doni, al Dio-Uno, e aderire, attraverso le multiformi potenze, alla potenza unica di Dio.
Per questo dice che esso è uno e il medesimo, ma prevede in coloro che lo ricevono mutamenti di forme e configurazioni. Dice per questo che quello varia secondo i segni dello zodiaco e secondo le ore, quasi che tali mutamenti variassero attorno a Dio a seconda dei diversi ricettacoli cui essi ricorrono nelle preghiere ai lui rivolte.
Gli Egizi non soltanto nelle loro visioni degli dèi, ma anche nelle preghiere più comuni, che hanno un simile significato, si approssimano agli dèi che devono supplicare per mezzo di questa dottrina simbolica e mistica.”
***
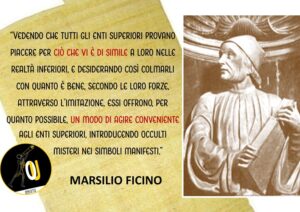
Per continuare la lettura in modo proficuo e con attenzione si consiglia di distogliere gli occhi dal computer o dal cellulare e di recarsi nella propria libreria per cercare il libro tra gli scaffali “impolverati”; se non si possiede il volume in casa si consiglia di acquistarlo (rigorosamente in cartaceo).
Leggere è un compito importante, la carta è di grande ausilio rispetto al formato digitale non solo per la concentrazione necessaria all’atto della riflessione e comprensione ma anche per instaurare un rapporto fisico con l’oggetto-pozzo che conserva amorevolmente le considerazioni degli esseri umani del passato, in questo caso di Marsilio Ficino.
Info
Leggi articolo Il Piombo in alchimia
Bibliografia
Marsilio Ficino, Anima Mundi, Einaudi, 2021


5 pensieri su ““Anima Mundi” di Marsilio Ficino #15: Il mondo delle immagini”