Poesia classica greca #4: Tirteo, il poeta della guerra
“No, non è un uomo valoroso in guerra
Chi non regge alla vista della strage, del sangue,
chi non cerca il nemico corpo a corpo.
Ecco il primato: questo nel mondo è il primo premio,
il più bello che un giovine può vincere” – Tirteo
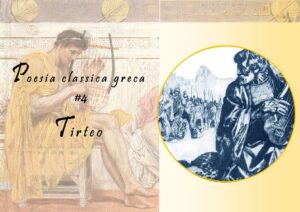
Quarto poeta per la rubrica “Poesia classica greca” iniziata con Archiloco a cui sono seguiti Semonide ed Ipponate.
Tirteo (Τυρταῖος) visse nel VII secolo a.C., non si ha la data certa di nascita e neppure quella di morte, benché di quest’ultima si pensa possa essere stata nel 640 o nel 633. Scelse Sparta come patria nella quale trascorse gran parte della sua vita e per la quale partecipò come condottiero alla Seconda guerra messenica.
La tradizione lo descrive come zoppo e deforme ed il suo arrivo a Sparta fu “ordinato” dall’oracolo di Delfi. Fu, infatti, a seguito della difficoltà che gli spartani incontrarono nel conquistare la Messenia (terra dei Messeni, cioè altri abitanti del Peloponneso, resi schiavi in una guerra precedente ma che, con l’aiuto di Argo, si ribellarono dopo sessant’anni) che l’oracolo consigliò la richiesta di un condottiero ad Atene. Gli Ateniesi che non volevano disubbidire all’oracolo inviarono un maestro di scuola che, seppur zoppo, era capace di esortare i soldati prima e durante la battaglia.
Lo scrittore Pausania del II secolo a.C. aggiunse che Tirteo fu inviato solo per obbedienza all’oracolo soprattutto perché zoppo e di scarsa intelligenza. Ma c’è anche da sottolineare che le prime testimonianze della leggenda del Tirteo ateniese sono di Platone e Licurgo, entrambi ateniesi ed entrambi lontani dall’epoca di Tirteo.
Che si volesse negare la possibilità che anche a Sparta potessero nascere poeti?
Considerando l’asprezza dei rapporti tra le due città e le tardive testimonianze è una ipotesi da non scartare.
“Giacere morto è bello, quando un prode lotta
per la sua patria e cade in prima fila.
Abbandonare la città, le sue campagne
opime, e mendicare, vagolando
con la madre diletta, il padre vecchio, i bimbi,
la cara sposa, è la cosa più turpe.” – Tirteo
Delle opere di Tirteo, (un’elegia denominata Eunomia, le esortazioni in versi elegiaci ed i canti di guerra) ci è rimasto ben poco, solo qualche frammento ed una raccolta di poesie di cui solo tre elegie sono quasi integre. Malgrado i pochi frammenti si è affermata la possibilità del tema della guerra come principale e grazie ad un frammento dell’Eunomia, tramandato da Plutarco, si è appreso che il “buon governo” fosse per Tirteo quello di Sparta nel quale il re ed il consiglio degli anziani (γερουσία) potevano non convalidare le leggi approvate dall’assemblea.
“Via, combattete gli uni accanto agli altri, giovani,
non date abbrivo a fughe turpi, al panico,
fatevi grande e vigoroso l’animo nel petto,
bandite il gretto amore della vita,
ché la lotta è con uomini; non lasciate, fuggendo
chi non ha più l’agilità: gli anziani.” – Tirteo
L’esortazione di Tirteo riguarda i giovani guerrieri che devono dimostrare sul campo di battaglia il loro valore e non devono temere la morte perché “Giacere morto è bello/ quando un prode lotta/per la sua patria e cade in prima fila”. Il poeta sottolinea l’importanza di non lasciare indietro, in caso di fuga, i più anziani che, presenti nel campo dimostrano il loro ardore ma che, con gli anni, sono stati privati della rapidità. E continua:
“È uno sconcio che un vecchio cada in prima fila
E resti sul terreno innanzi ai giovani,
con quel suo capo bianco e il mento grigio, e spiri
l’animo suo gagliardo nella polvere,
con le mani coprendo le pudende insanguinate
(spettacolo indecente, abominevole),
nude le carni: nulla c’è che non s’addica a un giovine
finché la cara età brilla nel fiore.
Da vivo, tutti gli uomini l’ammirano, le donne
l’amano; cade in prima fila: è bello.” – Tirteo

Nel brano Tirteo esorta il giovane ad occupare la prima fila perché il suo corpo morto brilla e viene ammirato rispetto a quello di un anziano. Stratagemmi che invogliano i guerrieri al coraggio e che allontanano la paura della morte, per questo motivo (e come ci riporta l’oratore ateniese Licurgo) gli Spartani, prima di ogni battaglia, erano obbligati per legge ad ascoltare la recitazione delle elegie di Tirteo; ed anche lo scrittore egizio Ateneo di Naucrati (morto dopo il 192 d.C.) riporta la testimonianza dello storico ateniese Filocoro (340 a.C. – 262/261 a.C.) secondo il quale fu in occasione della vittoria sui Messeni che iniziò l’usanza di cantare a turno, dopo cena, le elegie di Tirteo.
L’espediente del poeta non basava la forza solo nell’etica del preservare l’anziano e nell’osservazione dei corpi giovani; ma bensì esercitava potere sulla tattica: infatti, i giovani essendo più agili e forti erano di sicuro di grande vantaggio nella prima fila di una battaglia.
La salvezza della patria, la difesa del bene comune è ciò che più dà valore all’uomo e non è paragonabile alla competizione atletica, poetica, oratoria né al possesso di ricchezza o bellezza.
“Io non posso citare né tenere in conto un uomo
per un primato di corsa o di lotta,
anche s’è grande e grosso come i Ciclopi, o vince
correndo il vento della Tracia, Bòrea:
neppure s’è più bello di forme di Titone
o più ricco di Cinira e di Mida,
più regale di Pèlope Tantàlide, e mielata
come quella d’Adrasto è la sua lingua;
neppure se ogni gloria lo cinge e non è un prode.” – Tirteo
Sono passati secoli – millenni – dalle esortazioni di Tirteo eppure possiamo constatare quanto l’essere umano si sia impegnato notevolmente nel produrre guerra e nell’invitare i giovani alla morte. Per la patria. Per la salvezza. Il Novecento è stato un secolo nel quale, con il fiorire del cinema, la propaganda a favore della guerra si è espansa notevolmente: ogni Stato combatte per il proprio benessere e fra i due contendenti entrambi sono colpevoli nell’uso della forza (in difesa ed in attacco) laddove, dopo per l’appunto millenni, si potrebbero usare le parole. Ma, l’uomo non è mutato al suo interno, pregno di dèmoni è il suo animo ed ancora percorrere la strada sbagliata: quella della battaglia esterna a sé.
La guerra più nobile è quella che si combatte al proprio interno per acquisire la capacità di dominare i dèmoni interiori – gli istinti, sentimenti quali odio, vendetta, invidia – così da tagliare quel traguardo che vede il proprio bene uguagliarsi con il bene del prossimo.
“La Natura ti sia guida, seguila lieto ad arte:/ Fallirai se non ti sarà compagna di strada;/ La ragione ti sia bastone, fortifichi l’esperienza/ Gli occhi tuoi, che possa tu vedere in lontananza./ La lettura sia una chiara lampa nelle tenebre,/ Perché ti guardi dagli ammassi di parole e cose.” – “Atalanta Fugiens” di Michael Maier, epigramma del quarantaduesimo emblema
Written by Alessia Mocci
Info
In foto: Dettaglio del dipinto “Un musicista” di Albert Joseph Moore (1841-1893) e dettaglio ripreso da un articolo pubblicato da InfoSibari, l’autore dell’immagine non era riportato.
Rubrica Poesia classica latina



