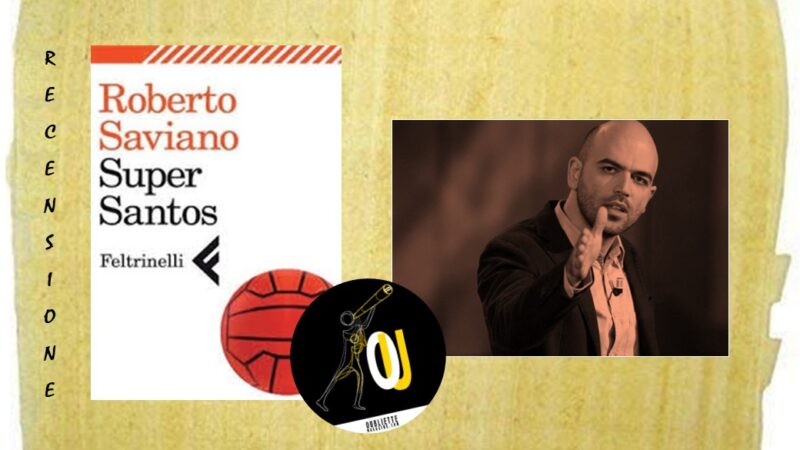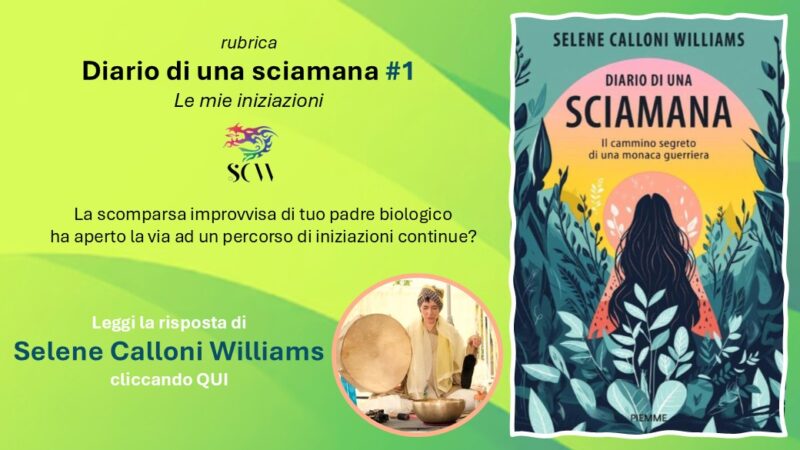“Lingue d’Europa” di Emanuele Banfi e Nicola Grandi: elementi di storia e di tipologia linguistica
Premetto quel che parrà subito ovvio. Io non scrivo critiche, né disamine testuali, né recensioni: a me non interessa tanto conferire un valore a un’opera letteraria o saggistica (termini che per me sono pressoché sinonimi), non avendone alcuna autorità per farlo, quanto utilizzare, anche vilmente, un testo perché accada una reazione fra me e lui. Anche se, talvolta, ho dei seri, seppur Celati, dubbi di ex-agerare. Quel prodigioso Gianni, se lo conosci, fatichi a evitarlo.

Spiego perché ho scritto vilmente. Il mio fine non è di certo quantificare valori, quanto confrontarli, metterli in correlazione, grazie alla scrittura. Da una parte c’è l’autore (nel caso di Lingue d’Europa sono due docenti di ateneo Emanuele Banfi e Nicola Grandi) e dall’altra ci sono io (discolo scolaro). L’interazione gravitazionale avviene a prescindere dalla rispettiva massa gravitazionale, dal proprio dato spazio-temporale. Quel che alla fine conta è il grado di entanglement che si forma tra i soggetti in campo, uno dei quali potrebbe essere vissuto più di un millennio fa, che però, grazie alla propria parola, è tuttora in grado di dire la sua, udendo e reagendo alla mia. Si tratta di un’illusione? Forse, ma quel che per me vale è la religio, cioè il legame che sorge dalla scelta effettuata in quel magico momento. Il sacro, secondo Mircea Eliade, è il luogo della condivisione fra l’umano e il divino. La scrittura, allorché è avvenuta, risiede lì, a metà strada fra me e l’altro. Ed è lì che io posso affermare il rimbaudiano: Je est un autre. Ognuno è divino (e devoto) a modo suo.
Leggendo Il cappello scemo di Haim Baharier ho scoperto che, nell’antico ebraico, tevà è sia parola che arca: un mezzo di comunicazione che, quando la sai condurre, può recarti alla salvezza: la parola che l’autore ha emesso e che io ho percepito, ognuno inter-agendo dalla propria orbita.
Un detto amalfitano è chi tene a léngua va ‘n Sardégna. Qualcosa di analogo lo pensava mia madre che, prima di uscire, si assicurava di avere le scarpe, il portafoglio e la favella. Grazie al mio amato maestro elementare Enrico Paoli e alla mia natura doppia, mi son sempre adoperato a schivare l’istituzione scolastica, pur amando la cultura. La linguistica è una delle materie che ignoro con più rincrescimento, specie da quando mi sono avvicinato allo studio del dialetto arşân reggiano. Nella vita è problematico tornare indietro, e questo è il motivo per cui sto andando avanti a modo mio, cercando di cogliere i suggerimenti di chi ne sa più di me, in questo caso di mia figlia Anna, che ama studiare fin dalle elementari e che ora sta frequentando con un discreto successo l’Ateneo Alma mater di Bologna. Sono così contento che non abbia preso da me! Ma sono altresì deciso a non imitarla in toto, anche per raggiunti limiti d’età.
Ho letto il presente saggio Lingue d’Europa cercando di trattenere il più possibile, non sapendo però quanto rimarrà nella mia memoria, che ogni giorno si diletta a vedere scorrere un rivo strozzato che gorgoglia: lo dico dopo aver quasi contemporaneamente finito di leggere Danubio di Claudio Magris.
A pagina 16 apprendo che “l’Europa vanta la presenza di più di sessanta lingue ‘statutarie’, riconosciute dalle Costituzioni dei singoli Stati nazionali; a esse vanno aggiunte le lingue ‘non statutarie’, il cui numero appare decisamente controverso, in quanto ogni calcolo risulta fatalmente condizionato da visioni politico-culturali…” – successivamente sono elencati alcuni vernacoli italiani, nonché il “bosniaco, filiazione del serbo, ma filiazione letta in chiave turco-islamica.”
Ripenso ora a quanto si auspicava Padre Aldo Bergamaschi, il mio personal theologian (che frequentavo all’inizio da ateo e poi, miracolosamente, da ignorante di Dio): un mondo in cui campeggiasse più in alto di tutte un’unica lingua, magari l’esperanto, che è una miscellanea di varie lingue, per quel che ne so.
Oggi questa lingua, di fatto, è l’inglese. Noi vili italici siamo come quegli immigrati che continuano a parlare fra loro l’idioma natio (e lo insegnano ai propri figli), ma che non possono non giungere a conoscere sempre meglio la lingua del luogo in cui abitano: e oggi si vive tutti in quel villaggio globale, dove non si sa chi esattamente comandi, pur intuendo il plutocratico perché.
Lo stesso capitò a taluni miei compagni di classe delle elementari, la cui lingua madre era l’arşân, quella dei miei genitori che però, prudentemente, discorrevano con me in italiano. Nell’atrio della scuola media che frequentavo, spiccava un cartello che ammoniva: Vietato parlare in dialetto. A noi cosiddetti baby boomers per anni ci è stata come amputata una lingua, quella dei nostri cari. Nonostante ciò, grazie ai miei genitori, conosco l’arşân abbastanza bene, pur lasciandomi scappare talvolta, involontariamente, alcuni italianismi, tipo pranşêr, anziché dişnêr, maslêr anziché pchêr, termine che deriva da beccaio, come anche butcher (inglese) e boucher (francese).
Si dovrebbe scegliere una lingua unica per la socialità in toto, difendendo però le lingue locali, che sono l’etimo (l’intimo significato delle parole, la loro lontana e spesso arcana verità) di qualsiasi lingua ufficiale che si giungerà a determinare. Il sanscrito è, per me, la lingua che più venero, pur non conoscendola quasi, se non per il suo valore etimologico: da kam’a, che equivale a passione, deriva amore e amicizia.
L’italiano è una lingua poco parlata nel mondo, ma è la terza più studiata, a quanto si dice. Questo lo si deve alla grandissima creatività ottenuta dalla sua scrittura letteraria. Lo stesso vale per il latino e per il greco antico.
“… nella maggioranza dei casi, infatti, le lingue dell’Europa appartengono all’unica famiglia linguistica indeuropea…” – a parte quei rissosi, irascibili e carissimi baschi, oppressi fino a pochi decenni fa dalla propria brama d’indipendenza e dalla conseguente repressione franchista. La loro lingua è un unicum pre-indoeuropeo, come sto scoprendo leggendo il presente saggio. Io sono favorevole all’istituzione di un vero Stato Unito d’Europa, non quella pantomima che c’è oggi, dal Portogallo all’Islanda, alla Norvegia, alla Russia, alla Turchia, paesi baschi compresi, ovviamente. I sogni sono desideri di felicità, che possono un giorno realizzarsi. Io mi sento arşân, emiliano, italiano, europeo e terrestre. E, ovunque mi diriga, cerco di capire e di farmi comprendere.
Questo mi fa davvero ammirare l’esame che gli autori fanno, a partire dai tempi più antichi, delle lingue italiane ed europee. Sono meravigliato dalle novità che leggo al punto che, lo sento, ogni tanto consulterò alcuni passi del saggio, tentando di rinvenirvi la risposta a sempre nuove domande.
“Una lingua non è mai uguale a se stessa: ciascuno di noi parla diversamente in rapporto alle situazioni in cui si trova, agli interlocutori con cui interagisce, all’argomento che sta trattando ecc.” – quando due colleghi dell’INPS discorrono fra loro, usano acronimi come UNEX, ARCA, ARLA, GAPE, GAMA, HYDRA, ARTCO etc; ma quando sono di turno allo sportello con l’utenza, per necessità di comunicazione, adottano la generica locuzione Archivi dell’Istituto. Quando parlo con un certo Romano uso vocaboli calcistici, a meno che non si discuta di thriller, di cui egli è ghiotto fruitore (soprattutto di Cornell Wollrich). Quando chiacchiero amabilmente con Silvano, cito termini collegati alla solita (chissà in quanti capiranno cos’è: il cui misterico etimo è assai conosciuto).
Nel leggere 3. Profilo comparato delle moderne lingue d’Europa, giungo alla consapevolezza che l’utilizzo di particelle come gli “articoli” debba servire principalmente a democraticizzare l’eloquio. Il maggior numero di parole illustrano essotericamente il contenuto di un discorso, che sarà meglio recepito da chiunque. Aggiungo, però: entro certi limiti. La lingua ha il compito di farsi capire. Ma anche d’esprimere in modo icastico un contenuto, magari utilizzando un ablativo assoluto.
Quando lessi Rimbaud, nelle notti colsi numerose rinunce a capire, con espressioni del tipo: la critica è impotente (a decifrare il senso del discorso). Il poeta è l’animale parlante meno assoggettato alla chiarezza. E può rimanere tale anche qualora scriva in prosa.
Ricordo un articolo dell’Espresso degli anni ‘70, in cui era riportata una lettera di un allievo di Heidegger, in cui il giovane chiedeva, in poche parole, Maestro, non potrebbe essere più chiaro? La risposta del suo più che arcano docente era lunga e per certi versi incomprensibile, ma si poteva sintetizzare in un secco No! Mi dispiace ma non è possibile! E questo rappresenta il limite nonché la grandezza di numerosi filosofi e scrittori.
“Mentre nei sistemi diffusisi in precedenza (ad esempio nei geroglifici egizi), definiti tecnicamente logografici, prevaleva l’intenzione di raffigurare simbolicamente il significato nel segno, nei sistemi fonografici si impone la tendenza a riprodurre il significante, cioè la sostanza fonica del segno stesso…” – in quanto “lo scopo ultimo della scrittura rimane quello di trasmettere il significato del messaggio…” – sia pure “per via indiretta” – quasi astratta, mi verrebbe da dire. Mi verrebbe da dire che questo nuovo modo deve aver favorito non solo l’evolversi della scrittura, ma la sua eventuale recitazione, che si baserà d’ora in poi su dei segni in qualche modo più certi e significativi. Inoltre, “imparando un numero limitato di elementi base, è possibile creare infiniti messaggi.” – e questo è lo spirito che, intuisco, ha ispirato la creazione del linguaggio macchina, basato in primis su due soli segni: 0 (luce spenta) e 1 (luce accesa). I linguaggi informatici successivi (assembler, cobol e il più semplice basic, nonché numerosi altri) hanno utilizzato un numero più ampio di segni, riuscendo a costruire monumenti informativi assurdamente complicati.

Quando leggo, a partire da pagina 125, dei tipi linguistici, basati sulla diversa posizione di S (soggetto), O (oggetto) e V (verbo), noto che, per esempio, “SOV” sono le “lingue indo-arie”, quelle “ugro-finniche”, quelle “turche” e la lingua “ungherese”; simile diversificazione è relativa a “SVO”, mentre “VSO” sono soltanto le “lingue celtiche”, fatta “eccezione del bretone” – il quale è “SVO”. Ed ora mi domando cosa significherebbe se le lingue extraeuropee fossero similmente SOV, SVO e VSO e per quale motivo: ma sarebbe come domandarsi per quale magia il lupo canide assomigli tanto a quello marsupiale, che è geneticamente assai diverso; o perché la pelliccia del giaguaro americano assomigli più a quella del leopardo africano, che a quella del limitrofo coguaro. Probabilmente tutto è accaduto per caso e/o per necessità. Ed è forse quello è il motivo per cui dei casi “VOS”, “OVS” e “OSV”, non ve ne sia “nessuna attestazione nelle lingue europee”. Per rinvenirne dei casi occorre spostarsi in altri continenti, dove essi “trovano riscontro in una manciata di lingue di scarsa diffusione” – in popoli i cui progenitori o discendenti potrebbero però aver bazzicato anche nel vecchio continente. Chissà! Ogni tanto penso alla balena Valentina, il cui scheletro fossile è stato rinvenuto nei calanchi del Rio della Rocca di San Valentino, a una ventina di chilometri dal centro di Reggio Emilia.
In alcune lingue generalmente si differenzia fra il genere maschile e quello femminile. Anche in questo caso ci sono i pro e i contro della questione. Rendere più complesso un vocabolario significa rallentarne l’apprendimento. Certo che sarebbe sfizioso sapere quale potrebbe essere il maschile di tigre (e qui penso a un celebre film di Gassman) e di averla maggiore, nonché il femminile di spettro e di fantasma.
In genere è “un’impresa vana cercare di predeterminare la direzione del cambiamento linguistico: le variabili in gioco sono tali e tante che anche un accidente della storia all’apparenza insignificante può deviare il corso degli eventi e indirizzarli verso una meta assolutamente inattesa”: anche grazie alla fiction letteraria, si pensi a fantozziano, felliniano, donchisciottesco. Si pensi pure a pandemia, vocabolo che già esisteva da tempo, ma che ora ha assunto un significato esistenziale e quasi fatale.
“In effetti, affermare che una lingua appartiene a un tipo non significa automaticamente escludere che in essa si mantengano vitali, strutture o strategie che rimandano a un altro tipo.” – Panta Rhei, per cui tutti i fiumi prima o poi recano al medesimo mare e, infine, al più immediato oceano.
Ognuno di noi, per quanto gli è possibile, dovrebbe cercare di salvare una lingua non statutaria. Essa servirà a qualcosa, ne sono certo. Per testimoniarlo riporto un detto delle mie parti: a n gh ē trést cavâgn c’a n vîn bòun na vôlta l’ân: non c’è scalcagnato cesto di vimini che non possa servire durante la vendemmia. Si prenda, sia pure per celia, l’esempio di Tex Willer, che si è salvato innumerevoli volte la vita grazie alla sua conoscenza dei dialetti pellerossa, soprattutto ma non solo quelli del Texas e dell’Arizona!
Sogno d’imparare tutti i dialetti italici, lasciando per ultimo, dulcis in fundo, quello bergamasco. Ogni tanto penso alla storiella che narra di quella volta che un monarca aveva ordinato: i veri italiani facciano un passo in avanti!, e tutti, dai sardi ai triestini, obbedirono fedelmente. Ma non i bergamaschi, non per scarso patriottismo, ma perché non erano certi di aver compreso le regali parole. E a volte anche il sottoscritto si sente così picio!
“Il livello della lingua più esposto alle influenze esterne e dunque più vulnerabile è ovviamente il lessico…” – cioè il repertorio fisico di vocaboli in una lingua; il che m’induce a formulare un’analogia tra la parola e la particella della meccanica quantistica, che si forma grazie a una configurazione energetica e che, nella sua indeterminabile vita, di certo condurrà sé a una fatale dissoluzione, che servirà a produrre una rinnovata energia, la quale, a sua volta, determinerà la formazione di una nuova particella. Il paragone pare azzardato, ma ha un suo senso qualora si pensi al ragionamento del fisico Niels Bohr, secondo cui la particella esiste nella realtà solo allorché viene attestata (essendo in precedenza una mera onda energetica). Similmente, il vocabolo esiste solo se viene pronunciato oppure scritto. L’invenzione della scrittura pare eternare quel magico momento. Sento che ogni scrittura è tale solo nell’atto della sua lettura, a bassa (metodo inventato, a quanto si dice, da San Carlo Borromeo) o ad alta voce. Il vocabolo, in tal senso, è al contempo più vulnerabile e immortale, essendo coinvolto in un eterno karma.
A casa (sparsi in due camere da letto, una sala, un solaio, un corridoio e due garage) posseggo circa 3.000 libri da leggere. Quando passo loro accanto, sembrano dormire il sonno dei giusti. Ma essi sono, sia pur virtualmente, già esistenti. Sarà solo nell’atto della loro, chissà quanto imminente e probabile, lettura, che ognuno di essi avrà, carattere dopo carattere, la meritata at-testazione.
“… dovremmo attenderci di riscontrare tra le diverse lingue almeno tre tipi di somiglianze (escludendo quelle dovute al caso)…” – previe una “filiazione genetica”, varie “analogie di natura tipologica”, un “contatto tra i rispettivi parlanti”. Avendo vissuto per oltre trent’anni con un’amalfitana di padre cilentano ho acquisito numerosi detti campani che ho poi diffuso al nord, il principale dei quali è stare in cardacia, cioè in ansia, da cardium. O cardacìa? O cardacía? Leggendo la traduzione italiana di Rayuela di Cortazár, notai che le i e le u erano segnate da un accento acuto: í e ú. Quindi: sí e piú. Non avendoci mai badato in precedenza, avevo (assurdamente) ipotizzato un ispanismo, stante anche il cognome dell’autore, ma una traduttrice di Einaudi m’informò che solo la sua casa editrice si comportava in tal corretto modo. Erano gli altri a sbagliare. A seguito di ricerche su zio Google, scoprii che la scelta di Einaudi era forse sorta dalle teorie del linguista Pier Gabriel Goldanich che, in una sua grammatica del 1918, sancì (anzi: sancí) tale regola. Ecco un’isola linguistica così (anzi: cosí) piccola che al confronto Montisola (nota anche come Monte Isola) pare una specie di Madagascar! Mi sto anche accorgendo che ci sono quasi più (anzi: piú) isole linguistiche che scrittori.
C’entra forse poco col discorso, ma tant’è… Sarebbe sfizioso fare l’inventario delle scelte (apparentemente?) sgrammaticate di scrittori quali Umberto Eco e Riccardo Bacchelli che di sovente si dilettavano a usare il sapido cripto-pleonasmo per intanto, e, nel caso del narratore felsineo, di alcuni spiritosi qual’è. Anche tali elementi fanno parte di diritto della cifra stilistica di questi dotti autori.
L’arşân stesso è ricco di posizioni contrapposte. Il suo massimo studioso, Denis Ferretti, autore di Grammatica del dialetto reggiano, non usa l’apostrofo tra l’articolo (al) e il sostantivo maschile, ma solo quando l’articolo (la) è abbinato al sostantivo femminile: l êşen e l’êşna, ognuno dei quali raglia in modo affine, prescindendo dall’apostrofo. Pochi seguono il suo esempio. Se si leggono le opere dell’appenninico (faccio fatica a definirne con una parola l’origine esatta: tassobiese?, casinese?, castellarese?, vettese?) Savino Rabotti, del novellarese Sergio Subazzoli e del correggese Luciano Pantaleoni, si possono cogliere notevoli differenze idiomatiche, anche se questi autori dimorano a una cinquantina di chilometri l’uno dall’altro.
Ebbi una volta l’opportunità di fare da intermediario culturale fra un amalfitano e un pisciottano, che tra loro poco si comprendevano. Usai all’uopo un misto di italiano, di amalfitano (ricco di genitivi in ‘e) e di pisciottano (zeppo di genitivi in ‘r). Alla fine i due si compresero abbastanza. Mia figlia, dal canto suo, ha esportato in quelle amene costiere, espressioni tipicamente arşâne, pur tradotte in italiano: ma va’ a girare, me la devo spocciare da sola, ma che brutto (o che bel) lavoro! Ricordo che un siracusano una volta mi disse: io non capisco il gusto di voi reggiani, che mettete il lavoro dappertutto! E il marcusiano che sonnecchiava in me prontamente assentì (anzi, assentí).
“… un’area linguistica deve essere prima di tutto un’aerea culturale e storica; ma non è detto che un’area storico-culturale si trasformi automaticamente in un’area linguistica.” – dipendendo sempre dall’imprevedibile e indefinibile intervento umano. Sotto il regime franchista, l’uso del basco era vietato, per cui era parlato di nascosto nelle case di quel popolo perseguitato anche culturalmente. Quando mi recai a Barcellona notai che i binari erano indicati nei due diversi idiomi, catalano e castigliano: via e vías. A Reggio, diciamo che fra córer e scapêr a gh ē al fîl dla pulèinta (detto intraducibile, nel senso che si capisce da sé).
“… possiamo prevedere che i mutamenti raggiungessero piuttosto agevolmente le regioni meglio collegate…” – e similmente accade per il mio dialetto cittadino che si differenzia da quello delle lande appenniniche e delle zone limitrofe al Po, che fra loro, arcanamente ma non troppo, essendo state meno contaminate da influssi forestieri, si somigliano. Le vocali montane e quelle fluviali sono più aperte di quelle pronunciate dal Pôpol Gióst, che abita in via Roma, nel centro della Città del Tricolore.
A volte pare che “la forma ‘sbagliata’ abbia preso definitivamente il sopravvento su quella ‘corretta’” – mio papà diceva rùbrica (da rùber), credo giustamente. E circuìto, anziché circùito, e qui non saprei che dire. Secondo Claudio Marazzini (che rispose a un mio quesito che gli posi per lettera), il mio insistere su càlcare (da càlcio) anziché sul carosellesco calcàre, era solo un mio problema. Il maestro Paoli l’avrebbe bacchettato sulle dita a pigna, dopo avergli esibito la corretta lezione tratta da Il piccolo Palazzi. Sempre e ovunque, Glossa Rhei. Ma in quel momento storico, l’inclito linguista aveva probabilmente ragione.
Leggo a pagina 176 che a Pompei esistono ancora vari “graffiti il cui stile è lontanissimo da quello degli autori coevi” – che hanno consentito agli studiosi del latino di ampliare le loro conoscenze. Questo è uno dei motivi per cui amo salvare non solo i disegni dei murales, le cui immagini stanno riempiendo le memorie di massa del mio computer, ma anche le scritte a volte apparentemente dissennate che sono sparse nel mio territorio.

“In conclusione, se davvero la situazione immaginata sopra si verificasse…” – dove potrebbe sorgere confusione fra chi è il vero soggetto di un paio di frasi contigue, come può accadere nel basco – “… e ci trovassimo dunque a conversare con un parlante latino e un parlante basco, otterremmo il risultato di trasmettere due messaggi differenti pur pronunciando un’unica frase.” – e tale inconveniente non può che dare ragione al citato Padre Bergamaschi: ci dovrebbe essere una lingua universale ma anche una lingua adatta a comunicare ad personam, secondo la comune parlata del prossimo, che dovrebbe essere, ogni tanto, anche la tua. Ricordo una sua omelia, in cui egli gridava: al drōven! al drōven! – lo adoperano! – perché in tal modo un uomo aveva risposto al suo quesito: Chi è il Cristo per te? Io stavo entrando in chiesa, nel mio consueto e innocente ritardo, quando udii tale parola ripetuta con ardore, senza dapprima comprenderla. Padre Aldo era un docente universitario ed era di nascita e di cultura toscana. Ma ormai sapeva ben intendere l’arşân!
Sento che utilizzerò il presente saggio come mio personal idiomatic-pedia, anche grazie al preziosissimo Indice delle lingue nonché a quello dei fenomeni linguistici, con cui esso si conclude.
Ringrazio pertanto i due autori, ma anche la mia figliuola (in arşân è la mé fiôla, ma anche la mé putîna), che mi ha quasi brutalmente (scherzo ma non troppo) imposto la lettura del saggio.
Fingo, per celia, di non ricordare bene, quale voto abbia lei conseguito nell’esame di linguistica, ma credo che sia stato 30 e lode ≤ x ≤ 31. Io avrei puntato al 17 e tre quarti, confidando in un improvviso, miracoloso e insperato colpo di c… casualità!
Written by Stefano Pioli
Bibliografia
Emanuele Banfi, Nicola Grandi, Lingue d’Europa, Carocci editore, 2018