Dante Alighieri e la presenza dei Classici nella “Divina Commedia”
Vorrei soffermarmi su un motivo della Commedia che pervade tutte e tre le Cantiche, ovvero la presenza dell’Antico in Dante. Emerge anche dal primo canto dell’Inferno nell’incontro tra Virgilio e Dante.
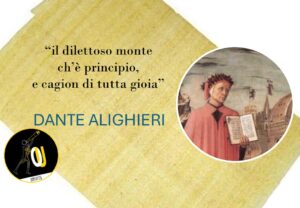
Dante si sta perdendo nella selva, ma ad un certo punto scorge un’ombra e, dopo aver parlato un po’ con lei, subito la riconosce e ne riconosce le caratteristiche o le proprietà specifiche.
Fiumi d’inchiostro si sono spesi sul “chi per lungo silenzio parea fioco” (v.63), il verso che introduce la presenza virgiliana nella selva dantesca.
Lasciando tutte le possibili interpretazioni, non posso non far notare un accostamento tra sfera uditiva (silenzio) e sfera visiva (fioco), stilema particolarmente caro a Virgilio, come si nota nell’episodio di ingresso di Enea nel regno degli Inferi (nel VI canto dell’Eneide ai versi 264-294).
Inoltre, coerentemente con la teoria medievale degli stili, Dante parla in latino (“miserere” v.65) quando inizia a rivolgersi al poeta che di lì a poco si manifesterà: tutto in questo canto in realtà è avvolto da Provvidenza e anticipazione.
Nella risposta virgiliana traspare tutta la nostalgia tipica dei poemi classici, in cui i morti ricordano con amarezza la loro vita (“Non omo, omo già fui”, v. 67); qui si potrebbe citare l’incontro tra Achille e Ulisse (siamo nell’XI libro Odissea, in cui Ulisse tra l’altro scende nel Regno dei Morti e Tiresia gli predice il futuro, incontra la madre e anche Agamennone) e tantissimi altri esempi. Analogamente l’auto-presentazione di Virgilio ricalca la falsariga del suo epitaffio, conferendo familiarità al lettore attento; e tuttavia non rimangono inosservati gli aspetti “nuovi” del Virgilio dantesco tra cui i “parenti lombardi”, aggettivo quest’ultimo di origine medioevale (da Longobardi); classica è la velocità “epica”, realizzata con parole “alate”, con cui Virgilio prosegue le informazioni di sé: “Nacqui sub Iulio… e vissi a Roma sotto ‘l buon Augusto” (vv 70-71); già con l’espressione “buon” si riconosce l’inevitabilità dell’impero augusteo, necessaria sia ai tempi dell’era pagana che ai tempi di Dante.
Dante infatti vede l’Impero romano come presupposto fondamentale per l’affermazione di una monarchia universale cristiana. Ma il Virgilio dantesco fa un passo ulteriore e riconosce il tempo in cui è vissuto come quello degli “dei falsi e bugiardi” (v.72). Analogamente Virgilio invita Dante verso “il dilettoso monte/ ch’è principio, e cagion di tutta gioia” (vv. 77-78).
Nonostante la lontananza tra mondo classico e mondo cristiano, il primo è ancora un modello per i medioevali. E così Dante, riconoscendo Virgilio, lo chiama “maestro” e “autore” (v. 85); maestro in latino è magister, da magis “che vale di più”; e autore è auctor, “colui che accresce, promuove”, dal verbo augeo (da qui anche l’appellativo di Ottaviano, Augustus, con risvolti anche religiosi e sacrali).
Virgilio sarà la sua guida, almeno nell’Inferno e nel Purgatorio. Quel Virgilio che tutta la tradizione medioevale ha voluto leggere in chiave cristiana anche per aver, in una sua Bucolica, la IV, profetizzato la nascita di un puer che avrebbe portato la pace nella Roma dilaniata dalle guerre civili.
Anche la profezia è un aspetto comune tra antichità ed età medioevale.
Nell’antichità i profeti (alla lettera “coloro che dicono prima”) erano tutti coloro che erano in contatto con la divinità: sacerdoti, indovini, poeti, morti. Lo sa bene Enea che, incontrando il padre nel Regno Dei Morti, ha da lui la predizione del futuro.
Anche Virgilio profetizza a Dante il suo futuro, che si intreccia con le sue vicende di uomo politico e cristiano: tra queste quella del “veltro” che “Di quella umile Italia fia salute/ per cui morì la vergine Camilla,/ Eurialo e Turno e Niso di ferute” (vv 106-108).
Ancora una volta in questi versi si mescolano l’Italia virgiliana (Humilemque videmus Italiam dice Enea in Eneide, libro terzo, versi III 522-523: ricordiamo che humilis in latino significa alla lettera “che sta in basso” e indica qui proprio le coste basse dell’Italia), e quella dantesca per cui “umile” va oltre il significato letterale per indicare quello morale della decadenza dell’Italia, che è tema carissimo a Dante, uomo a noi vicino e lontano, poeta essenziale, luce per la nostra civiltà, poeta dell’Italia per la quale in definitiva molti già si sacrificarono dai tempi antichi, come sopra richiamato.
Del resto in base all’interpretazione figurale di Dante, quale Eric Auerbach ha formalizzato, non è difficile cogliere negli eroi antichi del mito una prefigurazione dei futuri, possibili salvatori della patria, della nostra bella Nazione che è la più bella del mondo.
Tutto il Medioevo, in particolare quello latino, del resto si colloca come punto di contatto tra la cultura classica e la cultura europea come si legge nel famoso saggio Letteratura europea a Medio Evo latino di Ernst Robert Curtius (1948).
In questi giorni sto rileggendo un bellissimo saggio di Giorgio Ficara, Classici in cammino, edito da Marsilio nel 2021 e che ho recensito per Oubliette nel 2021 (per leggere la recensione clicca QUI).
Ebbene la sua tesi è che il concetto di classico è qualcosa di dinamico che si muove nel tempo dall’antichità fino ad oggi, passando anche per Dante. Quando il classico latita, anche la letteratura, nella sua qualità, ne risente. Ecco, senza voler per forza legarci ad un passato da noi distante, ma nella consapevolezza che senza maestri tutto svanisce (diventa fioco), dovremmo tornare a leggere i classici, non solo per scrivere, anche di critica letteraria, ma anche per il semplice gusto di apprendere e di camminare nella Storia.
Written by Filomena Gagliardi
Bibliografia
Dante Alighieri, Divina Commedia, Rusconi Libri, 2024




Dante, l’inquisitore e Messer Matteo
Non omnes mulieres venificas sunt. Sed omnes veneficas mulieres sunt
“Non tutte le donne sono streghe,
ma tutte le streghe sono donne che con sottili arti e seducente aspetto portano alla perdizione ingenui garzoni.
Noi garzoni protestiamo la nostra pudibonda innocenza, ma non aspettiamo altro che di essere messi alla prova.”
Alle risate dei bevitori, seguirono strofe sempre più sguaiate. Cosa poteva aspettarsi di trovare, in quella taverna male illuminata lo schivo viandante? Vino abbondante, cibi caldi e femmine lascive. I loro corpi si strofinavano sui garzoni invitandoli al ballo. Tutto si trasformò in una baraonda e non si capì più se fosse taverna, bordello, sabba di streghe lascive.
La porta sbattuta con violenza e più ancora la minacciosa presenza di Messer Matteo portatore alla cintura di due lame turche, riportarono la calma. I capannelli si sciolsero. I maschi diventati subito silenziosi, tornarono al bere e le femmine si radunarono dietro il bancone, lanciando con gli occhi messaggi d’amore. Eldengardo il viandante schivo, attese che la bolgia si placasse. Prese posto ad un tavolino, che era stato sistemato nella ampia rientranza del muro prima del camino di pietra nera. Appena seduto, lo schivo giovane recitò silenziosamente una breve preghiera “Nam futura coeptis .” implorando l’aiuto dei Santi. L’incontro, che temeva, era il motivo per cui lui, un inquisitore, abbandonata la calda tonaca bianca e nera dei Domenicani , rimpannucciato in una rozza guarnacca da bottegaio, si era dovuto fermare alla taverna. Si era scelto quell’angolo discreto e ora attese che Messer Matteo si sedesse.
Stringendo fra le mani i boccali di vino, che l’oste aveva subito rimboccato, si studiarono. Entrambi astuti, attendevano che l’altro parlasse. Fu Messer Mateo, sempre impaziente, ad iniziare.
“Là, nel bosco, sotto gli odorosi pinastri verdastri, si snoda la strada dell’amore che porta dritta al tuo cuore.
Percorrerla, portandoti doni è un piacere.
Vestendomi, mi dissero, non protestare, è un tuo dovere.
Giacché da sempre per un cavaliere, onorare una donzella,
è impresa che rende l’anima sua bella.”
Edgardo gli rispose
“Bella impresa fece l’anima tua, sfidando la femmina vana,
che avida d’amor e doni ti guata dalla ventana.
Lodar la tua onestà non posso, mio ingenuo cavaliere.
Meglio per te sarebbe costringer la femmina a giacere.”
Matteo sembrò soddisfatto, e ridendo, ammise che era una stupida idea che due galantuomini, per riconoscersi, recitassero dei versi zoppicanti e insulsi. Ma, aggiunse, “che possiamo fare se il Bargello e il
Maestro Generale del vostro ordine hanno deciso che dobbiamo collaborare.”
“Padre Eldengardo, vi hanno ragguagliato sul motivo di questo incontro?” “Si” ripose Eldengardo. “si tratta di lui e della sua Commedia” .”Al tempo-“ rispose Matteo. “Troppi occhi e troppe orecchie. Venite con me a casa di Fiammetta la romana. ”Come? “chiese sottovoce l’inquisitore arrossendo. “Ma certo” rispose Matteo “Chi fa caso a due onesti uomini che vogliono dividersi la baldracca?”
La cosa aveva senso. Per l’inquisitore che aveva avuto l’ordine della massima discrezione e disponibilità, fu facile obbedire. Anche perché il Padre Superiore lo aveva istruito “Badate, Messer Matteo può sembrare un poco di buono e un puttaniere. Ma sappiate che è uomo rispettabile e stimato dal Bargello.”
Fatti entrare in casa, Fiammetta versò due calci di vinsanto agli uomini e attese le loro richieste. Due o tre che fossero pensò Fiammetta, ho di che soddisfarli, mentre con gesto gentile rialzava il seno tondo. “No cara”. Matteo le mise in mano un fiorino grosso d’argento. Vogliamo solo la cameretta sul retro, per me e il mio compagno.” “Messer Matteo” gridò meravigliata la donna “che siete sodomita? vi ho sempre visto maschio gagliardo.!” “Ma no!” rise Matteo. “Di soldi dobbiamo parlare e da te siamo sicuri di non essere ascoltati. Poi ti darò altri due fiorini per il tempo preso.” Matteo conosceva quella stanza che più volte aveva usato per incontri segreti. Mura spesse, finestra su un giardino cintato e porta in pesante quercia garantivano riservatezza.
“Bene, inizio io” disse Eldengardo che malgrado le assicurazioni di Matteo, si sentiva a disagio in casa della meretrice.
“Il problema è Messer Dante Alighieri e la sua Commedia.
Da più parti ci sono pervenute informazioni sul poeta. Non proprio rassicuranti. I Domenicani, che già hanno proibito la lettura della Commedia ai chierici, hanno in animo di compier una inquisizione.
Però il Gran Maestro, sapendo che anche Firenze ha da ridire sull’opera, ha preso contatto col Bargello, che ha deciso di incaricare voi Messer Matteo come rappresentante degli interessi di Firenze in questa faccenda.” “Questo è vero “rispose Matteo. “Ditemi dunque cosa preoccupa i reverendi padri della Inquisizione. Da parte mia, vi verrà dato tutto l’aiuto richiesto”
“Ecco Messer Matteo: In primis, risulta che Dante, Guido Cavalcanti e Lapo Gianni tutti poeti, a Firenze facessero brigata a sé, come risulta dal sonetto di Messer Dante Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io a cui Cavalcanti risponde S’io fossi quelli che d’amor fu degno.
Converrete che non sono parole che i maschi usano scambiarsi. Essendo i tre stati allievi di Brunetto Latini, noto sodomita, nasce qualche sospetto.” Matteo divenne attento e si rivolse a Eldengardo “proseguite prego”
Il domenicano proseguì “Secundum. Girano voci che Messer Dante Alighieri abbia simpatie per gli eretici e che abbia avuto corrispondenza scritta con catari e valdesi.
Risultano accennate alcune eresie catare nella Commedia.
Tertium. Risulta che sotto tortura in un procedimento inquisitorio avvenuto presso Firenze, una donna sciagurata abbia ammesso di essere La domina di una congrega di streghe e abbia confessato di averne confidato ad un poeta come si entra in una congrega. Non conosceva però l’identità di detto poeta, solo che era intimo di Cecco Angiolieri”. “confirmatur sub tormentis” precisò l’inquisitore.
Messer Matteo lo interruppe. “Grazie, penso che per dovere di reciprocità vogliate sapere perché anche il Bargello è interessato a Messer Dante Alighieri.” “Certamente e vi ascolto, sono tutt’orecchi” rispose Eldengardo . Messer Matteo proseguì nella esposizione. “Firenze ha motivi meno nobili per cercare notizie sul poeta. Vorremmo sapere quanto vi è di vero nelle sue maldicenze e lodi. Firenze mira alla pace nella la città e sarebbe interessata a far sparire quanto scritto pro e contro i nobili cittadini. Inoltre, si maligna che l’Alighieri grazie alla attività diplomatica presso le varie corti, abbia accumulato una fortuna non dichiarandola alle autorità. Questo per non pagare imposte. Ed ora il denaro ci abbisogna. Vorrei ora Padre Eldengardo rispondere, per quanto so, alle vostre osservazioni.”
“Di Dante sodomita direi essere una fola. Casomai, il poeta sotto la veste di seriosità e amore spirituale risulta a detta di servitori a lui vicini essere stato uomo di virile rapacità interessato alle femminette. Specie se ben tornite. Inoltre, Messer Brunetto Latini era sì sodomita ma amava i ragazzini imberbi e Dante e i suoi amici, al tempo erano uomini fatti, puttanieri e non sodomiti.
Per quanto riguarda le frequentazioni di eretici, dovreste chiedere agli uomini di chiesa. Ai funzionari dei Firenze, risulta un Dante critico dei costumi della Chiesa e chi non lo è? Per quanto riguarda catari e albigesi confondono la frequentazione di poeti provenzali con quella di eretici provenzali.
Padre Eldengardo, mi avete fatto curioso. Parlatemi di Dante e la congrega delle streghe. Qualcosa conosco per via di un processo che ho tenuto a Borgo Silva presso Firenze Ma non mi basta.” “Bene ecco i fatti visto che siete curioso.” Padre Eldengardo sembro pronto a narrare, ma ricordandosi cosa gli avessero insegnato in convento su come ottenere l’attenzione degli ascoltatori, dapprima bevve lentamente un secondo calice di vino. Poi, si guardò le mani muovendole come facesse gesti scaramantici o desse benedizioni. Chiuse gli occhi come se cercasse in sé la verità, e finalmente iniziò. “La strega ravveduta, già domina del sabba, ci ha spiegato che la entrata nella congrega avviene come segue:
il giovane ancora impubere viene avvicinato da una persona che risulterà in seguito sempre sua amica. Quando arriva al momento di decidere della sua vita e non sa quale via intraprendere perché gli sembra di vagare per una selva oscura, gli compare una guida che lo salva dai pericoli e gli promette di istruirlo. Il giovane affronta diverse prove fisiche e spirituali. Varca porte che lo immettono in nuovi cammini, viene istruito sul bene e il male. In fine quando viene considerato pronto, incontra la domina che amandolo lo trasforma, facendo di lui un uomo nuovo. Successivamente lo rinvia alla sua comunità. Là, tutti lo riconoscono come rinato. “L’inquisitore fece una pausa e riprese. “Ora Messer Matteo non vi suona familiare: Dante incontra Beatrice che si manifesta come domina dei suoi sentimenti.
Poi vive diverse esperienze, positive e negative. Queste lo confondono. Così che e giunto alla età della ragione si trova immerso in una foresta che è immagine della confusione della sua mente e non sa quale via prendere. Compare la guida Virgilio che lo difende dagli animali pericolosi, lo accompagna, gli permette di varcare lo Stige e lo fa ascendere dal male o ignoranza alla rivelazione passando la prova del Purgatorio. In Paradiso trova Beatrice che si rivela a lui. Dopodiché ritorna a noi istruito e saggio. Detto semplicemente: incontra il membro della congrega destinato a guidarlo. Al momento di scegliere, l’inviato della congrega porta il giovane ad un viaggio di iniziazione ai misteri del culto delle deità pagane, facendogli affrontare prove pericolose e istruendolo. Infine, lo porta alla domina che lo esaminerà e deciderà se farlo entrare nella congrega. Troppe somiglianze per non essere sospettosi.” “Può darsi che abbiate ragione” rispose Messer Matteo.
“Ma quanto raccontate, mi ricorda molto la tragedia greca. Come in quella, viene narrato un rituale di rinnovamento, rigenerazione, morte e rinascita. Cioè l’incontro col maestro, la rigenerazione tramite prove, la morte il distacco dalla vita precedente, la rinascita come essere diverso o membro della congrega.”
“Ma” continuò Matteo “forse sono solo concetti mal digeriti e non compresi. Mi ricordano un aneddoto raccontatomi da un missionario inviato nelle isole a meridione della Arabia Felix.” “Forse vale anche per la vostra strega confessa”.
“Caro Padre inquisitore, mi sembra che non si sia approdati a molto.”- Fu la constatazione di un Messer Matteo stufo di Dante e della Commedia.
“Propongo di incontrarci il prossimo anno prima di Pasqua per scambiarci quanto di nuovo appreso.” “Sia” rispose Eldengardo e si accomiatò.
L’anno seguente, poco dopo Pasqua, si rincontrarono al convento di San Bartolomeo presso Pontassieve.
Eldengardo a causa dei numerosi digiuni a cui si era sottoposto era ancor più smagrito pallido e allampanato mentre Messer Matteo andando per la cinquantina portava un accenno di corpulenza, frutto di gaia vita. Dopo essersi complimentati per il reciproco aspetto e ristorati con buoni cantuccini mandorlati e vin santo, passarono all’argomento Dante Alighieri.
Il domenicano trasse dalla bisaccia alcuni fogli di appunti che fece leggere a Messer Matteo.
“Cosa ne dite? Ho valutato quanto mi opinaste nel nostro incontro”. Matteo lesse e restituì i fogli. “Grazie Padre Eldengardo, vedo che avete accettato le mie parole sulla presunta sodomia ed eresia dell’Alighieri. E anche, malgrado la mia insolenza, la opinione su Dante nella congrega delle streghe.”- Il domenicano ripose i fogli nella bisaccia e vi fu un momento di silenzio dedicato a gustare il vin santo che un novizio aveva versato da una brocca smaltata. “Messer Matteo, ora che sapete il mio, ditemi del vostro.” “Non vi è molto da dire reverendo Padre. Come dissi al nostro incontro, per Firenze si trattava di evitare nuove frizioni fra cittadini illustri e trovare il presunto tesoro.
Accorti letterati da noi ben pagati hanno scritto commenti alla Commedia spiegando che i nomi che vi compaiono sono solo fantasie, nomi scelti a caso per indicare esempi di peccato ancorché non reali. Per la pecunia, riverito Padre, Messer Dante Alighieri, in punctum mortis aveva fatto testamento lasciando a moglie e figli proprietà, denari e il testo non finito della Divina Commedia.
In una postilla aveva lasciato un bracciale in argento a una donna di nome Florina, incaricando il notaio di Ravenna Goffredo di Bartolo di darle a voce “post mea mortem”, alcune sue parole. Con buone maniere e qualche attenzione in forma di fiorini d’oro abbiamo ottenuto l’indirizzo di questa Florina.
Sono riuscito a trovarla a Ravenna e lei mi ha raccontato una storia quasi inverosimile.
Da verginella tredicenne Florina aveva preteso di udire la voce della Madre di Dio e si era messa nuda a predicare la buona Novella invitando la gente a denudarsi per umiliarsi e pentirsi dei peccati.
Ripresa dal vescovo e sottoposta a interrogatori dagli inquisitori, aveva confessato la verità : Povera e senza mezzi lo aveva fatto per nutrirsi delle offerte dei creduloni.
Pentita aveva presso gli inquisitori fatto ammenda e poiché il vescovo considerava il tutto una debolezza di ragazza, non meritevole di essere diffusa, fu deciso, dopo applicate le sanzioni spirituali, di espellerla. Il vescovo impietosito le dette qualche soldo e la raccomandò come serva a una dama di Ravenna.
Ecco ora la novità. Presso la dama, Florina incontrò l’Alighieri che da puttaniere quale era, si incapricciò della verginella portandola ad una casa di amici, per poi frequentarla. In seguito, la spulcellò facendosene la sua amante. Prima di morire le indicò di andare dal notaio dove avrebbe trovato un cofanetto a lei destinato. Conteneva disse il poeta, un tesoro che le avrebbe permesso di ben vivere se lo avesse giudiziosamente utilizzato. Florina alla morte del l’Alighieri lo aveva aperto ma invece degli sperati fiorini, aveva trovato un breve scritto e un libro dove erano stati scritti, lei pensava, dei nomi. Mi stupii di questa decisione e ancor più si stupì Florina che non sapendo leggere era rimasta perplessa e delusa del regalo del poeta. Aveva tenuto lo scritto, il libro, e il cofanetto in ricordo di Dante che si era mostrato amante gentile e premuroso. Mi feci mostrare il tutto. Lo scritto la invitava a presentare il libro ai nomi iscritti. Bastava questo per ricevere fiorini in regalo. Sul libro l’intestazione recava la scritta “persone della commedia”. Erano I buoni e i cattivi. Il libro conteneva infiniti nomi ognuno seguito sul foglio da una cifra. Non ci misi molto a capire che Messer Dante per soddisfare i suoi capricci e le sue voglie, non aveva utilizzato come sosteneva i proventi dell’ incarico di ambasciatore e consigliere, ma che era un ricattatore. Ogni personaggio era registrato per la somma pagata. er essere tra i buoni o per metterei suoi avversari tra i malvagi.”
Padre Eldengardo si dichiarò soddisfatto.” Ora che abbiamo chiarito tutti i misteri su Messer Dante Alighieri, penso che ora la Santa Madre Chiesa possa indicarlo come promotore della ricerca di Dio. Voi cosa farete?” “Noi“ rispose Matteo “lo presenteremo come virtuoso campione della fiorentinità e grande poeta.”
“Ma ?”- chiese l’inquisitore.
“Nessun problema. Abbiamo fatto il giro degli iscritti e degli eredi. Per un modesto obolo alle finanze del comune di Firenze abbiamo cancellato il nome ed a opera finita abbiamo bruciato il libro.” Matteo sorrise beffardo.
“Bene“ disse Eldengardo.
“Abbiamo il nuovo Messer Dante Alighieri.
Avveduto politico al servizio di Firenze, Poeta e scrittore. Propugnatore della lingua volgare. E anche uomo degno e meritevole che onorando Santa Madre Chiesa, ha scritto una opera intesa alla ricerca della beatitudine. Questo narrando di esempi di perfezione spirituale e di condanne esemplari per i peccatori.” Concluse l’inquisitore anche lui sorridendo beffardo.
“Insomma, tutto è bene quello che finisce bene. Il ricordo benché falso vive. Parce sepulto Messer Dante Alighieri” concluse Matteo e ripartì.
Morte al campiello, DANTESCA
Venezia 1423, il nove di maggio verso sera. In quello spiazzo, a quell’ora, di fronte a Ca’ Ponzia detta Ca’ delle Mone, veementi discutevano urlando una tonaca rossa da Monsignore e un giubbotto bruno da medico o alchimista.
Li avevo sentiti. Non parlavano delle tette e del culo di Ponzia, la meglio puttana di Venezia. Così, perché i capi di sestiere non intervenissero, li trascinai all’ Osteria della Scrofa Marina dove, nella saletta sul retro riservata solo agli amici dell’oste, avrebbero, complici due gottini di grappa di anice, potuto chiarirsi.
Io, intanto, attendendo che si calmassero, istruivo Tonio l’apprendista cuoco che avevo raccomandato al taverniere su come preparare il baba ganush, cioè l’insalata di melanzane secondo la ricetta segreta che un vecchio a Balat quartiere dei giudei a Costantinopoli, da dove io marrano spagnolo ero partito per la bella Venezia.
“Vedi Tonio, cura di prendere due melanzane medie per commensale, grigliale su buona carbonella di legno di faggio. Poi togli la scorza bruciata e poni la polpa, dopo averla acconciata in piccoli tocchi, in un mortaio in pietra di giusta misura. Poi pesta e pesta la polpa sino a farne una crema.
“Padrone questo so farlo” disse Tonio. “ Zitto che non sai niente” lo rimbeccai “Secondo l’uso di là, alla melanzana pestata aggiungi un cucchiaio da zuppa di olio pugliese non filtrato e mescola bene sino ad amalgamare. Aggiungi di sale una presina, di pepe macinato una generosa spolverata. Quando la crema sarà lucida dell’olio assorbito aggiungi un pizzico grande di rosso zafferano che darà colore dorato alla melanzana. E infine aggiungi per sfumare un goccio di agresto. Versa nel fangotto di terraglia smaltata, condisci con cetriolo a fette, barbabietola e spicchi di limone. E qui mi fermai, volgendo l’attenzione ai miei due amici, entrambi discendenti di famiglie di Templari, che dimenticavano di essere sempre sotto l’occhio dell’Inquisizione. Ma io, marrano, mi spaventavo se il languido sguardo dell’Inquisitore si posava anche solo casualmente sul mio viso.
Ero pronto alla solita disputa sboccata di bigoli e mone, ma il motivo del contendere mi fece zittire. “Loci silentia late”, quindi silenzioso attesi. Diceva l’astrologo che girava voce secondo la quale Dante, il creatore della Divina Commedia, sarebbe stato portato all’onore degli altari. Risi. Era idea da bigotti, ma il Monsignore, vero uomo di chiesa, apparteneva segretamente alla congrega di Diana la strega Domina del Zogo. E questa notizia lo irritò. L’astrologo era un uno scienziato negatore di Dio, ateo e discendente di catari. E l’unico a sapere della loro vera natura e dell’amicizia che li legava ero io, il marrano. Già vissuto come Mosè ben Absalom giudeo, che a Salonicco aveva nutrito le loro menti con la Cabbala, Maimonide e i maestri sufi. Ero l’amico che li aveva salvati dai genovesi durante la guerra di Chioggia. Oggi nuovamente pronto a salvarli. Astorre Sinibaldi, astrologo e a tempo perso scienziato, sosteneva che il poema era un invito a riformare la Chiesa, e il viaggio meraviglioso descriveva l’odissea dell’anima che, attraverso varie prove, prendeva coscienza del Divino. E forse Indicava così quale itinerario dovessero seguire i peccatori per aver aperte le porte del Paradiso. Tutto ciò raccontato in lingua volgare comprensibile a tutti. A scorno della risaputa ottusità dei chierici avversi ad illuminare le menti avide di sapere.
“Ma scusate”, dissi, “A ben leggere la Commedia vedo più peccati che beatitudini. O forse non ho capito?”
“Ma taci! Tu, marrano d’un giudeo” scherzò Mattia il Monsignore. “Certo che non vedi, intento come sei a contare i denari dell’usura”. Non risposi. Tanto a che serviva. Pensai solo al divino poeta Dante che aveva scritto: “Uomini siate, e non pecore matte, sì che l’Giudeo di voi tra di voi non rida!”.
Mattia il Monsignore sembrò voler dire qualcosa di importante. Si versò un secondo gottino di anice, e tracannatolo in un lampo apostrofò rudemente Astorre:
“Imbecille amico, ma non ti rendi conto che Dante è uno stregone seguace di Diana? Basta leggere bene. Rinfrescati la memoria, rileggi Orazio e Lucano sulla dea Diana signora delle Selve, e anche Apuleio. Come scienziato dovrebbe piacerti leggere quello che la Chiesa proibisce.”
“Taci astrologo! Non rispondere, che io sono Monsignore! Ti ricordi come finiscono i poemi occitani? e le fiabe che si raccontano e le confessioni delle strie sotto il ferro dell’inquisitore?”
“Tu Astorre, hai letto la Commedia di Dante. Ti basteranno perciò alcuni chiarimenti per toglierti dal viso quello stupido sorriso e capire quello che intendo quando parlo del poeta come seguace di Diana e membro della congrega. Ecco, per entrare a farne parte questa è la via: sin da piccolo vieni scelto. Dapprima incontri senza saperlo Diana o la sua gran sacerdotessa. In seguito, quando ad un certo momento inizi a porti domande sul tuo posto in questo mondo, incontri una guida, un sapiente, un mago che ti accompagna in un viaggio periglioso fra lande desolate, dove vieni sottoposto a molte prove e devi sconfiggere infiniti nemici. Arrivi infine ad un Illuminato che ti esamina e, se ritenuto idoneo e meritevole, ti traghetta verso la strada che porta al Palazzo della Sapienza. Lungo la strada e nel Palazzo vieni istruito. Infine, incontri Diana la signora del Zogo, che ti svela gli ultimi misteri e ti fa rinascere come essere nuovo. Rinato e mutato nell’anima, puoi ritornare nel nostro mondo. Considera dunque Beatrice come Diana, Virgilio come guida, Caronte il traghettatore come esaminatore, Inferno e Purgatorio come la strada dell’apprendimento, il Paradiso come Palazzo della Sapienza rivelata. Là dove Beatrice, La Maestra della congrega degli adoratori di Diana, ti accoglie tra questi, e infine, coronato di sapienza e colmo della reale visione dell’Universo, ridiscendi in questo mondo a portare la novella che la Domina Diana è presente”.
Per me, Mosè ben Absalom adoratore del Vero Dio, dentro e marrano cristiano fuori, quelle parole sembravano oziose speculazioni di filosofastri.
Astorre sembrava una statua di sale che bene avrebbe figurato a Sodoma, finché Mattia, preso in un vortice di esaltazione, gridò: “Noi, i fedeli della Signora del Zogo, veniamo arsi e perseguitati, e lui, il poeta che si fa beffe di noi, è considerato dai lettori degno degli altari. Ma verrà il giorno in cui i saggi nutriti dal primigenio sapere lo smaschereranno”.
Fu allora che Astorre Sinibaldi, finto astrologo e vero sicario dell’Inquisizione, affondò lo stiletto nel petto di Mattia. Uccidendolo, affinché la vera natura della Divina Commedia restasse segreta.
Pensai: “Dopo un Monsignore morto, ora ci sarà un giudeo accoppato”. Così, con la daga che tenevo nascosta, tagliai la gola ad Astorre. Misi la daga in mano a Mattia e uscii dalla stanza, urlando che i compari si stavano uccidendo.
Il taverniere mi ignorò e lasciò che fuggissi portando con me il fangotto di melanzane. Non conveniva aver ospitato un giudeo, e, dopo un’occhiata alla stanza insanguinata, visto che non aveva altri avventori, chiuse la porta e andò a chiamare le guardie.