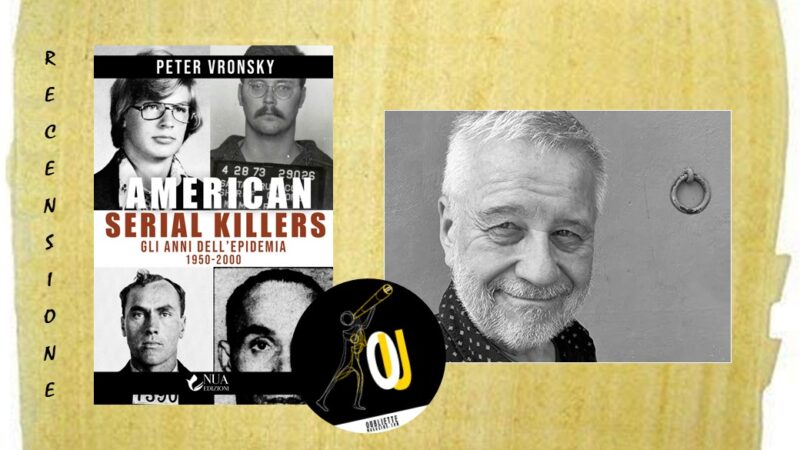Significato dei sogni #24: il sogno in stato di veglia di Mircea Eliade
“Con una interpretazione unilaterale e un poco semplicistica che gli psicologi hanno in seguito corretto e completato, Freud interpretava la salita di una scala come l’espressione travestita dal desiderio sessuale.” ‒ Mircea Eliade

Ventiquattresima puntata della rubrica “Significato dei sogni” nella quale si presenta un estratto del racconto Dūrohana e il sogno in stato di veglia tratto dal Capitolo VI “Simboli dell’ascensione e sogni in stato di veglia” del volume “Miti Sogni e Misteri” di Mircea Eliade (Rusconi, 1974).
Dando per scontato che il lettore conosca lo storico delle religioni, antropologo, mitografo e filosofo romeno Mircea Eliade (1907-1986) si sottolinea solo la precocità dell’autore, infatti, a 14 anni pubblicò il racconto “Come ho scoperto la pietra filosofale”. Vinse una borsa di studio per studiare filosofia indiana con il filosofo Surendranath Dasgupta (1887-1852) a Calcutta grazie alla tesi di laurea in Filosofia intitolata “La filosofia italiana da Marsilio Ficino a Giordano Bruno”. Romeno, francese, tedesco, inglese, ebraico, italiano, sanscrito e persiano sono le lingue di suo uso comune sia nel parlato sia nello scritto.
L’estratto che ivi si presenta Dūrohana e il sogno in stato di veglia percorre le teorie e le esperienze di Julien Green, Sigmund Freud, Robert Desoille, Gaston Bachelard, Carl Gustav Jung connesse al mondo indiano. In particolare la parola sanscrita Dūrohana, che non sarà trattata in questo estratto, ha il significato di “via difficile” connessa alla via iniziatica che eleva chi la intraprende alla vera conoscenza, cioè una conoscenza libera dai dogmi dell’epoca e luogo in cui si vive.
Mircea Eliade ne “Il mito dell’eterno ritorno” (Rusconi, 1975) scrive: “Il «centro» è la zona del sacro per eccellenza, quella della realtà assoluta. […] La via che conduce al centro è una «via difficile» (Dūrohana) e questo si verifica a tutti i livelli del reale. […] Il cammino è arduo, disseminato di pericoli, poiché è un rito di passaggio dal profano al sacro, dall’effimero e dall’illusorio alla realtà e all’eternità, dalla morte alla vita, dall’uomo alla divinità”.
***
Estratto da “Dūrohana e il sogno in stato di veglia”
Sappiamo che il volo, l’elevazione e l’ascensione su gradini sono temi abbastanza frequenti nei sogni. Succede anche che uno di questi temi divenga il motivo dominante dell’attività onirica o immaginativa.
[…]
Julien Green[1] osservava nel suo Journal, al 4 aprile 1933: «In tutti i miei libri l’idea della paura o di altre emozioni piuttosto forti sembra legata in modo inesplicabile a una scala. Me ne sono accorto ieri, passando in rassegna i romanzi che ho scritto… Mi domando come ho potuto così sovente ripetere questi effetti senza accorgermene. Da fanciullo sognavo di essere inseguito su una scala. Mia madre ha avuto le stesse paure in gioventù; me ne è rimasto forse qualcosa…».
Dopo quanto abbiamo appena detto sui «sette passi del Buddha»[2] si comprende perché nei libri di Julien Green la scala sia legata all’«idea della paura o di altre emozioni piuttosto forti». La scala è per eccellenza il simbolo del passaggio da un modo d’essere a un altro. Il mutamento ontologico avviene soltanto con un rito di passaggio; infatti nelle società tradizionali la nascita, l’iniziazione, la sessualità, il matrimonio, la morte costituiscono altrettanti riti di passaggio. Si cambia modalità soltanto in seguito ad una rottura, che provoca sentimenti ambivalenti di paura e di gioia, di attrazione e di repulsione. Proprio per questa ragione la scalata non simboleggia soltanto, come abbiamo visto, l’accesso alla sacralità ‒ la rottura di livello per eccellenza ‒ ma anche la morte.
Numerose sono le tradizioni in cui l’anima del morto sale i sentieri di una montagna o si arrampica su un albero. Il verbo «morire» si esprime in assiro con «aggrapparsi alla montagna», e in egiziano «aggrapparsi» è un eufemismo per «morire». Nelle opere di Julien Green, come osserva lui stesso con stupore, tutti gli avvenimenti drammatici ‒ morte, delitto, dichiarazione d’amore, apparizione di un fantasma ‒ avvengono su una scala. In altri termini, l’immaginazione dello scrittore ritrova spontaneamente la stessa immagine esemplare della scala ogni volta che uno dei suoi personaggi affronta un’esperienza decisiva che lo fa diventare un «altro».
Con una interpretazione unilaterale e un poco semplicistica che gli psicologi hanno in seguito corretto e completato, Freud interpretava la salita di una scala come l’espressione travestita dal desiderio sessuale. Ma anche il significato puramente sessuale decifrato da Freud non contraddice il simbolismo della scala nel suo insieme, poiché anche l’atto sessuale costituisce un «rito di passaggio». Concludere che il paziente che in sogno sale i gradini di una scala soddisfa in tal modo un desiderio sessuale sepolto nel suo inconscio è pur sempre un modo per dire che nel più profondo del suo essere egli si sforza di uscire da una situazione «pietrificata», da una situazione negativa, sterile. Nel caso di una psiche in crisi, tale sogno, ‒ sempre con il significato puramente sessuale attribuito da Freud ‒ indica che lo squilibrio psichico potrebbe risolversi con l’atto sessuale del desiderato, cioè per mezzo di una modificazione così profonda della situazione del paziente da poter essere assimilata a un cambiamento di comportamento, cioè di un modo d’essere. In altri termini, l’interpretazione freudiana dell’immagine della scala in quanto segno di un desiderio sessuale inconscio si collega perfettamente tra i molteplici significati di «passaggio» illustrati dalla scala nei riti e nei miti.
Resta da sapere se il metodo riduttivo della psicoanalisi freudiana spieghi completamente la funzione del simbolo. Il problema è troppo complesso perché possiamo affrontarlo in queste poche pagine dedicate ai simboli del volo e dell’ascensione. Ricordiamo tuttavia che R. Desoille[3] utilizza con successo la tecnica del «sogno in stato di veglia» e che ha ottenuto guarigioni anche in casi in cui il trattamento psicoanalitico non aveva ottenuto alcun miglioramento apprezzabile. Il tipo di «sogno in stato di veglia» che Desoille chiede più frequentemente ai suoi pazienti d’immaginare è proprio la salita di una scala o l’ascensione di una montagna. In altri termini, si ottengono guarigioni psichiche rianimando con l’immaginazione attiva certi simboli che comprendono nella loro struttura l’idea di «passaggio» e di «mutamento ontologico». Considerati sul piano di riferimento dello storico delle religioni, tali simboli esprimono nello stesso tempo situazioni accettate dall’uomo e le realtà che affronta, che sono sempre realtà sacre perché ai livelli arcaici di cultura il sacro è il reale per eccellenza. Potremmo perciò dire che la semplice ripetizione di certi simboli religiosi (più esattamente: attestati abbondantemente in innumerevoli religioni) mediante l’immaginazione attiva sfocia in un miglioramento psichico e conduce infine alla guarigione. In altri termini, la psicagogia[4] del sogno ascensionale «in stato di veglia» sarebbe un’applicazione di una tecnica spirituale al campo dell’attività psichica inconscia.
È quanto evidenzia ancor più chiaramente l’esperienza di R. Desoille, che ai pazienti suggerisce di immaginarsi non soltanto intenti a salire scale e montagne, ma anche intenti a «volare». Gaston Bachelard[5] definiva giustamente la tecnica del sogno in stato di veglia come una forma dell’«immaginazione del movimento». «L’elevazione dell’anima va di pari passo con la sua serenità. Nella luce e nell’elevazione si forma un’unità dinamica.»
Precedentemente abbiamo scoperto i significati del volo[6] e dell’ascensione nel folclore, nella storia delle religioni e nei mistici e abbiamo potuto constatare che si tratta sempre di immagini della trascendenza e della libertà. Se vogliamo evitare il causalismo semplicistico proposto dal metodo riduttivo siam obbligati ad arrestarci a questa conclusione: sui piani diversi ma strettamente connessi all’onirico, dell’immaginazione attiva, della creazione mitologica e folclorica, dei riti e della speculazione metafisica, infine sul piano dell’esperienza estatica, il simbolismo dell’ascensione significa sempre l’esplosione di una situazione «pietrificata», «ostruita», la rottura di livello che rende possibile il passaggio a un altro modo d’essere; in una parola, la libertà di «muoversi», cioè di cambiare situazioni, di abolire un sistema di condizionamenti.
Si noterà che ritroviamo in contesti molteplici ‒ onirico, estatico, rituale, mitologico, et cetera ‒ significati complementari ma strutturalmente connessi e raggruppabili tipologicamente. Anzi, è possibile interpretare tutto ciò che un tipo ci presenta in una specie di messaggio cifrato soltanto «decifrando» a uno a uno i significati particolari secondo e sul proprio piano di riferimento, e poi componendoli in un insieme. Infatti ogni simbolismo «fa sistema» e si può realmente comprenderlo soltanto nella misura in cui lo si considera nella totalità delle sue applicazioni particolari.
Ammesso questo, è ovvio constatare che il simbolismo dell’ascensione rivela il suo significato più profondo quando viene interpretato nella prospettiva della più «pura» attività dello spirito. Sembra che esso liberi il suo «vero messaggio» sul piano della metafisica e della mistica. Si potrebbe anche dire che proprio grazie ai valori espressi dall’ascensione nella vita dello spirito (elevazione dell’anima a Dio, estasi mistica, et cetera) gli altri significati, colti sui piani del rituale, del mito, dell’onirico, della psicagogia, diventano completamente intelligibili, rivelano le loro intenzioni segrete. Infatti salire una scala o una montagna in un sogno, o in un sogno in stato di veglia, equivale, al livello della psiche profonda, a un’esperienza di «rigenerazione» (risoluzione della crisi, reintegrazione psichica).
[…]
Gli psicologi del profondo concordano infatti nel dichiarare che i dinamismi dell’inconscio, contrariamente a quanto avviene nell’esperienza cosciente, non sono retti dalle categorie dello spazio e del tempo. Anzi, Carl Gustav Jung afferma espressamente che, quando si tocca la soglia dei contenuti dell’inconscio collettivo, si ha l’«esperienza dell’eternità» proprio a causa del carattere atemporale di tale inconscio, e che appunto la riattivazione dei suoi contenuti sfocia in una rigenerazione totale della vita psichica. Questo è certamente vero, ma sussiste una difficoltà: esiste infatti una continuità fra le funzioni assolte o i messaggi trasmessi da certi simbolismi ai livelli più profondi dell’inconscio e i significati che quelli rivelano sul piano delle più «pure» attività dello spirito. E questa continuità è perlomeno sorprendente, poiché gli psicologi constatano generalmente opposizione e conflitto fra i valori dell’inconscio e del conscio e i filosofi oppongono spesso lo spirito della vita oppure alla materia vivente.
[…]”
***

Per continuare la lettura in modo proficuo e con attenzione si consiglia di distogliere gli occhi dal computer o dal cellulare e di recarsi nella propria libreria per cercare il libro tra gli scaffali impolverati; se non si possiede il volume in casa si consiglia di acquistarlo (rigorosamente in cartaceo).
Leggere è un compito importante, la carta è di grande ausilio rispetto al formato digitale non solo per la concentrazione necessaria all’atto della riflessione e comprensione ma anche per instaurare un rapporto fisico con l’oggetto-pozzo che conserva amorevolmente le considerazioni degli esseri umani del passato, in questo caso di Mircea Eliade.
Un ulteriore consiglio: un bel quaderno (cartaceo) con penna (o matita) posto sul comodino per annotare i sogni al risveglio (con data ed orario). È importante non perdere l’uso della scrittura sia per la manualità delle dita sia per la stimolazione del cervello astratto e creativo.
Inoltre, è possibile partecipare al nostro nuovo studio sulla casistica del sogno in contatto con la tecnologia dei social inviando un’e-mail ad oubliettemagazine@hotmail.it nella quale allegare un file .doc con un sogno connesso alla tecnologia (smartphone, internet, pc, social, intelligenza artificiale, et cetera). Il sogno raccontato sarà salvato in forma anonima e servirà per la compilazione di un testo in comparazione alla letteratura del passato.
***
Nella prima puntata della rubrica si è presentato un estratto tratto dal primo capitolo “La letteratura scientifica sui problemi del sogno” del libro “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud; nella seconda un estratto tratto dal primo paragrafo intitolato “Il rapporto tra sogno e veglia” dello stesso capitolo; nella terza puntata si è presentato un estratto tratto dal secondo paragrafo intitolato “Il materiale onirico. La memoria nel sogno” dello stesso capitolo; nella quarta si è selezionato un estratto da “Relazione, imago e proiezione” del febbraio 1959, tratto dal capitolo “Attività medica e analitica” del libro “In dialogo con Carl Gustav Jung” di Aniela Jaffé, che mostra il sogno in rapporto con l’ex partner; nella quinta si è ripreso il discorso con Sigmund Freud con un estratto estratto tratto dal quarto paragrafo intitolato “Perché si dimentica il sogno dopo il risveglio” del primo capitolo “La letteratura scientifica sui problemi del sogno”; nella sesta si è selezionato un estratto dal primo capitolo intitolato “Sogni lucidi e la loro impostazione filosofica” del libro “Sogni lucidi” dalla parapsicologia e scrittrice britannica Celia Green; nella settima si è presentato un estratto tratto dal secondo capitolo “L’uomo e l’esperienza” del libro “Sogni, profezie e apparizioni” di Aniela Jaffé affrontando la tematica della precognizione della morte; nell’ottava si è ripreso il libro “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud con un estratto tratto dal terzo paragrafo intitolato “Stimoli e fonti del sogno” del primo capitolo “La letteratura scientifica sui problemi del sogno”; nella nona un estratto tratto dall’introduzione del libro “Alchimia” di Marie-Louise von Franz mettendo l’accento sulla trascrizione del sogno; nella decima si è presentato un estratto tratto dal libro “La schizofrenia” di Carl Gustav Jung, dal capitolo “Psicogenesi della schizofrenia”; nell’undicesima si sono mostrate “Le peculiarità psicologiche del sogno” tratto del libro “L’nterpretazione dei sogni” di Sigmund Freud; nella dodicesima si è parlato del libro “Il codice dei sogni” di Charles Maillant finendo nel paragrafo Diventare ciechi; nella tredicesima il capitolo Anatomia di un sogno tratto dal libro “I sogni” di Edgar Cayce e Mark Thurston, nella quattordicesima si è presentato il tema della resposanbilità ed inconscio dal libro “Elogio dell’inconscio” di Massimo Recalcati; nella quindicesima si è parlato dell’assenza di sonno trattata da Simon Monneret; nella sedicesima si è toccato il tema della maternità in carcere con Lella Ravasi Bellocchio; nella diciassettesima I sentimenti morali nel sogno espresso da Sigmund Freud, nella diciottesima Il simbolismo del cibo di Serena Foglia, nella diciannovesima Le discordanze della memoria di Igor Sibaldi, nella ventesima l’Incubo di Jorge Luis Borges, nella ventunesima Sognare di volare di Artemidoro, nella ventiduesima Sognare di morire di Artemidoro, nella ventitreesima Sognare di cambiare sesso di Charles Maillant.
“La Natura ti sia guida, seguila lieto ad arte:/ Fallirai se non ti sarà compagna di strada;/ La ragione ti sia bastone, fortifichi l’esperienza/ Gli occhi tuoi, che possa tu vedere in lontananza./ La lettura sia una chiara lampa nelle tenebre,/ Perché ti guardi dagli ammassi di parole e cose.” – Epigramma del quarantaduesimo Emblema de Atalanta fugiens
Note
[1] Julian Hartridge Green, francesizzato Julien Green, nasce il 6 settembre del 1900 a Parigi ivi muore il 13 agosto del 1998. Scrittore e drammaturgo statunitense, le sue opere saranno segnate dall’omosessualità e dalla fede cattolica.
[2] Paragrafo precedente del volume intitolato “I sette passi del Buddha”. “L’espressione «io sono il più alto del mondo» non significa alto che la trascendenza spaziale del Buddha. Egli ha raggiunto «la cima del mondo» attraversando i sette piani cosmici che corrispondono notoriamente ai sette cieli planetari.”
[3] Robert Desoille (1890-1966) è stato uno psicoterapeuta francese. Noto per la tecnica del sogno ad occhi aperti diretto, dapprima influenzato da Sigmund Freud e Pierre Janet, successivamente da Carl Gustav Jung. Si ricorda il testo “Teoria e pratica del sogno ad occhi aperti diretto” del 1961.
[4] Psicagogia è una cerimonia religiosa (rito) in cui si evoca l’anima del defunto, qui usato per la rievocazione del sogno della scala.
[5] Gaston Bachelard (1884-1962) è stato un filosofo della scienza.
[6] Paragrafo Il volo magico sito nel Capitolo VI “Simboli dell’ascensione e sogni in stato di veglia”.
Bibliografia
Mircea Eliade, Miti sogni e misteri, Rusconi, 1976
Michael Maier, Atalanta fugiens, Edizioni Mediterranee
Info