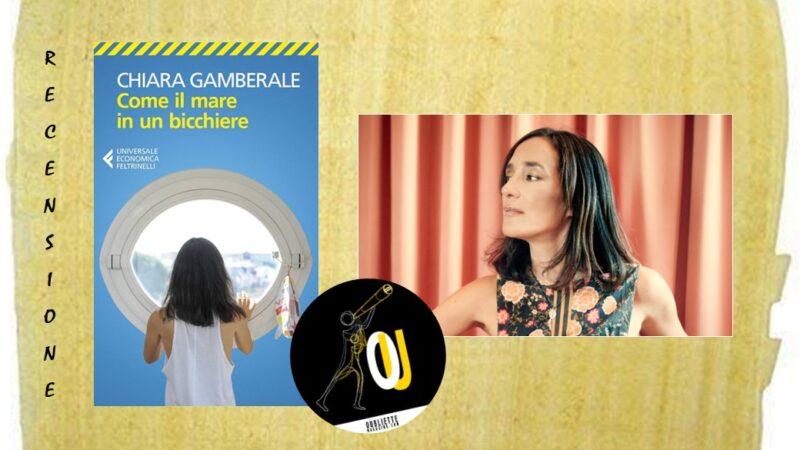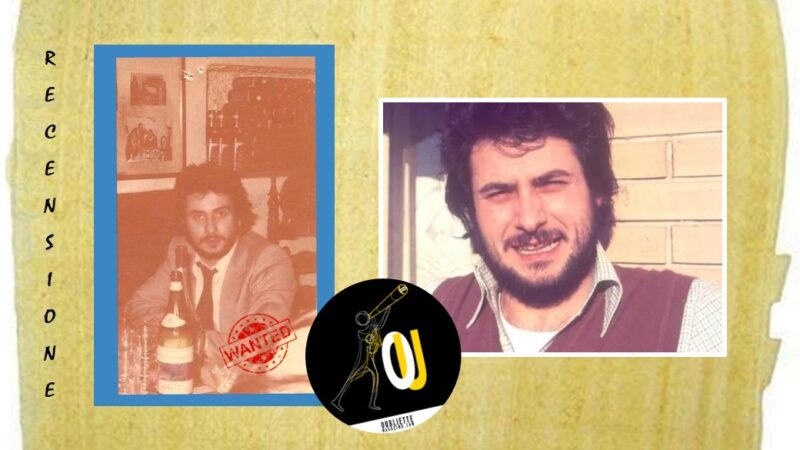Solitudine: casistiche e consigli utili per iniziare ad amare se stessi
“Con che occhi diversi si vede la vita a dieci, a venti, a trenta, a sessant’anni! I solitari hanno coscienza di questa metamorfosi psicologica.”[1] ‒ Henri-Frédéric Amiel

Dal latino solitudo, come derivato di solus, il termine solitudine indica al contempo una condizione di pienezza e di privazione. Infatti anche e solo prendendo in considerazione solus i linguisti non hanno ancora raggiunto un accordo: per taluni la radice è da identificarsi con il pronome sé (come in sécors, pigro di intelletto) per altri solus è identico a sollus (intero).
Che sia una pigrizia di intelletto intesa come non accettazione statica delle regole sociali oppure sia il sentirsi un intero, cioè una sorta di darsi forma da sé, la solitudine abita la creazione.
Poeti, musicisti, pittori, filosofi, asceti vivono questo stato dell’essere come necessario per il proprio benessere interiore e lo coltivano lasciandosi trasportare come se un incantesimo fosse stato prodotto appositamente per sollevare la coscienza dai pensieri del quotidiano.
L’ambiguità della solitudine, però, si manifesta nella doppia condizione espressa in incipit: pienezza e privazione. Perché se nel momento creativo ci si sente in comunione con il tutto, nell’attimo successivo si avverte un vuoto che non deriva dall’aver creato una forma nel mondo sensibile (parole, suoni, illustrazioni) ma, piuttosto, dal sentirsi distanti dagli altri esseri umani, come se la creazione in sé allontanasse dalla possibilità di comunicazione con l’altro.
“All’uomo intellettualmente dotato la solitudine offre due vantaggi: prima di tutto quello di essere con se stesso e, in secondo luogo, quello di non essere con altri.” ‒ Arthur Schopenhauer
Fresco di seconda ristampa (Tomarchio editore, 2025) vi presentiamo un brano tratto dal saggio di Giovanna Fracassi intitolato “Lettere a Sofia” nel quale si potrà leggere una riflessione dell’autrice vicentina che, in una lettera a Sofia, illustra le diverse realtà della solitudine e pone interessanti domande per il lettore toccando tematiche quali creatività, felicità, autorealizzazione. Chiude una breve critica letteraria sul brano.
Estratto da “Lettere a Sofia”[2]
“Cara amica mia,
la tua giornata pare all’insegna della malinconia nostalgica. Accade talvolta anche a me. Inutile opporsi, credo che vada accolta con gratitudine: sono morsi dolci che ci fanno riassaporare momenti felici, vissuti intensamente, il nostro passato più caro, e ci riportano l’eco delle persone che abbiamo amato e che ci hanno amato.
Discorso a parte per la solitudine. Penso che si debba distinguere. C’è la solitudine scelta e c’è quella subita. C’è quella occasionale e quella esistenziale, quella creativa e quella distruttiva. Può definirsi, come affermava Arthur Schopenhauer, come la capacità di stare bene con se stessi, di bastare a se stessi in primis. Da questo può derivare il piacere di stare con gli altri. Cosa realizzabile se, appunto, non si dipende dalla loro presenza per sentirsi sereni o felici.
Può accadere che il disperato tentativo di sottrarsi alla solitudine, sfoci in comportamenti alienanti, aggressivi per gli altri o addirittura autolesionistici. Tutto ciò accade quando non si riesce a comprendere che la solitudine non è né buona né cattiva, perché è una condizione ontologica dell’essere umano. Si può sfuggirle per brevi intervalli e comunque sempre a lei si torna. Ciò che spaventa è ciò che la solitudine in qualche modo anticipa: ossia la propria morte, annunciata dalla morte delle persone che si amano e di quelle che ci hanno generato.
Per me la solitudine è stata una costante, l’ho sempre amata, più che sopportata. Tuttora la preferisco e l’agisco. Direi che l’indosso con piacere. La solitudine interiore è una sorta di forza; senza la capacità e la determinazione di bastare a me stessa, non ce l’avrei fatta. Sono consapevole della solitudine ontologica dell’essere umano. La ritengo necessaria perché spinge al consorzio con gli altri dal punto di vista delle necessità pratiche di sopravvivenza. Dai tempi dell’uomo primitivo in poi, la collaborazione, la suddivisione dei compiti, l’organizzazione si sono sempre rese necessarie e la loro ottimizzazione è sempre stata garante di un perfezionamento delle varie civiltà. Inoltre induce l’uomo a cercare relazioni affettive, d’amore, d’amicizia, addirittura religiose quando l’oggetto d’amore è Dio. Entrambe queste vie sono la prova e nello stesso tempo, la risultante che l’uomo è costitutivamente, essenzialmente solo e rincorre per tutta la vita il superamento di tale solitudine che poi altro non è, lo ripeto, che la paura della morte che gli ricorda sia la sua finitezza che la sua transitorietà su questa Terra.
Poi c’è la solitudine scelta e voluta.
Io, per esempio, ho realizzato che non avevo molto in comune con quasi nessuno di coloro con cui venivo in contatto. C’era sempre una parte di me che rimaneva estranea ai discorsi con le altre mamme, con le altre colleghe, con i conoscenti o con i vicini. Mi mancava sempre un qualcosa e dopo essere stata in loro compagnia mi sentivo come se avessi buttato, sprecato il mio tempo. Iniziai così ad affilare o a recuperare la sensibilità per tutto ciò che mi circonda, mi portavo a casa sensazioni e osservazioni che mi arricchivano e davano un senso a ciò che avevo fatto o dovuto fare. Rielaboravo la crescita dei miei figli, cogliendone spunti sempre nuovi, mi mettevo al loro passo, guardavo tutto con i loro occhi e scoprivo altre immensità di significato e esperienziali. Mi sentivo, mi sento, espandere a dismisura con loro, forse addirittura più di loro. Ricordo momenti in cui mi sentivo esplodere dentro una voglia di vivere tutto, di capire e imparare tutto. Ma ciò aveva come presupposto il mio isolamento, almeno interiore.
Infine, c’è la solitudine creativa. Questa è evidente e conosciuta: da sola posso creare, altrimenti non riesco. È quella per cui alzo le mie paratie e mi guardo dentro e spesso poi ne scaturisce una poesia, o un pensiero, o un’immagine o una decisione.
Insomma, io penso che siamo esistenzialmente soli, non c’è via di fuga. Si cerca, si spera di aver trovato qualcuno o qualcosa che sia risolutivo e poi ci si accorge che è ancora altro quello che si vuole. È nella natura dell’uomo non sentirsi mai soddisfatto. Però si possiede anche la forza per reagire, la forza che viene dalla ragione o dal cuore o magari da entrambi e così ci si torna ad aprire perché ogni solitudine è apertura a sé e all’altro.
In conclusione, la solitudine è un tratto caratteristico dell’essere umano. Tutto sembra perso, smarrito e indefinito. Eppure, al fondo, c’è sempre la speranza. Ecco quindi i vari tentativi per superare questa sensazione, la ricerca spesso spasmodica di trovare in un altro da sé, la possibilità di non percepirsi nella propria nudità esistenziale. Spesso questi tentativi portano alla delusione e alla separazione, alla lacerazione da quelle persone o da quelle situazioni in cui si credeva d’aver trovato una risposta, mentre si tratta solo di una pausa, una sosta nella nostra ricerca, nel nostro viaggio.
Tutto questo non deve portare alla disperazione. Al contrario, dovrebbe essere ciò che fornisce un senso al nostro vivere, al nostro innato bisogno di aprirci all’altro, di occuparcene, di averne cura. Su queste basi si fonda la nostra socialità, il nostro senso di appartenenza a una famiglia, a un gruppo, a una società, a uno Stato. La speranza non è da me intesa nella sua valenza consolatoria o come generico afflato verso un futuro migliore. Trovo che questa accezione sia limitativa. La speranza è insita nella vita stessa: togliere a un uomo la speranza è come ucciderlo, bruciarne il germe vitale interiore. Avere speranza deve spronare l’individuo a cercare le soluzioni, le risposte e soprattutto spingerlo all’azione. Diversamente è un acquietarsi passivo sulla propria esistenza, un affidarsi a qualcosa o qualcuno altro da noi stessi.

È l’angoscia esistenziale che i più cercano di evitare perché straziante e spiazzante. Difficile accettare che tutto non abbia alcun senso se non quello fine a se stesso: vivere per vivere, che già di per sé, comunque, è impegnativo. Agli altri esseri viventi tutto questo ragionare è precluso. Agli umani, invece, è stata data questa capacità: ci sarà un motivo?
Sofia, vuoi parlare della felicità a cui aspiri? Secondo me la felicità è raggiungibile, in caso, solo per brevi istanti. Si deve sfatare l’idea che essa possa costituire un modo di stare o di essere definitivo. Ed è necessario sia così, altrimenti verrebbe meno, la molla dell’agire, del pensare stesso.
Io poi la collegherei al tema dell’autorealizzazione: conoscersi per sottrarsi alla pressione che viene dall’esterno e che ci propone modelli di realizzazione che non sono nostri, solo per spronarci ad una competizione che in realtà non ci dovrebbe appartenere, ma ci viene inculcata dagli altri, genitori per primi. Aver fiducia in se stessi è il nucleo primigenio attorno al quale si costruisce la propria individualità. È un processo che ha le sue radici nella primissima infanzia e che comunque necessita di continua introspezione, dato che è in divenire.
Tu sei ottimista o pessimista? A me rimproverano di essere pessimista. Io mi ritengo semplicemente realista. Se i problemi ci sono, inutile fare come lo struzzo, e se si sa che le cose potrebbero andare male, è giusto metterlo in conto.
La tua sempre affezionata amica
Giovanna”
***
Giovanna Fracassi con “Lettere a Sofia” ripensa con il sentire femminile le grandi tematiche della millenaria tradizione filosofica che, dai greci ai nostri giorni, si manifesta in un costante turbine che mescola il sentire di ogni epoca. Così in questa lettera troviamo, grazie all’espediente dell’incipit sulla descrizione della giornata pregna di malinconica nostalgia della sua interlocutrice, una interessante digressione sul tema della solitudine comparata al sentire nostalgico.
Partendo dalla differenza tra “solitudine scelta” e “solitudine subita” l’autrice cita il filosofo Arthur Schopenhauer per richiamare il concetto di “bastare a se stessi” ed è infatti su questo che ruota tutto il ragionamento affrontato secondo le diverse casistiche nelle quali si coglie la condizione della solitudine. Dapprima si sconsiglia di sottrarsi da questo particolare sentire, perché l’azione di negazione non può che generare malessere, l’autrice indica la strada dell’esplorazione per attuare uno dei più complessi meccanismi: l’accettazione. È, infatti, cardine la presenza dell’associazione solitudine/morte che interviene per esplicare la differenza sociale con le forme comunitarie umane.
Giovanna Fracassi racconta della sua esperienza, della sensibile mancanza provata in ambienti sociali, la riflessione verso la crescita e verso i mutamenti dei propri figli, perché molteplice è il rapporto dell’autrice con la realtà. Come tratto caratteristico dell’essere umano, la mancanza è presente in tutti, ma non tutti possono cogliere la bellezza del potersi guardare con estrema sincerità quando si tirano le somme delle proprie azioni, delle proprie emozioni, dei propri fallimenti.
Giovanna rinforza l’argomentazione con “siamo esistenzialmente soli, non c’è via di fuga”; un concetto caro alla sua matrice poetica e che si ritrova in svariate sillogi pubblicate precedentemente come, ad esempio, “Arabesques” (“[…] sul baratro irrequieto/ di una voragine/ di significato/ dove, infine,/ cercare/ l’altra parte di sé”[3] ed anche “[…] Odo il suo ardente desiderio/ d’infrangere la barriera/ e di sciogliersi,/ infine,/ disperdendosi/ nel mare della solitudine/ che da sempre l’attende.”)[4] ed “Opalescenze” (“[…] Non odo suoni umani,/ non vedo il mondo./ Da quassù/ posso udire soltanto/ il mio silenzio/ posso vedere solo/ il mio universo.”[5] ed anche “[…] Erra,/ ramingo viandante/ e cerca/ e domanda/ e implora.// […])[6]; in raccolte di racconti come “Introspezione” (“Vuote come le sue stanze dove andava a cercare le cose che le ricordavano la sua vita, le memorie amalgamate alle attese e alle speranze, i sogni che, come soffi di note cristalline, abitavano la sua anima, alla fioca luce delle candele che, come pietosi lumini, l’accompagnavano nelle notti scure di solitudine.”)[7] oppure in saggi filosofici come “Essere e corpo in J. P. Sartre” in passi come “La conoscenza è intuitiva e l’intuizione implica l’idea della presenza immediata delle cosa come essa è. La percezione è un originario cogliere l’oggetto come tale, è un atto intuitivo, immediato, spontaneo.”[8] nel quale la conoscenza si rivela come intuitiva se connessa alla solitudine della pratica della riflessione, la percezione, dunque, deve primariamente abitare la comprensione dell’atto spontaneo e solamente una persona dedita all’osservazione solitaria del proprio sé e del mondo circostante può avvalorare l’immediatezza e tutto ciò che ne deriva.
In chiusura del brano ivi presentato tratto da “Lettere a Sofia”, Giovanna Fracassi tramite una domanda rivolta alla destinataria (ed a tutti i lettori) ‒ “Tu sei ottimista o pessimista?” ‒ propone la connessione tra l’attitudine del solitario ed il pessimismo di stampo leopardiano, nel quale il nichilismo entra in connubio con la dimensione del reale e, dunque, con la possibilità di risoluzione di qualsiasi problematica tramite la forza della continua introspezione.
Written by Alessia Mocci
Info
Note
[1] Henri-Frédéric Amiel, Frammenti di un giornale intimo, a cura di C. Baseggio, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1967, p. 171
[2] Giovanna Fracassi, Lettere a Sofia, Tomarchio Editore, 1ª ed. 2022, ristampa 2025, p. 58
[3] Giovanna Fracassi, Arabesques, Rupe Mutevole Edizioni, 2012, p.16
[4] Ibidem, p. 24
[5] Giovanna Fracassi, Opalescenze, Rupe Mutevole Edizioni, 2013, p. 70
[6] Ibidem, p. 108
[7] Giovanna Fracassi, Introspezione, Rupe Mutevole Edizioni, 2024 p. 33
[8] Giovanna Fracassi, Essere e corpo in J. P. Sartre, Rupe Mutevole Edizioni, 2023, p. 30