Belfagor: fantasma del Louvre o aspirante rosacroce?
“C’è un fantasma dentro il Louvre.”

È la frase con cui lo scrittore e sceneggiatore Arthur Bermède (noto anche con lo pseudonimo di Jean de la Périgne e Roland d’Albret) apre “Belphégor” (Belfagor), classico esempio di quel romanzo d’appendice inserito a puntate nei quotidiani dell’Ottocento, (il primo a intuire la potenzialità d’attrattiva sui lettori fu E. de Girardin, direttore del parigino “La Presse”) reso celebre da Honoré de Balzac e in seguito ampiamente utilizzato da diverse generazioni di scrittori, da Alexandre Dumas a Tolstoj, da Stevenson a Wells, da Hemingway fino ad Agata Christie, capace di fidelizzare i lettori in vista della prossima uscita del romanzo e in qualche modo antesignano dell’attuale serialità in stile Netflix.
“Belphégor” è uscito nel 1925 in 59 episodi su “Le Petit Parisien”, successivamente nel 1927 è stato pubblicato dalla casa editrice Tallandier. E sempre nel 1927 viene prodotta anche la prima versione cinematografica senza sonoro, in quattro puntate, diretta da Henri Desfontaines, sceneggiata dallo stesso Bermède e interpretata da René Navarre (già famoso in patria per la serie “Fantomas”, del 1913).
Circa quarant’anni dopo, l’emittente francese ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) ha presentato l’adattamento in televisione dal titolo “Belphégor ou Le fantôme du Louvre”, diretto da Claude Berna e sceneggiato da Jacques Armand.
I due modificano alcuni nomi, ridimensionano il personaggio del detective Chantecoq (eroe del romanzo) a favore di quello del commissario Ménardier e di una giovane coppia di estemporanei investigatori, e implementano il tessuto narrativo con influenze esoteriche.
Protagonista, un imperscrutabile fantasma che appare accanto alla statua della divinità caldea Belfagor (animato dal famoso mimo Isaac Alvarez) e che si aggira nottetempo nelle sale del Louvre, con un lungo mantello, un copricapo nero e una maschera di cuoio sul volto, accompagnato da un bambino che gli fa strada dopo averlo richiamato con un particolare fischio.
Da intendersi come una divinità demoniaca presso alcune popolazioni semitiche del Medio Oriente, Belfagor (da Baal-P’eor, letteralmente signore della morte secondo la lingua caldeo-babilonese) viene assorbito dalla religione cristiana al Diavolo e comunemente identificato come il dio dell’inganno.
Quando il capo custode del Louvre viene trovato morto all’interno del museo e la polizia parigina inizia a indagare, un giovane studente, Andrea Bellegarde, attratto dalla notizia, inizia a fare delle ricerche insieme a Colette, figlia dell’ispettore Mènardier incaricato dell’inchiesta. Successivamente al ritrovamento di un meccanismo che apre un sarcofago mobile, Bellegarde si fa rinchiudere nel museo per palesare l’arcano che si cela dietro la comparsa del fantasma, scoprendo le incomprensibili pratiche di una setta di occultisti discendente dalla famosa confraternita dei Rosa-Croce, il cui tesoro, dal potere radioattivo, sarebbe nascosto proprio nel cuore del Louvre.
Il fervore esoterico legato a una sedicente confraternita della Rosa-Croce (che prende il nome dal presunto fondatore dell’ordine, Christian Rosencreutz, la cui esistenza si sarebbe protratta per 106 anni, dal 1378 al 1484) ebbe origine da due manifesti pubblicati nel 1614 e nel 1615, “Fama” e “Confessio”, a cui seguirono altri manoscritti diffusi nell’agosto del 1623, a Parigi, che comunicavano la presenza di una congrega di illuminati che, “seguendo la volontà dell’Altissimo, vogliono trarre gli uomini dall’errore e dalla morte, e tutti coloro che ne entreranno a far parte saranno istruiti alla conoscenza dell’Altissimo, resi da visibili a invisibili e da invisibili a visibili, e avranno la capacità di parlare le lingue straniere senza la necessità di apprenderle”.
Ma dei Rosa-Croce c’è testimonianza fin dal 1200, quando, nella sua “Ars Magna”, il teologo spagnolo Raimondo Lullo scrive di “questi associati alchimisti della Rosa-Croce”, e forse le radici s’immergono in una precedente e più universale setta denominata Stirpe di David, che l’abate Gioacchino da Fiore definisce Radix Davidis, e che continua fino al frate domenicano Giordano Bruno (per molti il perno della rinascita rosacrociana), in una cultura che recupera le oscure tradizioni iniziatiche egizie e mitraiche e che si pone nell’ambito di una diversa visione scientifica del mondo (uno dei principali difensori fu Galileo Galilei che, come Giordano Bruno, riorganizza la confraternita ribattezzandola dei Giordaniti. Anche Renè Descartes sarà incolpato di essere un adepto rosacrociano, e come non ricordare il sigillo di Baruch Spinoza: una rosa, simbolo di accesso alle verità nascoste).
Da questa adunanza convergono tutti i veri o presunti adepti Rosa-Croce, dall’umanista e allievo di Giordano Bruno Simon Studion (autore del libro di profezie “Naometria) al musicista e alchimista Michael Maier fino a Jacob Andreae, il “secondo Lutero” (zio di Johannes Valentinus Andreae autore de “Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz”, pubblicato nel 1616 e considerato il terzo manifesto rosacrociano), il quale contesta che ci siano i Rosa-Croce per evitare persecuzioni da parte della Chiesa, supportato, in questo, dal medico e teosofo inglese Robert Fludd (altro allievo di Giordano Bruno), che nella sua opera “Silentium post clamores” lancia un appunto inconfondibile a tutti i confratelli: “Bisogna essere invisibili, cosi devono essere i Rosa-Croce”.
Si sa, l’indagine esoterica di propensione spirituale è vista con sospetto dalle gerarchie ecclesiali, troppo prese da esigenze più temporali, e un po’ si ripete quanto già capitato alla dottrina gnostica nel II secolo d.C., troppo “pericolosa” nella sua espansione alla salvezza individuale per pochi illuminati, e troppo eterodossa nell’esaminare gli accadimenti del mondo reale come il riverbero di ciò che succede in quello invisibile, e per questo tacitata prima e confutata poi dagli esegeti ed eresiologi cristiani.
Come afferma la medioevalista Frances Yates, “il comportamento abituale degli scrittori rosacrociani sarà affermare di non essere, per parte loro, rosacrociani”, proseguendo peraltro a spargere il “verbo” con appositi codici cifrati, nella ferrea convinzione che il piano esteriore, quello della storia ufficiale, sia manifestazione di un piano occulto che agisce in una dimensione spirituale (sostenuto anche dal filosofo antroposofico Rudolf Steiner), che per essere compreso necessita di una chiave iniziatica perché come scrive l’alchimista tedesco Michael Maier: “Chi cerca di penetrare nel Roseto dei Filosofi senza la chiave, sembra un uomo che voglia camminare senza i piedi”.

La presunta invisibilità dei Rosa-Croce si presterà dunque a semplici leggende (come ad esempio nel caso del conte di Saint-Germain), e si parlerà a lungo dei loro rapporti con la tarda massoneria, “rimarrà comunque eterna materia di illazione l’esistenza di una confraternita realmente esistita ed esistente, con conseguente trasmissione di un sapere a pochi illuminati”, come scrive Umberto Eco nella prefazione a “La storia dei Rosa-Croce” di Paul Arnold.
Un po’ come i pochi illuminati-adepti di “Belfagor”… perché non ci siamo dimenticati del nostro fantasma del Louvre, della protettrice della divinità caldea Lady Hodwin, delle misteriose gemelle Luciana e Stèphanie Borel (entrambe magistralmente interpretate da Juliette Gréco), fino all’esperto di riti iniziatici Boris Williams (interpretato dal membro della Comédie-Française François Chaumette)… sì, e, d’altra parte, i baby boomers come me non potrebbero mai mettere in oblio il terrificante personaggio che ci teneva col fiato sospeso davanti allo schermo rigorosamente in bianco e nero della tv (sei puntate andate in onda sulle reti Rai), uno dei più angoscianti del fantastico seriale, grazie anche alla fotografia espressionista, alla colonna sonora di Antoine Duhamel (che in seguito collaborò con Jean-Luc Godard e François Truffaut), contraddistinta da note di violino su temi classici, in un’atmosfera di magia e di mistero dove le suggestioni noir e gotiche sono accompagnate da echi di Nouvelle Vague.
Impossibile, dunque, scordarsi di Belfagor, quella che passò per la divinità dell’inganno. Ci Ci si chiede quale sia l’inganno e chi siano gli ingannati. Coloro che rifiutano di scorgere l’invisibile dietro il visibile, oppure chi ci invita a scrutare ciò che si cela dietro il visibile?
Belfagor, nel dubbio, proseguirà a materializzarsi nei ricordi di chi ha visto quell’iconico telefilm. Belfagor: occulto ai più, visibile e invisibile nello stesso tempo. Un personaggio che non è mai esistito ma che non smetterà mai di esistere, un convalidato Rosa-Croce.
Written by Maurizio Fierro
Info


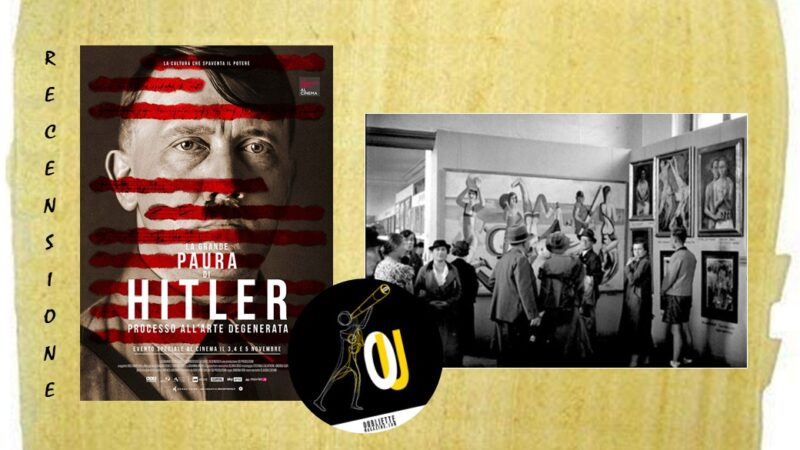

Bellissimo articolo contenente molte notizie sui Rosacroce che non conoscevo. Solo una precisazione: il romanzo di Bernede fu pubblicato a puntate su Le Petit Parisien nel 1927, e precisamente dal 28 gennaio al 28 marzo 1927; il film in quattro episodi venne distribuito nelle sale cinematografiche in quattro appuntamenti dal 10 febbraio, in pratica contemporaneamente alla pubblicazione sul quotidiano. Il romanzo fu pubblicato in volume solo successivamente, ma la prima edizione vide comunque la luce quello stesso anno.
Ciao Antonio, grazie mille e grazie anche per le precisazioni.
Sui Rosacroce, ho preso come riferimento due testi:
Storia dei Rosacroce, di Paul Arnold con prefazione di Umberto Eco (Bompiani)
La saggezza dei Rosacroce, di Rudolf Steiner