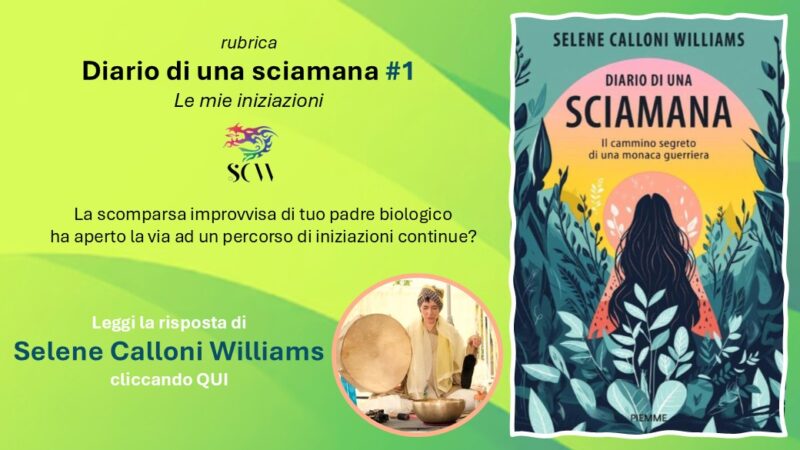Meditazioni Metafisiche #18: il sacrificio, ovvero il cambiamento dell’essere umano
Presso tutti i popoli del Vicino Oriente antico esistevano dei sacrifici di alleanza, mediante i quali due di essi stringevano rapporti di collaborazione, aiuto, amicizia.

Di solito il sacrificio di alleanza prevedeva l’uccisione di animali il cui sangue era versato per metà sopra un popolo e per l’altra metà sopra l’altro popolo, in modo tale da significare che i due erano diventati consanguinei. Poi i due popoli stabilivano delle clausole da rispettare in questa alleanza.
Questo stesso schema si ritrova nella alleanza tra Dio e il popolo di Israele in Esodo 24. Mosè sacrifica degli animali al Signore, poi asperge metà del sangue delle vittime sull’altare e l’altra metà sul popolo di Israele e pronuncia queste parole: “Ecco il sangue dell’alleanza che ha concluso il Signore con voi”. Allora la Antica Alleanza si basa sul sangue delle vittime sacrificali. Le clausole sono i Dieci Comandamenti che Dio dà a Mosè sul Monte Sinai.
Nel Nuovo Testamento viene stipulata la Nuova Alleanza mediante il sacrificio di Cristo stesso che diviene il nuovo agnello sacrificale.
Abbiamo quattro racconti della Istituzione Eucaristica dove il pane e il vino sono (per i cattolici e gli ortodossi) o rappresentano (per i protestanti) il corpo e il sangue di Cristo: in Marco e Matteo (espressione del racconto della chiesa di Gerusalemme) e Luca e Paolo (espressione del racconto della chiesa greca).
Matteo 26 riprende le stesse parole di Mosè ma applicate al sangue di Cristo: “Bevetene tutti, questo è il mio sangue dell’alleanza”. Quindi la Nuova Alleanza si fonda sul sangue non di animali ma di Cristo stesso. Pertanto, concludono i teologi, tutta la vita della chiesa trae la forza dal sangue purissimo del Dio fatto Uomo. La clausola è, oltre ai Dieci Comandamenti che rimangono in vigore, il comandamento dell’amore (Giovanni 13, 34).
Ciò che salta più agli occhi in questa Nuova Alleanza del cristianesimo è lo stra-ordinario amore di Dio per il suo popolo, che Francesco d’Assisi chiama “eccessivo” e i fratelli delle chiese orientali chiamano “pazzo”. Al Venerdì Santo i cattolici cantano una antica antifona, forse risalente all’VIII secolo: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit, “ecco il legno della croce, dal quale pende la salvezza del mondo”.
È un amore oltre ogni misura umana: Dio Padre sacrifica il Figlio e il Figlio accetta volontariamente di fare la vittima sacrificale. Anche sotto questo aspetto si possono intendere le parole della Lettera gli Ebrei, delizioso scritto neotestamentario profondamente teologico e redatto nel greco migliore del Nuovo Testamento: Cristo è “irraggiamento della sua gloria e impronta della sua sostanza”, apaugasma tēs doxēs kai charaktēr tēs upostaseōs autou. Come l’impronta del sigillo rispecchia il sigillo stesso, così Cristo è impronta del Padre, condivide la natura e le qualità. “Chi vede me, vede il Padre”, o eorakōs eme eōraken ton patera, dice Gesù in Giovanni 14, 9.
Il Figlio di Dio che si fa “compagno” di viaggio dell’uomo, che nella etimologia latina da cum e panis significa colui che mangia il pane insieme ad un altro. Non solo, ma che diventa pane da mangiare, un po’ come accade anche con alcune divinità indiane. Come ad Emmaus (Luca 24) i cristiani riconoscono Cristo nello spezzare il pane, così viene sancita nell’amore estremo la vera identità di Cristo.

Qualcosa di questo è presente altresì nella divinità indiana Prajāpati. Questo dio è all’origine del sacrificio, quindi è la prima vittima sacrificale e allo stesso tempo il primo officiante del sacrificio. C’è in merito un passo molto eloquente del Śatapatha-Brāhmaṇa XI, 1, 8, 2-4: “Prajāpati offrì sé stesso agli dei sotto forma di sacrificio. Il sacrificio era per loro, perché il sacrificio è il cibo degli dei, yajño hi devānām annaṃ. Dopo aver fatto offerta di sé agli dei, emise un’immagine di sé, che è il sacrificio.”
Caterina da Siena: “Chi sarebbe quel bruto che, scoprendo un amore così grande, non amerebbe a sua volta?” Quasi tutti i papi fino al IV secolo morirono martiri. La chiesa del passato distingueva un “martirio rosso” (versando il sangue), un “martirio bianco” (andando in missione) e un “martirio verde” (abitando luoghi sperduti svolgendo vita eremitica).
Nicola di Bari è uno dei santi più conosciuti, in esso si fuse una ardente carità verso il prossimo e la persecuzione sotto Diocleziano che patì per amore di Dio e dei fratelli, pur senza venirne ucciso. Subito dopo la morte la salma iniziò a sprigionare olio e acque curative, un po’ come il Tempio di cui parla Ezechiele 47, da cui sgorgano acque che risanano la terra. Chi ama Dio trova in ogni cosa che accade, bella o apparentemente brutta, un motivo di ringraziamento. Il cristianesimo fa della croce, abbracciata da Dio in persona nel sacrificio della vita, il luogo privilegiato della manifestazione dell’Assoluto. Dal costato di Cristo, trafitto dalla spada di Longino, scaturiscono quel sangue e quell’acqua che redimono il mondo e persino lo divinizzano, come mettono l’accento le chiese orientali.
Ma questi atteggiamenti di amore estremo non sono esclusivi del cristianesimo. Le divinità di solito si pongono come esseri di luce e amorevoli. Rabbì Achiva si sentì degno di dire la professione di fede ebraica (“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”, Deuteronomio 6, 5) solo quando per Dio diede la vita. I musulmani, facendosi martirizzare, guadagnano il paradiso. Non esiste l’induismo come entità unica né tantomeno l’Oriente, sono aberrazioni occidentali.
Il subcontinente indiano ha culti anche diversissimi senza un denominatore comune. Gandhi aveva certamente uno spirito religioso mediante il quale accettava persino di morire per il bene degli altri, che poi coincidono con Dio, dato che tutti gli esseri sono Dio. E così via.
Nei Versi aurei Pitagora diceva che gli uomini soffrono dei mali che loro stessi si procurano, tenendosi legati a ciò che nuoce loro. Non riconoscere in tanto amore la via della salvezza, significa stare ancorati al male con le proprie mani.
In definitiva, non si tratta di aderire necessariamente a una forma religiosa, ma innanzitutto di credere nell’amore in quanto tale. Questo amore in quanto tale non è espresso solo da Cristo che sta in agonia sulla croce fino alla fine del tempo (Pascal) ed è “sempre vivo per intercedere” (Lettera agli Ebrei 7, 25: pantote zōn eis to entunchanein), ma vive in ogni uomo, dalla madre che dà la vita ogni giorno per i figli all’insegnante che vive in una scuola per aprire le menti dei giovani allievi. Dopo che l’uomo apre gli occhi volontariamente e riconosce l’amore, potrebbe fare un passo ancora e aprirsi anche a Dio, perché “Dio è amore”, o theòs agapē estin (1Giovanni 4, 8).
Nelle nostre vite gli affari di tutti i giorni offuscano quella intuizione primordiale che ci apre ai valori dello spirito e alla divinità. Tutto ci parla di materia e di denaro, di corpo e di immanente. Ma il mondo intuitivo-immaginale ci è necessario per vivere una vita piena e non perderci in cose che alla fine lasciano il tempo che trovano. È questo il grande contributo di Hillman.
In un papiro egiziano si dice che le medicine sono state fatte per curare le malattie, il vino per curare la tristezza, i sogni per guidare il cieco nella vita.
La materia non è il Male Assoluto, ma se il nostro cuore sta solo in essa, perde il contatto con le vere energie vitali del suo essere. Anche il Talmud riconosce che Dio ci giudicherà pure per i piaceri leciti che non abbiamo goduto. Lutero diceva che appetitum ad mulierem est bonum donum Dei, il desiderio della donna è buon dono di Dio.
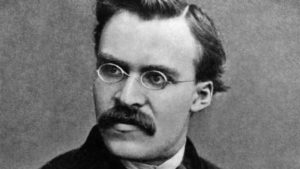
Nietzsche in Umano, troppo umano osservava che bisogna lasciare la fede nella quale ci si è impigliati la prima volta ed evolvere, educazione presuppone sempre educabilità. L’uomo per natura pensa, il cervello è fatto per risolvere problemi e trovare sempre nuove soluzioni. Il segreto della Via è che non si potrà mai trovare la fine. Il senso sta nel percorso. Il cambiamento è la cifra dell’essere umano.
Ma nel percorrere la Via ci si accorge che tutto, passo nuovo dopo passo vecchio, dice la stessa cosa. In tedesco “esperienza” si dice Erfahrung, come a dire l’interiorizzazione di un viaggio. Alla fine il viaggio ci apre gli occhi sul fatto che non ci siamo mossi. Siamo sempre noi. Il viaggio della vita è la nostra riscoperta. La verità non è un oggetto esterno a noi, ma la identità profonda tra noi e il mondo. Il senso del viaggio della vita è capire il nostro Sé e non capire qualcosa di esterno. È ritrovarci dopo che ci siamo dimenticati di noi. È sanare la ferita dello stacco da noi stessi con il ritorno a noi stessi.
Le cose del mondo hanno una funzione ben precisa. Valgono non in sé stesse, non dobbiamo quindi attaccarci il cuore, ma sono utili nella misura in cui servono a farci capire chi siamo. L’atleta agonista o comunque lo stachanovista si impegna duramente per vincere oppure per non pensare al proprio disagio interiore. È un altro modo di usare male le cose del mondo. Esse devono servire per farci pensare al disagio, per aprirci gli occhi sul nostro limite: e da questa consapevolezza che dobbiamo impegnarci per maturare.
Il Seid è una antica magia sciamanica norrena, praticata prevalentemente dalla donna, detta Völva, anche se si può supporre non esclusivamente dal fatto che anche Odino ne conosceva i segreti, sebbene non siano mai stati ritrovati resti archeologici di maghi uomini.
Una concezione molto interessante entro questo sapere tradizionale è la Rete di Wyrd o Rete del Destino. Il destino di una persona è come una serie di fili che legano il passato al presente e il presente al futuro. Un avvenimento influenza ciò che siamo e questo nostro essere intaccherà il nostro futuro, e poi per una circolarità il futuro può intaccare il passato in un processo continuo.
La maga norrena poteva trasferire questo mistero dell’uomo sulla tela di un telaio e toccando i fili influenzare il destino di una persona.
Ma l’idea base della Rete di Wyrd è che noi siamo artefici del nostro destino. Mentre nella Grecia antica non vi era la concezione di una vera volontà, la tradizione norrena dice che l’uomo, migliorando sé stesso o imbrutendosi, può decidere ciò che sarà.
L’uomo ha una grande responsabilità sulla propria vita.
L’intelligenza serve per capire ciò che dobbiamo fare, la volontà serve per attuarlo.
Anche le religioni e le correnti spirituali non tolgono all’uomo la responsabilità di scegliere il proprio destino. Nel Salmo 31, 6 si legge: “Nelle tue mani affido il mio spirito, riscattami, Signore, Dio fedele”. I biblisti notano una sfumatura giuridica: come nel diritto israelitico il depositario accettando di custodire l’oggetto se ne assume la piena responsabilità, così Dio diviene il padrone della vita del fedele che si affida a lui.
Questa lettura è confermata dal verbo ebraico seguente, pdh, termine tecnico del riscatto, parola usata ad Ugarit nei confronti della emancipazione dalla schiavitù. Ma il concetto di alleanza – in ebraico berit, dall’accadico birit, “fra” – presuppone che il fedele sia libero di aderire o meno alle leggi di Dio, cioè di stipulare o meno un patto “fra” uomo e Dio.
Ad una attenta analisi filologica del Salmo 31, il testo ebraico presenta almeno tre stratificazioni. Il nucleo primitivo doveva essere nei versetti 10-19: una preghiera di lamentazione in metro 3+2. Poi si aggiunse una preghiera di fede (dall’inizio alla prima parte del versetto 6: “Signore, nelle tue mani affido il mio spirito”): in metro 3+3. Infine abbiamo una preghiera di fiducia nell’intervento del Signore (che comprende la seconda parte del versetto 6: “Riscattami, Signore, Dio fedele”, fino al versetto 9): in metro 4+4. Secondo questo approccio diacronico, l’interpretazione giuridica (sincronica) del versetto 6 non reggerebbe perché le due parti dello stesso sarebbero state scritte in tempi diversi. Ma non si può escludere a priori che le due preghiere siano sì state scritte da mani diverse ma poi unificate e leggermente modificate dalla mano finale che le ha unite e avrebbe dato la sfumatura giuridica.
Per la Bibbia ogni lettura sincronica è problematica perché si tratta di un testo tradizionale, cioè sorto progressivamente ad opera di autori distanziati nel tempo. Purtuttavia, il redattore finale può aver unito i singoli testi differenti e, apportando leggere modifiche, può aver dato una valenza unitaria.

Per la concezione vedica il sacrifico non è solo garante dell’alleanza tra le tremende divinità indiane e la società, ma addirittura la fonte di ogni bene che accade agli uomini. Il sacrificio vedico regge addirittura l’equilibrio cosmico.
I sacrifici vedici sono di due tipi:
- Quelli detti indipendenti (nirūḍha), nei quali il sacrificio dell’animale è la base della cerimonia;
- Quelli nei quali l’uccisione dell’animale può essere solo un aspetto accessorio, mentre il fulcro della cerimonia sta nell’offerta sacrificale di un liquido vegetale (Soma) o di latte.
Per impulso di certe correnti oggi i sacrifici indiani tendono a non uccidere animali. Il vegetarianismo è molto importante in India.
Pensiamo anche all’Editto I di Ashoka, per cui non bisogna sacrificare nessun animale mettendolo a morte. Ashoka è stato un grande re indiano del III secolo a. C., il quale favorì la proliferazione del buddhismo anche fuori dall’India, probabilmente fino al Mediterraneo. Ci sono rimasti 33 Editti in varie lingue nei quali si danno precetti morali. Ashoka, nel diffondere il buddhismo, voleva far conoscere la regola morale indiana o dharma, termine sanscrito molto importante e dalle innumerevoli sfaccettature, che in questi editti è detto in prakrito dhamma, il quale si ispira certamente al buddhismo ma non in via esclusiva, pretendendo di essere una regola di vita universale, valida per ogni uomo.
Ciò che spingeva Ashoka nella sua opera a favore del dhamma era il debito verso le creature. Secondo le concezioni indiane, gli uomini hanno un debito verso tutti gli esseri, che deve essere sanato dando loro amore.
Quindi rivelando per amore a quante più persone possibile la via per la liberazione, si imbocca la strada giusta anche per la propria. Ben sapendo che tutti siamo parte di un Assoluto nel quale dovremo reintegrarci.
Questo il buddhismo lo sottintende, anche se non lo dice esplicitamente, come fanno invece le correnti denominate induiste. Per alcune scuole del Vedānta esiste una sola Realtà, Dio o Assoluto, Brahman, tutto il resto è illusione. Anche il Corano 55, 26: “Tutto ciò che c’è perirà. Ma rimarrà il Volto del tuo Signore”, kullu man ‘alayhā fānin. Wayabqā wajhu rabbika.
Presso gli ittiti le molte divinità non erano collegate a particolari visioni del mondo, come potevano essere gli dei greci e romani, che impersonavano forze della natura o concetti, ma erano aspetti territoriali che venivano venerati in senso religioso.
Il sacrificio agli dei ittiti aveva qualcosa di analogo con quello mesopotamico, per cui i templi erano luoghi nei quali il dio mangiava. La particolare divinità ittita aveva diritto a parte del raccolto e degli armenti per nutrirsi. Il re, che tra l’altro era il vero sacerdote che sacrificava direttamente, offriva anche simbolicamente le conquiste territoriali.
Storicamente le tavolette e il materiale archeologico testimoniano di intensi scambi tra il mondo mesopotamico e quello ittita. Dal punto di vista filologico, gli ittiti del II millennio scrivevano in ittita, lingua indoeuropea, in scrittura cuneiforme, sistema grafico di origine mesopotamica di 800 segni nel III millennio, di 500 nell’epoca babilonese, ma ridotti per l’ittita a 200.
Le prime testimonianze scritte della civiltà ittita non sono in ittita ma in accadico, importante lingua semitica mesopotamica, e in cuneiforme accadico. Probabilmente gli ittiti sconfissero i siriani e si portarono via gli scribi siriani, che avevano questo sistema di scrittura sofisticato.

Lo ipotizziamo perché il sillabario ittita è uguale a quello della Siria, precisamente della città di Alalah. Solo dopo gli ittiti costrinsero gli scribi siriani a scrivere in cuneiforme anche l’ittita. Invece sembra che gli ittiti conoscessero molto poco e male il sumerico, lingua mesopotamica non semitica, considerata isolata.
Da diverse tavolette ittite sappiamo che durante la festa Antahsum la coppia regale offriva sacrifici di pecore alla divinità. Entro questa festività avveniva anche quella detta kadauri, nella quale il DUMU.LUGAL, “figlio del re”, faceva alcuni riti come rappresentante del re[1].
Written by Marco Calzoli
Note
[1] A. M. J. Ticchioni, Il DUMU.LUGAL nei testi cultuali ittiti, in Studi Classici e Orientali, Vol. 27 (ottobre 1977), pp. 137-167.
Info
Rubrica Meditazioni Metafisiche