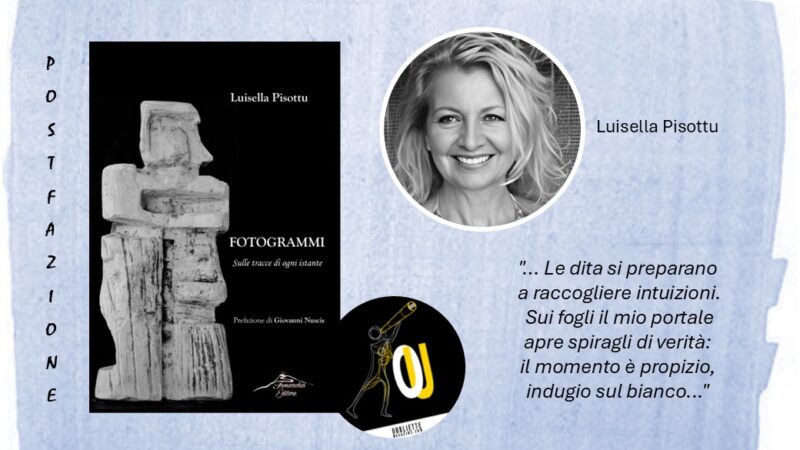“Migrazioni e intolleranza” di Umberto Eco: comprendere è accettare la diversità?
Questo volume pubblicato come supplemento a La Repubblica raccoglie due vecchi saggi e ulteriori due scritti inediti di Umberto Eco che affrontano temi sempre attuali: i movimenti migratori e le difficoltà delle società contemporanee nel confrontarsi con la diversità.
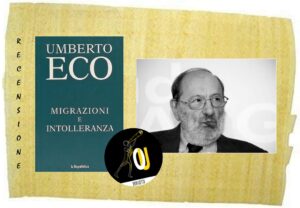
Nonostante questi testi (“Migrazioni e intolleranza”) siano ormai datati, permane la loro validità interpretativa anche nel contesto attuale. Si configurano come strumenti di analisi critica molto utili per comprendere fenomeni che continuano a contraddistinguere il nostro tempo.
Il primo testo: Le migrazioni del terzo millennio, dedicato alle migrazioni, riporta parte di una conferenza pronunciata nel gennaio 1997 in apertura del convegno organizzato dal Comune di Valencia sulle prospettive del terzo millennio. Umberto Eco riflette sulla natura inevitabile di questo processo.
La storia è segnata da spostamenti di genti: dalle invasioni “barbariche” (come “noi” le abbiamo chiamate) al colonialismo, fino ai flussi migratori contemporanei. L’idea di un mondo statico, dove i confini restano blindati, è pura illusione.
Eco insiste sul fatto che i movimenti migratori non sono anomalie, bensì fattori costitutivi della storia. Da qui la necessità di affrontarli evitando la paura o la chiusura, ma dotandoci di strumenti culturali e politici adeguati. In questo senso, lo scrittore smonta le retoriche allarmistiche che descrivono i migranti come “invasori”, sottolineando invece il valore dell’integrazione e lo scambio fecondo che deriva dall’incontro tra culture.
Il secondo testo: Intolleranza, riadatta l’introduzione al Forum internazionale sull’intolleranza, organizzato a Parigi dall’Accadémie Universelle des Cultures nel 1997, analizzando l’intolleranza come una delle pulsioni più radicate nell’animo umano.
Eco sottolinea come l’intolleranza nasca dal bisogno di semplificazione: classificare, ridurre la complessità, distinguere un “noi” rassicurante da un “loro” percepito come minaccia. Questo meccanismo elementare, che ha radici psicologiche profonde, è alla base di fenomeni sociali e politici come il razzismo, il nazionalismo e l’integrismo religioso.
Umberto Eco mette in guardia contro il rischio che l’intolleranza, se alimentata da discorsi pubblici irresponsabili o da crisi economiche e sociali, possa trasformarsi in conflitto aperto.
Il terzo testo: Un nuovo trattato di Nimega, è tratto da un discorso tenuto nel 2012 all’Università di Nijmegen, in Olanda, sede del primo trattato di pace europeo nel 1678. Eco prende spunto dal Trattato di Nimega (storico accordo di pace del XVII secolo) per riflettere sul tema dell’Europa.
Nimega diventa per lui un simbolo: il luogo dove si è cercato di costruire un equilibrio tra nazioni diverse e spesso in conflitto. Eco richiama la necessità, nel nostro tempo, di un nuovo “trattato” simbolico, cioè di un patto capace di ridefinire la convivenza europea alla luce delle migrazioni e delle nuove sfide identitarie. L’idea centrale è che l’Europa debba trovare la forza di superare egoismi e particolarismi, altrimenti rischia di disgregarsi davanti alle pressioni esterne e interne.
Il quarto ed ultimo testo: Esperienze di antropologia reciproca è l’introduzione a una antologia di testi sull’antropologia reciproca dell’Associazione Transcultura, pubblicata in Francia nel 2011. Questa riflessione gira attorno al concetto di “reciprocità” nello sguardo antropologico. Eco parte dall’osservazione che, tradizionalmente, l’antropologia ha visto l’“altro” come oggetto da studiare: i popoli lontani, gli stranieri, le minoranze.
Egli propone invece di parlare di antropologia reciproca, in cui ciascuna cultura impara a guardarsi attraverso gli occhi dell’altra. In un mondo globalizzato, dove l’incontro con la diversità non è eccezione ma quotidianità, questo scambio di prospettive diventa indispensabile per costruire una convivenza autentica. Eco insiste sul fatto che non esiste un “noi” centrale e un “loro” periferico: tutti siamo al contempo osservatori e osservati.
L’autore non si limita però all’analisi, ma invita a un cambiamento culturale che comporti l’educazione alla tolleranza, il riconoscimento della pluralità e la capacità di convivere con l’alterità. Per Eco, non si tratta di eliminare l’istinto di diffidenza – impossibile da sradicare del tutto – ma di elaborarlo culturalmente, attraverso pratiche di dialogo e di incontro.
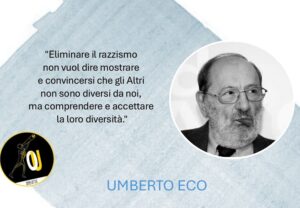
Scrive Eco nella quarta di copertina de “Migrazioni e intolleranza”: «Eliminare il razzismo non vuol dire mostrare e convincersi che gli Altri non sono diversi da noi, ma comprendere e accettare la loro diversità».
Umberto Eco descrive questi fenomeni scegliendo di usare una prosa chiara, diretta, capace di parlare a un pubblico ampio. Inoltre, l’ironia sottile e la capacità di intrecciare riferimenti storici, letterari e filosofici conferiscono ai saggi una leggerezza che non toglie nulla alla serietà dell’argomento.
In conclusione, “Migrazioni e intolleranza” breve ma denso libretto rappresenta un esempio del contributo intellettuale di Eco: capace di illuminare i nodi cruciali della convivenza umana con chiarezza, spirito critico e lungimiranza. Un testo da leggere non solo per la qualità della riflessione, ma per la sua funzione civile: ricordarci che la sfida dell’incontro con l’altro è inevitabile, e che solo dalla capacità di gestirla dipende il futuro delle nostre società.
Quanto si sente la mancanza di Umberto Eco di questi tempi!
Written by Algo Ferrari
Bibliografia
Umberto Eco, Migrazioni e intolleranza, La Repubblica, GEDI, 2020