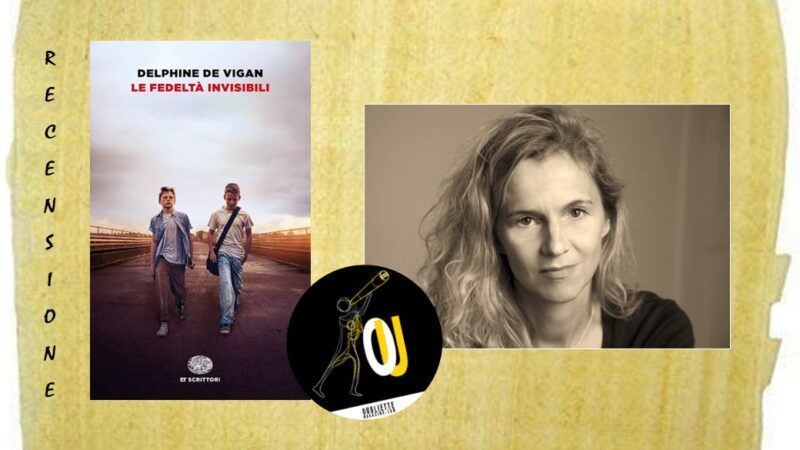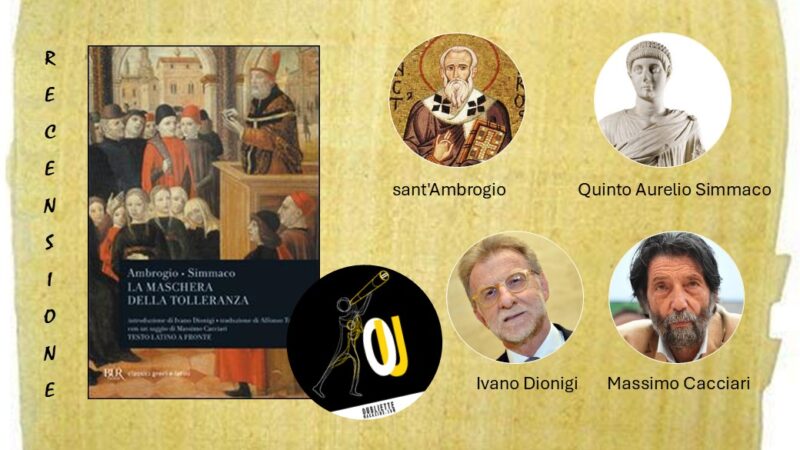“Lucciole, squaletti e un po’ di pastina” di Donatella Di Pietrantonio: sette racconti per tutte le età
“Ma secco è il pruno, e le stecchite piante/ di nere trame segnano il sereno/, e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante/ sembra il terreno” ‒ da “Novembre” di Giovanni Pascoli

Donatella Di Pietrantonio, vincitrice della scorsa edizione del Premio Strega con L’età fragile (Einaudi 2023), dell’edizione 2017 del Premio Campiello con il romanzo che l’ha resa famosa, Arminuta (Einaudi 2017), si è nei mesi scorsi distinta nella scrittura per ragazzi con Lucciole, squaletti e un po’ di pastina, una raccolta di sette racconti edita da Salani nel 2025.
Con questo volume, splendidamente illustrato da Andrea Tarella, l’autrice abruzzese ha vinto la sezione “Ragazzi Narrativa” del Premio Elsa Morante 2025, assegnato il 13 maggio scorso a Napoli. Anche nella narrativa pensata per i più giovani, insomma, la Di Pietrantonio si afferma autrice di successo.
Mi piace pensare che la scrittrice, odontoiatria pediatrica, racconti storie ai suoi giovani pazienti per “corromperli” e per convincerli ad accettare le sue malefiche cure. A quale bambino, del resto, piace sedersi sulla poltrona di chi maltratta la propria boccuccia?
Grazie a questa pubblicazione è ora possibile leggere le favole ai più piccoli anche lontano dallo studio dentistico.
Eccone i titoli: Le prime lucciole, Storia di una pastina, Cielo quasi sereno, Amici di pinna, E Dio creò i colori, L’albero di Tommaso, Pastorale mezza americana.
Ognuna di esse costituisce un modo fantasioso e fantastico di spiegare qualcosa.
Ad esempio Le prime lucciole mostra come nascono le lucciole: esse sono delle stelle cadenti che entrano nella pancia delle mosche uscite a Dio difettose per raggiungere la Terra. Attraverso questa chiosa, veramente carina per se stessa, passa intanto il messaggio che in Natura tutto si trasforma.
La metamorfosi può essere la risposta all’esigenza di un cambiamento, come quella delle stelle che ad un certo punto si stancarono di stare ferme in una parte di cielo e iniziarono a voler esplorare il regno degli uomini. Nonostante il giudizio onnisciente della narratrice, che già forse lascia presagire come andrà a finire la storia (“Anime pigre gli uomini: solo di rado qualche poeta o bambino si distraeva dagli oggetti bassi per volgere lo sguardo alle vaghe stelline”), le stelle “ammiccavano verso la Terra, curiose della vita”.
Del resto questa vicenda esplicita anche le conseguenze a cui si va incontro quando si sceglie di cambiare: i nostri piccoli astri, usciti dalla loro zona di comfort, determinano un caos non solo nella galassia che “era tutta in disordine, come le camere di certi bambini“, non solo ad un astrofisico a cui “cadde un dente per la preoccupazione“, ma all’interno della propria esistenza. Dio, attraverso il suo angelo, le lascia libere di cambiare: le lucciole sapranno abbracciare fino in fondo la loro nuova condizione che, esattamente come la precedente, ha i suoi pro e i suoi contro?
Al di là della trama, delle tematiche importanti che essa sa veicolare, si apprezza la prosa poetica che rende la narrazione accattivante per i bambini, ma non solo, ad esempio attraverso l’uso di aggettivi accostati in accumulazione e climax per rendere l’idea del caos che regna sovrano in Cielo nel momento in cui le stelle decidono di andarsene: “le costellazioni” erano “spettinate, confuse, decimate”, oppure mediante la similitudine con il disordine delle camerette che i bambini (ma talvolta anche gli adulti, aggiungo io), conoscono bene. Oppure in alcuni momenti non basta dire che “le lucciole furono bellissime”; occorre non raccontarlo, ma mostrarlo (secondo il dettato di Stephen King) attraverso gli effetti che il loro arrivo sulla terra provoca nella Natura: “Quando arrivavano sopra i prati, nei boschi o perfino in città, il vento si posava, gli uccelli stavano zitti e i fiori schiudevano le corolle in attesa che qualcuna di loro la visitasse [….] Illuminavano qui una foglia, lì una ragnatela, la pella scabra dei rospi. I prati erano stellati come cieli caduti. La danza di luce si specchiava negli occhi, sgranati degli uomini finalmente vicini”.
Inoltre, a riprova dell’impegno letterario delle nostra autrice, vorrei menzionare due suggestioni; la prima è data dalla curiosità delle stelle verso la Terra; al di là di come andrà a finire questo desiderio di conoscenza, loro devono sperimentare, analogamente al protagonista del libro Il piccolo principe (1943) di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944); d’altro canto, invece, la voce onnisciente di chi narra, già delusa dai “traffici… degli uomini” e dalle loro “anime pigre” ricorda non solo il Piccolo Principe, ma il fanciullino di Giovanni Pascoli (1855-1912) perché, esattamente come scrive il poeta nell’omonimo saggio (edito nel 1897), anche la Nostra afferma che era sola prerogativa dei poeti o dei bambini distrarsi dal quotidiano ed incantarsi contemplando qualcosa di diverso come le “vaghe stelline”. Queste ultime sono rese benissimo dalle illustrazioni, un blu fondo interrotto da pallini dorati, ora più grandi ora più piccoli.
Oppure le favole possono servire a spiegare, in chiave metaletteraria, come nascono non solo le storie, ma anche gli elementi che le tengono formalmente coese. Una storia, infatti, non è soltanto un insieme di parole, ma anche di segni diacritici e interpuntivi che magari inizialmente non esistono (come apostrofi, accenti e virgole) ma che possono essere inventati con un po’ di fantasia, ad esempio ricavandoli dalla zampetta della Q. Le storie, così come le lettere e i segni d’ interpunzione sono talmente fragili, però, che basta poco per cancellare tutto. Eppure niente si annulla, tutto si trasforma, secondo quanto già detto: allora le predette lettere, se contenute in una scatola di minestra acquistata al supermercato, possono diventare il pasto di un bambino che sarà, forse, un futuro scrittore. Le pagine di questo racconto sono decorate da lettere dell’alfabeto che circondano il testo a mo’ di cornice.
Oppure le storie possono raccontare che l’amore non è mai costrizione, ma libertà come emerge nel racconto Cielo quasi sereno, corredato da cromatismi che vanno dall’azzurro al grigio, tra il cielo e le nubi, fino a sfociare nell’arancione di un romantico tramonto.
Esse possono inoltre insegnare che bisogna andare oltre i pregiudizi perché, ad esempio, gli squaletti non sempre vogliono mangiare i pesciolini; a volte vogliono solo giocare con loro: per farsi apprezzare, però, devono superare delle prove, ad esempio difendere i piccoli dalle insidie della “terribile murena Filomena”; e anche in casi come questi, gli squaletti sanno sorprendere (Amici di pinna); le narrazioni possono poi parlare di un Dio che sa mettersi in discussione e, all’occorrenza, dietro le richieste più o meno esplicite delle sue creature, creare ciò a cui non aveva dato importanza per pigrizia, come i colori, non solo belli, ma anche necessari perché le cose vengano riconosciute nella loro essenza e non confuse, come ad esempio l’amore che nasce in Lui quando si rende conto che, dando vita ai colori, ha fatto qualcosa per gli altri: “Si sentì pieno d’amore e per l’amore ci voleva il rosso” (dal brano E Dio creò i colori).

E qui sagacemente l’illustratore ha usato due pagine per esagerare con il rosso, che ricopre anche il testo e che prende anche la forma di un bel cuore. Oppure le storie sono un invito ad accettare la morte vista non come la fine di tutto, bensì come una trasformazione da un lato e dell’altro come un atto di amore verso il nuovo che verrà: questo ci insegna L’albero di Tommaso (nel brano omonimo), albero che diventa legna da ardere e quindi calore per il bambino, lasciando che una pianticella più piccola, sua figlia, abbia tutto lo spazio e la luce necessari per dare nuovi frutti “dolci e succosi”. In queste pagine, invece, prevalgono le sfumature del viola, in onore all’albero di prugne, protagonista della favola.
Oppure le trame possono riproporre, mutatis mutandis, le vexatae quaestiones tra lupi e pecore, come nel racconto Pastorale mezza americana: vexatae ed antichissime, almeno tanto quanto autori come il greco Esopo (VI sec. a.C.) e il latino Fedro (I sec. d.C.).
In conclusione consiglio la lettura di questo bellissimo libro Lucciole, squaletti e un po’ di pastina che, attraverso il ricorso a personaggi tratti dal mondo vegetale e animale, mostra esempi e modelli validi anche per gli uomini.
Così è sempre stato nella favola classica ed è giusto che tale finalità emerga anche in queste storie e che le distingua da altre. Questo, ovviamente, senza nulla togliere alla bellezza della narrazione in sé, comprensiva anche delle illustrazioni (non solo colori, ma figure disegnate di animali, piante, e di altri protagonisti delle varie trame), obiettivo che, con una scrittrice come la Di Pietrantonio e un artista come Tarella, è pienamente raggiunto, come volevasi dimostrare!
Written by Filomena Gagliardi
Bibliografia
Donatella Di Pietrantonio, Lucciole, squaletti e un po’ di pastina, illustrazioni di Andrea Tarella, Salani, Milano 2025, 18,90 euro