“Conversazioni poetiche – Terza Edizione”: la prefazione di Giovanna Fracassi
“[…] i poeti e le poetesse di questa terza edizione dell’antologia “Conversazioni poetiche” propongono lo sforzo dello scontro tra l’immaginazione ed il reale, tra l’ambizione del sortilegio poetico ed il freno delle passioni, tra la solitudine e l’incontro con l’altro.” ‒ dall’Introduzione de “Conversazioni poetiche ‒ Terza edizione”

“Conversazioni poetiche ‒ terza edizione”, disponibile da aprile 2025 ed edita da Tomarchio Editore, vede la partecipazione di tredici voci tra autori ed autrici che, per l’appunto, conversano in poesia.
Sono, dunque, tredici le raccolte presenti e sono così intitolate: Vita di Annalisa Atzeni; L’azzardo di Fabio Soricone; 25 novembre di Franco Carta; Frammenti di un mosaico di Gabriella Mantovani; Pensieri di Ilse Atzori; In Libertade di Italo Cappai; Metamorfosi della solitudine di Marcello Comitini; Dell’amore e del cammino di Marco Leonardi; Punto e a capo di Maricà; Vita… pensieri… di Oswaldo Codiga; Il vento della solitudine di Rosario Tomarchio; Evidenze di Teresa Stringa; L’atmosfera giusta di Teresa Viola.
L’introduzione è stata curata da Alessia Mocci e la prefazione da Giovanna Fracassi.
Per gentile concessione della casa editrice Tomarchio Editore pubblichiamo la prefazione della terza edizione del progetto antologico “Conversazioni poetiche”.
PREFAZIONE “Conversazioni poetiche ‒ Terza edizione”
La parola “poesia” ha origini nel greco antico e deriva dal verbo “ποιεῖν” (poiein), che significa “fare”, “creare” o “produrre”. In questo contesto, la poesia è vista come un atto di creazione o di fabbricazione di qualcosa di nuovo, in particolare un’opera letteraria che nasce dalla fantasia, dall’immaginazione e dalla sensibilità del poeta. Vi è anche il sostantivo greco “ποίημα” (poiēma), che significa “creazione”, “opera” o “lavoro”. Questo termine si riferisce al risultato di un’azione creativa, un’opera che nasce dalla mente e dall’animo umano, spesso caratterizzata da una certa forma e da un linguaggio ricco di espressione estetica. Possiamo dunque affermare che la poesia è essenzialmente un atto creativo, un modo di “fare” linguaggio che si distingue dal discorso comune.
Essa è quindi una costruzione artistica che tende a suscitare emozioni, riflessioni e immagini attraverso l’uso particolare delle parole, del ritmo, delle metafore e delle figure stilistiche, cercando la bellezza, la profondità e il significato attraverso la forma e il contenuto. Non a caso nel mondo classico si credeva che le Muse infondessero nei poeti e negli artisti il dono della creatività e li guidassero nell’espressione delle loro opere, esse erano divinità della mitologia greca che personificavano le diverse forme di arte e ispirazione, erano figlie di Zeus, il re degli dèi, e di Mnemosine, la dea della memoria. Ecco quindi Calliope, la più venerata delle Muse, che era associata alla poesia epica, cioè a quella che racconta gesta eroiche e storiche. È spesso rappresentata con una tavoletta e una penna, simboli della scrittura. Poeti epici come Omero e Virgilio erano considerati ispirati da Calliope mentre Erato era la Musa della poesia amorosa e lirica che si credeva ispirasse le composizioni elegiache e le poesie che trattano temi quali l’amore, il desiderio e la passione, veniva rappresentata con una lira, simbolo del canto e della musica.
Ma come possiamo definire la poesia, questo genere letterario che tanto ci affascina? Chi può risponderci meglio dei poeti stessi che l’hanno esplorata come una forma d’arte, come mezzo di espressione emotiva, come modo di comprendere e descrivere il loro mondo interiore e il mondo in cui vivevano? Ecco dunque alcune delle definizioni di poesia date da alcuni poeti famosi, che ne mettono in luce diverse sfaccettature. Per Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) “La poesia è la verità che vive in un simbolo” ossia è un mezzo per rivelare verità profonde e universali, spesso nascoste dietro simboli e metafore, essa ha la capacità di dare forma a ciò che non può essere detto direttamente, ma che è essenziale per comprendere la realtà.
Per William Wordsworth (1770-1850) “La poesia è un’emanazione spontanea dei sentimenti” perché nasce dal profondo del cuore umano. È un’espressione sincera dei sentimenti e delle emozioni, che spesso scaturiscono dalla connessione con la natura.
Per la grande poetessa Emily Dickinson (1830-1886) invece “La poesia è l’arte di scegliere le parole che si devono sentire” perché si tratta di un processo in cui il poeta sceglie con attenzione ogni parola, creando un’armonia che risuona nell’animo del lettore. La poesia è per lei una forma d’arte che parla direttamente all’intuizione, ai sentimenti e alla comprensione del mondo.
Per Charles Baudelaire (1821-1867) la poesia è “un piacere che nasce dal dolore”, riteneva che la poesia avesse la capacità di trarre bellezza dalle sofferenze e dalle oscurità della vita. La sua definizione implica che la poesia possa trasformare il dolore e la tristezza in arte sublime, creando una forma estetica da emozioni intense e contrastanti.
Il nostro Giuseppe Ungaretti (1888-1970) considerava la poesia “un modo di guardare la realtà” perché il poeta interpreta il mondo e riflette su di esso.
Per T.S. Eliot (1888-1965) “La poesia è l’espressione di un’emozione, ma anche l’arte di fare appello alla razionalità e al pensiero” in quanto si tratta di un atto complesso che unisce emozione e intelligenza.
Ancora Pablo Neruda (1904-1973) definisce la poesia “il sangue dell’anima”, essa può essere considerata una manifestazione intima dell’animo umano, un’espressione potente di verità, di emozioni profonde e di lotta, che scorre come un fluido vitale nel cuore dell’individuo.
Per il poeta Walt Whitman (1819-1892) la poesia è “il respiro dell’umanità”, è una voce che unisce gli esseri umani in una dimensione universale che celebra la vita, l’individualità e la solidarietà.
Altra considerazione quella di Dante Alighieri (1265-1321) secondo cui la poesia è “la scienza che insegna a conoscere l’umanità” perché per mezzo di essa è possibile esplorare la condizione umana, la moralità, la giustizia e la spiritualità, così nella sua “Divina Commedia”, la poesia diventa uno strumento per esplorare l’aldilà e la struttura dell’universo, ma anche per riflettere sulla vita e sull’anima umana.
Terminiamo questa rassegna, certamente non esaustiva, con il poeta Rainer Maria Rilke (1875-1926) per il quale la poesia è “l’arte di fare parlare le cose silenziose” perché sa dare voce a ciò che è invisibile o inesprimibile. Secondo lui, la poesia ci permette di ascoltare le voci dell’universo e di dare significato agli aspetti più sfuggenti della realtà, come il silenzio, la solitudine e la bellezza nascosta.
Va ora evidenziato un aspetto che difficilmente può sfuggire a chi ama la poesia ma che è di vitale importanza se si vuole comprendere nel suo significato più profondo che cos’è: il suo stretto rapporto con la filosofia. Sebbene abbiano metodi e linguaggi diversi, entrambe cercano di esplorare la realtà, di affrontare il mistero dell’esistenza, la natura della verità, la relazione tra individuo e mondo e di esprimere la condizione umana. La filosofia cerca la verità attraverso la logica e la razionalità, mentre la poesia usa la bellezza del linguaggio, l’immagine e l’emozione per suscitare riflessioni che sfuggono alla razionalità. In molti casi, poeti e filosofi si sono avvicendati nell’esplorazione di questi temi, arricchendo reciprocamente le loro rispettive discipline. La filosofia, attraverso il ragionamento e la discussione logica, cerca di arrivare a risposte razionali, mentre la poesia si avventura in territori più enigmatici, cercando di evocare emozioni e immagini che possano suggerire risposte intuitive o simboliche. In molti casi, la poesia affronta questioni esistenziali che sfidano la razionalità, ma che sono ugualmente fondamentali per comprendere la condizione umana.
Il poeta fra tutti che meglio rappresenta il connubio tra filosofia e poesia è senza dubbio Giacomo Leopardi (1789-1837) non solo uno dei più grandi poeti italiani, ma anche un profondo pensatore; le sue riflessioni filosofiche sono intimamente legate alla sua poetica. La sua opera è una fusione di poesia filosofica in cui i temi esistenziali, il dolore, il pessimismo e la riflessione sul significato della vita s’intrecciano con la sua visione filosofica. La sua visione del mondo e della condizione umana non si limita alla speculazione filosofica razionale, ma si esprime in una poesia che traduce il dolore, la solitudine, l’infelicità e la vanità dell’esistenza in immagini potenti e suggestive. La sua filosofia del pessimismo e la sua poetica formano un unico tessuto di riflessione, in cui il pensiero filosofico si fa emozione e la poesia diventa il mezzo per meditare sulla realtà. Leopardi ha creato una sintesi unica tra la dimensione razionale e quella emotiva, così che la sua opera continua a parlare alla profondità dell’animo umano, rendendolo uno dei più grandi poeti e pensatori della storia della letteratura. Il nucleo centrale della sua filosofia è il suo pessimismo, che può essere considerato sia una visione filosofica sia un tema poetico.
La concezione del “pessimismo cosmico” che Leopardi sviluppa, in particolare nelle sue “Operette morali”, è un pensiero che permea tutta la sua produzione poetica. Questo pessimismo afferma che la natura umana è intrinsecamente destinata alla sofferenza, e che le illusioni e le speranze che spesso alimentano la vita sono destinate a frantumarsi di fronte alla dura realtà dell’esistenza. In quest’opera, la filosofia diventa il mezzo per esaminare la condizione umana in modo razionale, mentre la poesia è il canale emotivo attraverso il quale queste riflessioni vengono espresse. Leopardi trova nella poesia la modalità per esprimere la sua filosofia del dolore e della disillusione.
Poesie come “L’infinito” e “A Silvia” non sono solo esempi di poesia lirica, ma anche meditazioni filosofiche sul significato della vita e sulla condizione umana. Nell’idillio “L’infinito” riflette sul contrasto tra la finitezza dell’esistenza umana e l’infinito universo. La poesia, in questo caso, diventa una riflessione sulla limitazione dell’uomo, ma anche sul desiderio di oltrepassare questi limiti. Il celebre verso “e il naufragar m’è dolce in questo mare” esprime il piacere che il poeta prova nel perdersi nell’infinito, sebbene sappia che questa ricerca è, in fondo, un’illusione.
In “A Silvia” Leopardi esplora la caducità della giovinezza e della speranza. Silvia, rappresenta la giovinezza e i sogni di un futuro migliore, che sono distrutti dalla morte. La poesia diventa così una meditazione sulla vanità dei desideri e sulle illusioni che accompagnano la vita. Anche qui, la filosofia e la poesia si intrecciano: la riflessione filosofica sulla morte e sull’ineluttabilità del destino si trasforma in un atto poetico di dolore e rimpianto.
Spesso ci si chiede: perché leggere poesie, in questo nostro tempo così permeato dall’uso e spesso dall’abuso dei social e frantumato in una serie di impegni e di ruoli che ci vede sempre meno attenti, riflessivi, in corsa perenne?
Molte sono le riflessioni e le considerazioni che tale quesito stimola, vediamone alcune. La lettura delle poesie è un’esperienza che arricchisce la vita, offrendo un’esplorazione più profonda di sé, del mondo e delle emozioni, stimola la mente, nutre lo spirito e ci sollecita ad entrare in contatto con la bellezza e la complessità della condizione umana. Essa non è solo una mera attività estetica, ma un’esperienza intellettuale ed emotiva che ci aiuta a dare significato alla nostra esistenza, a crescere e a connetterci con gli altri.
Leggere poesie può sembrare un’attività superflua o elitaria, in realtà ci sono molte ragioni valide per cui la poesia merita di essere letta, essa offre esperienze uniche che vanno oltre la lettura di altri generi letterari, ed è in grado di arricchire la vita in modi profondi e significativi, aiuta ad approfondire la comprensione di noi stessi e del mondo, esplorando le emozioni, i pensieri e le esperienze umane, permette di riflettere su temi universali, come l’amore, la solitudine, la morte, la speranza, la bellezza, e la condizione esistenziale; può stimolare l’immaginazione e la creatività perché ricca di immagini, metafore e simboli. Leggere e riflettere su queste immagini può pungolare la nostra immaginazione e incoraggiare un pensiero più creativo. La poesia ci spinge a vedere il mondo in modo diverso, a guardare oltre l’ovvio e ad esplorare significati più profondi, coinvolgendo direttamente le emozioni.
Le parole scelte con cura, la musicalità del verso, il ritmo e l’intensità dei temi trattati possono risvegliare sentimenti potenti. Inoltre questo tipo di lettura, soprattutto quella più complessa o ricca di figure retoriche, costituisce un esercizio mentale arricchente per via della sua densità e della sua struttura a volte intricata, ci obbliga a fermarci e riflettere su ogni parola, su ogni verso, cercando di cogliere significati nascosti o sfumature sottili. In questo modo ci aiuta a migliorare la nostra attenzione, la comprensione e la capacità di pensiero critico. Infine ricordiamo che la poesia si configura come un patrimonio culturale che ha attraversato secoli e continenti, ne consegue che leggere poesie ci collega con le tradizioni letterarie, storiche e filosofiche delle diverse epoche, ne riflettono la mentalità, i valori e le sfide pur continuando a parlare della condizione umana in modo universale.
La presente antologia poetica “Conversazioni poetiche – Terza edizione” raccoglie le poesie di vari autori che da lettori sono diventati anche scrittori, possiamo a questo punto chiederci cosa spinge ancora oggi a scrivere poesie.
Scrivere poesie è un atto personale che può avere molte motivazioni e funzioni diverse, ma tutte queste ragioni sono accomunate dal desiderio di esplorare, esprimere, comunicare e trasformare. Che si tratti di un atto di introspezione, di una necessità di dare forma al mondo, o di un modo per connettersi con gli altri, la poesia offre un’opportunità unica per affrontare la vita e le sue sfide in modo creativo, profondo ed emotivo in quanto offre uno spazio in cui si possono esplorare e comunicare emozioni difficili da esprimere con parole comuni.
Sentimenti come la tristezza, la gioia, la solitudine, la rabbia, o l’amore sono resi in modo più profondo e intenso attraverso il linguaggio poetico. La forma poetica permette di distillare le emozioni in immagini potenti e suggestive e di riflettere su esperienze personali, sul mondo che ci circonda e sulle domande più significative della vita, come la morte, l’amore, il destino, e il significato dell’esistenza. La poesia aiuta a trovare un senso nell’incertezza, a dare forma al caos dell’esperienza umana e a comprendere meglio noi stessi e la realtà che viviamo.
Possiamo aggiungere che scrivere poesie è un atto terapeutico che permette di liberarsi da pensieri e suggestioni che altrimenti potrebbero essere repressi, un modo per dare libero sfogo a ciò che si ha dentro; in questo senso scrivere poesie può essere visto come una sorta di catarsi che aiuta a rilasciare emozioni dolorose o bloccate. Ancora ricordiamo che chi si diletta a scrivere poesie compie un atto estetico: molti poeti scrivono per creare qualcosa di bello, per esprimere la loro visione del mondo attraverso il linguaggio. La poesia è un’arte che gioca con le parole, le immagini, il ritmo e la musicalità, e può trasformare la realtà in qualcosa di straordinario e stimolante. Suggestivo è pensare che scrivere poesie sia anche un modo per comunicare e condividere il proprio mondo interiore con gli altri perché diventa un canale per esprimere pensieri, turbamenti, inquietudini, gioie, esperienze che sono universali e che altri possono riconoscere, condividere e sentire come propri favorendo una connessione in grado di toccare il cuore degli altri e di risvegliare emozioni simili.
Inoltre la poesia può essere un atto di auto-esplorazione; scrivere poesie permette di scoprire qualcosa di nuovo su se stessi, di esplorare il proprio inconscio e di dare voce a parti di sé che potrebbero essere nascoste, diventa uno strumento per conoscere meglio chi siamo, per dare forma alla nostra identità e alla nostra storia personale e spesso può diventare un modo per trasformare esperienze dolorose in qualcosa di bello, in un atto creativo che dà valore e significato a ciò che, altrimenti, potrebbe sembrare solo sofferenza.
Infine scrivere poesie significa donare qualcosa di se stessi che ci identificherà e resterà nel tempo a testimonianza del nostro essere vissuti.
Info
Acquista una copia de “Conversazioni poetiche – terza edizione”
Prima edizione de “Conversazioni poetiche”
Seconda edizione de “Conversazioni poetiche”
Leggi l’Introduzione di “Conversazioni poetiche – Terza edizione”
Acquista “Conversazioni poetiche – Terza edizione” dalla sito della casa editrice


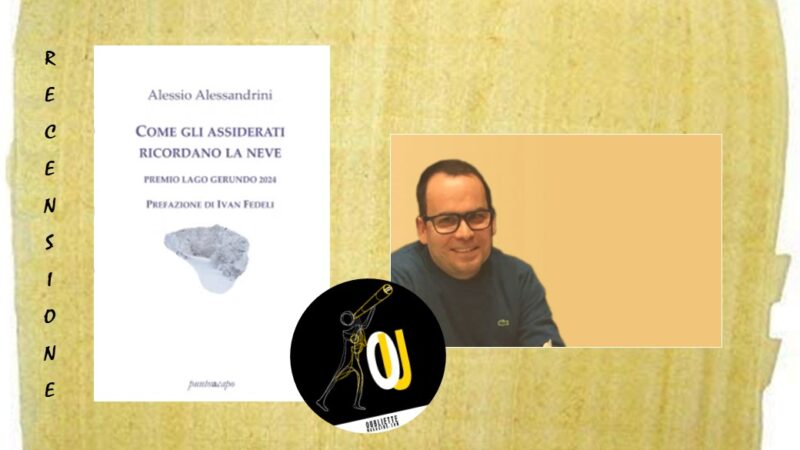
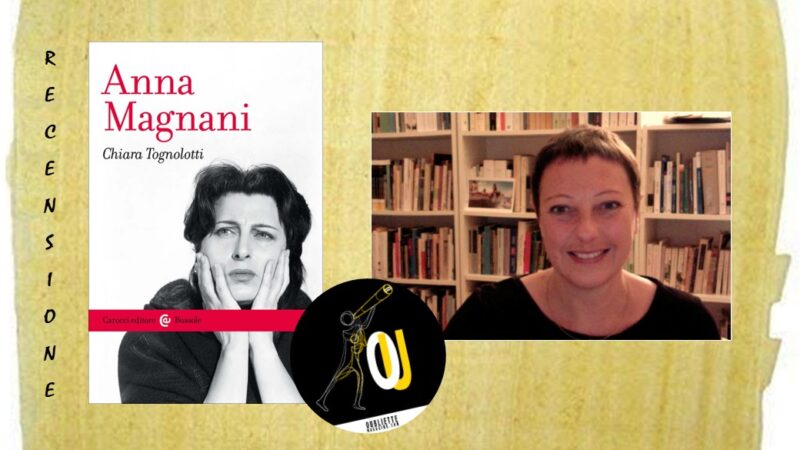
Chiedendo scusa ai Grandi citati sopra, umilmente do la mia definizione di poesia: ‘La poesia sono le ali del pensiero profondo dell’anima e della coscienza.’
Maricà
Complimenti a Giovanna Fracassa per la splendida prefazione.