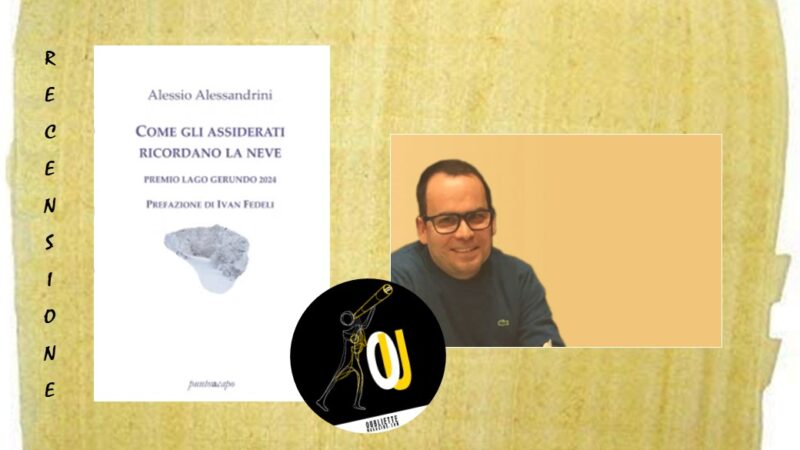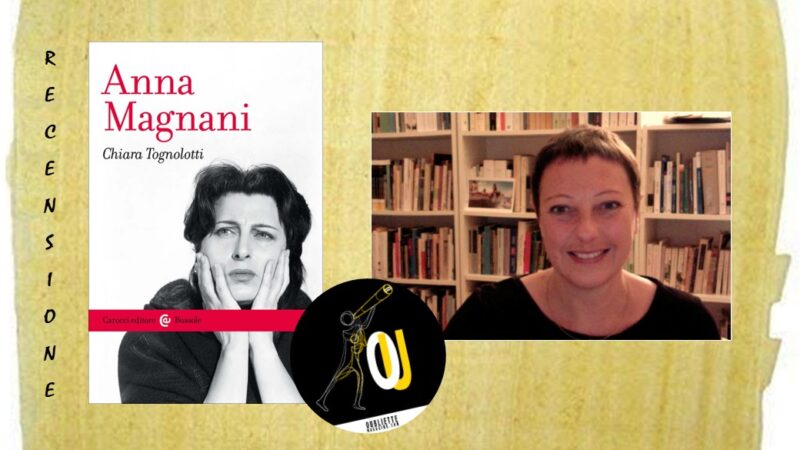“L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij” di Luca Mari: gli allevatori di ChatGPT
L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij di Luca Mari può parere e forse è l’ennesimo saggio sull’Intelligenza Artificiale (con le maiuscole evidenziate).
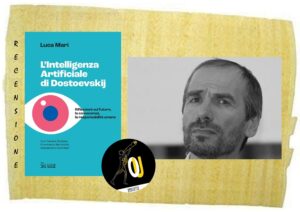
L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij ha però il pregio di essere sintetico, chiaro e illuminante. I suoi capitoli sono brevi ed efficaci, tanto che alcuni di loro sembrano articoli destinati a una vasta platea di lettori, e non solo a chi si occupa di tali questioni per passione personale, per studio o per lavoro.
Vorrei tranquillizzare l’eventuale mio lettore: il presente testo non mi pare sia stato scritto mediante ChatGPT.
Nella fascetta della quarta di copertina leggo che Luca Mari è un “professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche all’Università Carlo Cattaneo.” Nella stessa sono inseriti i dati di tre suoi collaboratori: un “Laureato in Giurisprudenza” (nonché “Vice-Direttore del Sole 24 ore”), un “Assegnista di Ricerca presso l’Università” poc’anzi citata e un “Professore ordinario in Logica, Epistemologia e Filosofia della scienza e docente incaricato per i corsi di Ontologia analitica presso l’Università Cattolica di Milano.”
Verrebbe da dire, e chi mi conosce la definirebbe una piolata, che se Luca Mari fosse una specie di “ChatGPT” sarebbe pertanto ben messo, cioè ben addestrato ad andare dove deve andare (come Totò disse a quel vigile milanese).
Al che mi viene da chiedermi: quanto ci metterà un CHATgpt a sparare ogni tanto delle piolate? Non sarebbe (forse) un progetto né facile né impossibile. Chissà mai se, un giorno…
Leggendo L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij m’è venuto spontaneo spesso di pensare a tale espressione retorica: Chissà se… Nel senso di: chissà quante e quanto belle ne vedremo…
“… cosa sta succedendo? Cosa ci succederà? In qualcuno prevale lo stupore per la novità.” – nulla può meravigliare l’uomo se non quel che è atteso come un futuro non del tutto inatteso: e questa sarebbe una mezza oscarwildata… oppure un’intera flaianata… Chissà se…
ChatGPT: “… cosa posso imparare di questo inatteso ospite? E, cosa da esso posso imparare su di me?” – e, aggiungo io: cosa esso (o egli?) può imparare su di me, che io vorrei tenergli celato? Io e lui, andremo sempre d’accordo? O si dovrà un non lontano giorno dire: Lui e io? Io reggerò lui, o Lui reggerà me?
Raccontava Nino Manfredi che sua nonna, prima di svestirsi la sera prima di andar a letto, qualora la televisione fosse ancora accesa, usava porre prudentemente un telone davanti allo schermo. Mia nonna chiese una volta al figlio, indicando lo speaker del telegiornale: ma lui ci vede? In una mattina del 1991, all’indomani della diffusione a livello planetario del virus telematico Michelangelo, una mia collega non volle toccare per tutto il giorno il computer. A chi cercava di tranquillizzarla, disse: Certe cose le si vengono a sapere soltanto dopo!
In Attraversare i muri, autobiografia della performance artist Marina Abramovic leggo che la sua famiglia benestante (nell’ottica della Jugoslavia dei tempi di Tito) alla fine degli anni ‘50, era riuscita a farsi inviare dalla Svizzera una prodigiosa lavatrice, però: “Mia nonna non si fidava di quella macchina, ci metteva dentro la roba da lavare e quando aveva finito la tirava fuori e la dava alla donna di servizio perché la lavasse a mano un’altra volta.” – e io mi chiedo anche cosa avrebbero pensato i nostri avi se avessero assistito alle celebri performance di Marina.
Mi capitò un giorno di calcolare una somma complessa con il programma excell e il mio anziano collega pretese di ricontrollare i conteggi con la macchina calcolatrice (lenta, vetusta e voluminosa). Suo padre probabilmente avrebbe preferito fare i calcoli con carta e penna.
Sic transit gloria mundi, e anche: panta rhei! Lo spazio/tempo, assicura Einstein, ha una sua natura curvacea, per cui, nel seguire il suo destino, gira dove pare meglio a lui.
“… la produzione degli input e l’interpretazione degli output sono sotto la nostra responsabilità.” – e chi saremo, noi? Chi proverà a coinvolgermi nel suo, nel loro e, infine, nel nostro? Chi sono loro? Intendo con loro gli allevatori di ChatGPT e affini.
Accennando al saggio di Luca Mari con Francesca, una ventenne iscritta al terzo anno di ingegneria informatica, mi sono accorto che le titubanze mie e quelle del di lei padre nei confronti dell’Intelligenza Artificiale non collimano come le sue. Ho attestato una notevole differenza, non solo psicologica, fra noi boomer (nati nel pieno del boom economico, che ebbe luogo alla fine degli anni ‘50 e alla metà degli anni ‘60) e le generazioni successive. Ogni tanto penso ai miei figli che normalmente scrivono i loro messaggi sul cellulare usando entrambi i pollici contemporaneamente: pare sia un fatto normale per le nuove generazioni.
A pagina 18 di L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij scopro un altro dato interessante: “l’intelligenza umana, nelle sue dimensioni etimologiche dell’intus-legere, il ‘leggere dentro’ e quindi il pensiero analitico, e dell’inter-legere, il ‘leggere attraverso’ e quindi il pensiero associativo, è un’attitudine che si alimenta di competenze disciplinari.”: quello che un tempo si diceva il saper leggere tra le righe…
Con quale modalità si cercherà di addestrare ChatGPT a leggere tra le righe? Quale sarà l’alimento verbale che sarà a Lui destinato? E da Chi?
Io riporto sempre il termine ChatGPT, ma leggo che ce ne sono altri che già oggi stanno girando in rete: il cyber spazio è anch’esso estremamente curvo e ricco di potenzialità, nonché, ormai, di sempre più svariati “chatbot”.
“… il percorso diventa non meno importante del suo punto di arrivo.” – come il guardare dal finestrino del treno i paesaggi che si susseguono? Come lo scorrere la sfilza di notizie del motore di ricerca che da qualche tempo, affettuosamente, io chiamo zio Google? Guarda caso, la maggior parte delle notizie che appaiono sullo smartphone riguarda certi miei interessi culturali e sociali. In un paio di occasioni mi sono addirittura imbattuto in miei articoli… Chissà se…
L’autore elenca “tre bisogni psicologici fondamentali” – che restano cogenti anche in presenza di “chatbot”. Sono tutti e tre indicati a pagina 22. Al momento è possibile leggerli forse solo sfogliando questo saggio (o il relativo e-book).
Amo il tuo modo di scrivere, Luca, quando fai un’affermazione che pare in prima battuta certa, a cui talvolta segue, una conseguente domanda che la rende instabile: “Si può imparare tutto, ma non ad avere emozioni e ad amare. Ma ne siamo così sicuri?”
Oppure: “i sistemi di intelligenza artificiale sono abilitati a prendere decisioni autonome (davvero questi sistemi sono capaci di prendere decisioni autonome?)” – a ciò ora aggiungo un banale quesito: come mai intelligenza artificiale è qui in minuscolo?
A pagina 33 riporti l’idea di “Cartesio” – il filosofo antipaticamente geniale mi viene da definirlo – il quale era certo, quanto può esserlo un cartesiano, che “gli (altri) animali sono macchine/automi…” – donatici dal nostro generoso Allevatore-Signore… Quest’ultima è solo una mia gratuita metafora.
Similitudini, metafore, allegorie, parabole: queste forme di retorica resteranno a lungo soltanto umane?
Umberto Eco e Riccardo Bacchelli (nonché Fabio Fazio) usano talvolta il discutibile pleonasmo Per intanto: capiterà anche ai chatbot? Quando la pianterò di mettere questo vocabolo in corsivo? Non dico mica automobile, e nemmeno lo automobile, come capitò a Filippo Tommaso Marinetti.
M’inquieta la nota 2 a fondo pagina che include un “https://” – ma sento che dovrei abituarmici ormai. Non serve più dovere uscire di casa per recarsi in biblioteca: basta un click!
Mi fa sorridere la tua affermazione (del tutto razionale) secondo cui “il nostro cervello” ha “soltanto processi elettro-chimici” – e non intendo affermare che ciò è assolutamente vero, ma che è verosimile. Ignoro, infatti, se vi sia o no quell’altra cosa: come la chiamano? Mi pare anima, o Anima, a seconda della quantità di fede che si professa.
Scoprendo che un “chatbot” può discutere in dialetto, mi domando, piolanamente, se egli sia al corrente che, a seconda della zona della provincia reggiana, si dice cajòun, cujòun e cojòun, tre termini che, a prescindere dal codice di avviamento postale, indicano sempre i medesimi cabasisi (detti anche didimi, dal greco didymos, fratello gemello). Un conto è saper parlare, un conto è possedere una corretta proprietà di linguaggio. Il mio timore, in fondo, è che un chatbot mi possa superare da un punto di vista glottologico. Un chatbot, non un chatbot.
Chissà se è questione di pochi decenni e poi anche un chatbot potrà scrivere un inclìto capolav… Chissà…
Notevole è quanto leggo a pagina 46: “Niccolò Copernico” e “Charles Darwin” ci hanno smaliziato “per quanto riguarda la cosmologia e la biologia” – ma ancora non abbiamo le idee chiare per quel che si riferisce alla “dimensione cognitiva”.
Nella pagina seguente, Luca, spieghi la differenza fra chi “nuota” e quel che “naviga”: da cui sorge la questione se il computer pensi oppure elabori soltanto.
Oggi l’uomo è ancora in grado di dirgli: “io ti addestro, e tu impari”. Per cui, anche per un chatbot vale il detto “sbagliando s’impara”. Chissà… fino a quando?!
Semini un impalpabile panico, quando scrivi: “Chi vuole accompagnarci, allacci le cinture di sicurezza per il resto del capitolo!” – che è il 5, forse il più importante del saggio, che è da leggere, e da meditarci su per un po’, prima di commentarlo con la dovuta serenità.
Nel successivo c’è scritto: “gli attuali chatbot non sono motori di ricerca che recuperano informazioni da fonti indipendenti…” – ma “dei fantastici, eloquenti parafrasatori e rielaboratori dei testi che sono stati fatti leggere loro durante l’addestramento.” – e chi sarebbe mai, anzi, chi è ora, chi sarà in futuro, il loro trainer? Un tipo alla Scopigno o alla Bearzot? Se non sei un boomer e vuoi sapere chi siano costoro, potrai sempre rivolgerti all’affettuoso zio Google o alla sapiente zia Wiki…
This, perhaps, is the real problem… Chi allena chi?! E perché?!
Può diventare una pericolosa incognita, oppure no?
A pagina 91 leggo che “un chatbot” non è sanzionabile. Sì, lo posso spegnere, ma qui, chi alla fine chi è sanzionato sono io, il fruitore, una volta che cesso di fruire del suo servizio.
M’inquietano e senz’altro mi destano meraviglia questi “Transformer” detti anche “reti neurali” – che non sono certo di aver capito con quale modalità agiscano.
A pagina 102 scrivi che “un chatbot non è dunque più un factotum” ‒ bensì “il coordinatore di un sistema di interfaccia” – il che mi ricorda che un tempo anche il capo-operaio era un lavoratore col colletto blu, con la tuta sporca di unto, mentre ora è un tecnico che agisce nel suo ufficio, in giacca e cravatta. Oppure in blue jeans…
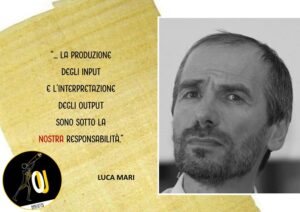
Da quel che scrivi a pagina 118, possiamo incominciare a imparare a dialogare con un Altro che non sia un peloso pet, bensì un sapido chatbot.
Prendo spunto dalla tua (non)-Conclusione – Imparare (a imparare) con i chatbot: una seconda lettera, per ricordare, più che altro a me stesso, che il primo libro di Jiddu Krishnamurti che lessi fu Cominciare a imparare. Quell’illuminante filosofo per anni ha cercato di farmi comprendere in che modo occorre liberarsi dal conosciuto (nel senso di non farsi condizionare da esso) per iniziare a conseguire una piena consapevolezza di quel che si è, e di quel che si fa.
Qualcosa dell’anima di Krishnamurti è entrato in me, nel mio modo di esistere e di pensare.
Ora anche un po’ della tua. Grazie, Luca.
Post scriptum: per comprendere l’accenno che nel titolo si fa a Dostoevskij, occorre leggere con attenzione il Capitolo 4, che attiene alla “responsabilità individuale” dell’uomo, così come fu descritto “nel capitolo Il grande inquisitore del romanzo I Fratelli Karamazov.”
Ergo: provare, addestrarsi, informarsi, decidere in piena consapevolezza, piuttosto che limitarsi a credere.
Questo mi permetto di suggerire al lettore del tuo lettore.
Written by Stefano Pioli
Bibliografia
Luca Mari, L’Intelligenza Artificiale di Dostoevskij, Il Sole 24 Ore, 2024