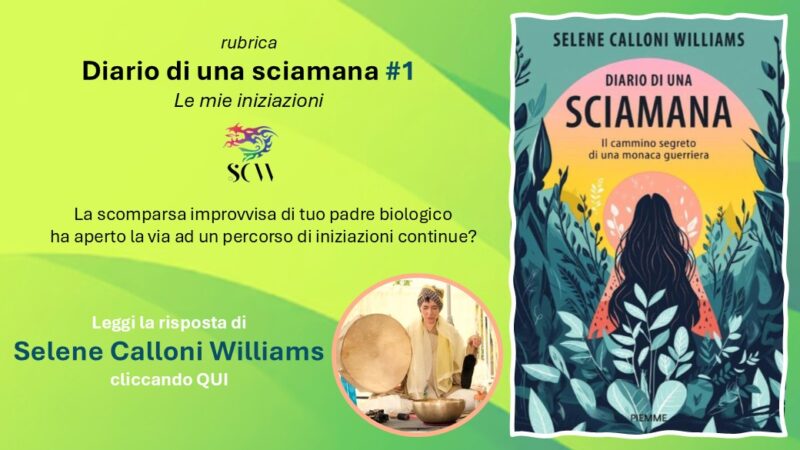Pier Paolo Pasolini: l’intellettuale scomodo su cui ci si interroga ancora oggi
“La tolleranza è sempre e soltanto ipocrisia.”
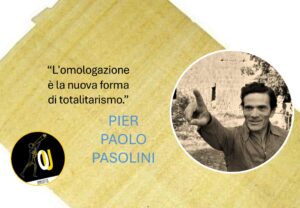
Cinquant’anni dopo la sua tragica e misteriosa morte, 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini non è un ricordo ingiallito. Ma è una presenza ingombrante, un fantasma che a tutt’oggi bussa alla coscienza collettiva italiana.
“La mia è una solitudine che grida.”
Poeta, scrittore, regista, giornalista e drammaturgo, Pier Paolo Pasolini è stato una figura scomoda nel paese del miracolo economico e delle sue contraddizioni.
Un intellettuale che, con la forza della sua arte e con le sue idee, ha indagato sulle malattie dell’Italia moderna con lucidità, e con parole che oggi più che mai appaiono profetiche.
“Siamo tutti in pericolo, l’unica differenza è che io lo so.”
Nato a Bologna nel 1922, il contesto familiare in cui cresce è segnato dalla disciplina e dalla severa presenza paterna, ma anche da una certa apertura intellettuale grazie alla madre, attrice dilettante e donna di grande temperamento.
Nel Friuli, che sarà il suo luogo dell’anima, scopre la sua vocazione poetica e la sua omosessualità; ed è una terra che lo segna profondamente dove trascorre i suoi anni formativi. Un ambiente epico in cui ha modo di osservare da vicino le contraddizioni e le dinamiche della vita rurale.
Affascinato dai dialetti, dalle lingue locali e dalle forme espressive popolari, a Casarsa del Friuli apprende il dialetto friulano, che per lui non è un dialetto, ma una lingua. Lingua, che secondo il poeta, è mezzo per preservare la cultura popolare e stigmatizzare la standardizzazione culturale della società italiana. E che diventerà per lui strumento di espressione poetica e forma per esprimere la propria identità.
“La borghesia ha paura del corpo perché ha paura della morte.” ‒ da Scritti Corsari
La formazione scolastica di Pasolini è complessa: a causa della guerra e di difficoltà economiche frequenta varie scuole, mostrando una predisposizione straordinaria per la letteratura, la poesia e il cinema.
Nel 1942, si iscrive all’Università di Bologna presso la facoltà di lettere, ma la guerra e le vicende familiari lo costringono a sospendere gli studi. Periodo questo, in cui gli eventi bellici, la povertà e la marginalità sociale lo portano a cercare tracce di un’umanità autentica e arcaica, contrapposta all’inquinamento della storia. Alimentando la sua sensibilità, che lo spinge a prestare attenzione agli ultimi e agli emarginati.
L’esperienza drammatica della guerra, e l’uccisione del fratello partigiano per mano di compagni di fazione, gli si presentano con una violenza ideologica che lo porta a sviluppare un rapporto conflittuale con la politica. Quando viene accusato di atti osceni è costretto ad abbandonare l’insegnamento e a fuggire a Roma con la madre.
Ma la Roma di Pasolini non è la città eterna dei papi e dei monumenti, ma quella delle borgate, del proletariato urbano che lotta per la sopravvivenza. Ed è proprio nei quartieri popolari che Pasolini trova una vitale energia primitiva, che lo spinge a dare spazio alla sua fertile creatività.
Ma Pasolini non è soltanto un poeta e uno scrittore: è un intellettuale totale, capace di attraversare vari linguaggi espressivi mantenendo un filo conduttore coerente. Sopraggiunto il dopoguerra, entra in contatto con il mondo culturale italiano, collaborando con riviste e quotidiani attraverso una narrativa che si concentra sulle trasformazioni della società italiana, sullo scontro tra modernità e tradizione.
Attraverso i suoi capolavori letterari, Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959), realizzati con uno stile letterario che fonde l’italiano colto con il gergo romanesco, dà voce a un’umanità di diseredati.
Descrivendo le bravate dei protagonisti, la loro quotidianità non proprio edificante, la disperazione di chi possiede poco o quasi nulla, con una lingua cruda e diretta capace di restituire la vita delle periferie, catturandone la realtà, ma senza edulcorarla.
I suoi romanzi scandalizzano l’opinione pubblica del tempo, ma confermano Pasolini come uno degli osservatori più sinceri e penetranti della società italiana.
Lo scrittore non si limita a raccontare storie: costruisce un ritratto etico di un’Italia in trasformazione, così divisa tra tradizione e modernità, povertà e aspirazioni di riscatto. Realtà raccontate con un verismo intriso di una pietas quasi religiosa, che provoca scandalo.
La sua narrativa, al contempo, segna un punto di svolta nel panorama letterario italiano del Novecento, introducendo temi sociali e morali prima di allora trascurati dalla letteratura mainstream.
Se la narrativa di Pasolini affascina per la sua capacità di restituire la verità cruda, il cinema lo consacra come visionario e maestro. Il passaggio al cinema è per Pasolini una necessità espressiva, un modo per raggiungere un pubblico più vasto attraverso l’immediatezza del linguaggio cinematografico. Realizzando negli anni Cinquanta del Novecento i suoi primi cortometraggi con un linguaggio originale, che fonde poesia e critica sociale.
Nel suo film d’esordio, Accattone (1961), la vita delle borgate viene elevata ad elemento epico e tragico insieme. Pellicola con cui il regista rivoluziona il cinema italiano, Accattone racconta la vita di un giovane protettore di prostitute della periferia romana interpretato da attori non professionisti.
Dimostrando così che il cinema può essere arte e denuncia, e strumento per osservare e capire e cambiare il mondo.
Altro capolavoro pasoliniano è Il Vangelo secondo Matteo (1964), film che ancora oggi incanta per la sua intensità poetica e spirituale. Dove il Cristo viene mostrato lontano dai potenti e vicino ai poveri, oltre che incarnazione di giustizia, compassione e autenticità: un simbolo di umanità che riflette la visione morale del mondo del regista.
Girato con uno slancio emozionante, che dà ad Accattone la connotazione di opera di neorealismo metafisico, il Gesù del film è descritto come un rivoluzionario che sta dalla parte degli ultimi.
Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una Notte (1974), sono un inno alla libertà, alla fisicità pura, contrapposti alla repressione messa in atto dalla società dei consumi. Opere, in cui Pasolini celebra la gioia carnale, la vitalità dei corpi e l’innocenza di un eros pre-borghese.
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) che rappresenta il suo testamento cinematografico, è una delle opere più radicali e scomode della storia del cinema.
È una trasposizione cinematografica del libro del Marchese de Sade nell’ultima repubblica fascista, che rappresenta una spietata allegoria del potere. Il film mostra come il potere assoluto (politico, economico) non sia solo repressione, ma una mercificazione tale da ridurre i corpi a una sorta di mercanzia che annulla ogni umanità.
Pasolini non teme di mostrare la crudeltà, l’ipocrisia e la fragilità dei suoi contemporanei, ma lo fa con uno sguardo celebrativo della vita e della verità, capace di rendere ogni personaggio, anche il più oscuro, pienamente umano.
Tanto che la critica cinematografica riconosce in Pasolini un regista capace di innovare il linguaggio filmico italiano, inserendo la narrazione popolare e la poesia in un contesto di forte denuncia sociale.
Nei suoi film la periferia, i borghi, i dialetti, le classi subalterne, diventano protagonisti e al contempo sono strumento di denuncia delle contraddizioni della società italiana, della sua ipocrisia morale e della mercificazione dei rapporti umani.
Diventando, negli anni Settanta, la voce critica di un’Italia che cambia rapidamente: il boom economico, il consumismo e l’omologazione culturale sono al centro della sua analisi.
Anche la sua visione del cristianesimo è poetica e critica, mostrando Cristo vicino agli umili e ai diseredati, lontano dalle gerarchie ufficiali, che si fanno simbolo di autenticità.
Negli ultimi anni, attraverso i suoi articoli sul Corriere della Sera, raccolti poi in Scritti corsari (1975), lancia i suoi anatemi più famosi. Con una lucidità che lo isola da destra e sinistra.
“Il vero fascismo è il potere che esercita l’uomo sull’uomo.” ‒ da Scritti Corsari
La mutazione antropologica, per esempio, tema che Pasolini affronta sostenendo che il fascismo vero non era quello storico, ma il nuovo potere rappresentato dal fenomeno del consumismo.
Secondo Pasolini, il miracolo economico ha distrutto la cultura popolare e contadina, compresi i suoi valori e i suoi dialetti, in quanto sostituita da un modello omologante del piccolo-borghese edonista e conformista.
“Il genocidio della cultura contadina è il vero delitto italiano.” ‒ da Lettere Luterane
Il poeta vede nella televisione il principale strumento di questa omologazione, un potere per plagiare le coscienze in modo più subdolo ed efficace del vecchio fascismo.
Accusa la sinistra di essere colpevole per aver abbandonato la classe operaia e i poveri; per abbracciare ipocritamente i valori borghesi del consumismo e del permissivismo.
A proposito della sessualità, Pasolini riconosce in essa uno strumento di conoscenza e di verità, un modo per porre l’attenzione sul principio di libertà come su quello della repressione. Sessualità, che se esplorata con coraggio e intelligenza, non deve scandalizzare o essere stigmatizzata.
Uno degli aspetti più interessanti del pensiero di Pasolini è avere coniugato denuncia sociale e riflessione filosofica. Aspetti che si sono declinati nella sua posizione di intellettuale scomodo, che ha denunciato ipocrisie, ingiustizie e violenze culturali, richiamando su di lui critiche feroci e persino minacce legali.
I suoi romanzi sono stati oggetto di processi per oscenità, e alcuni dei suoi film hanno subito censure e scandalizzato l’opinione pubblica.
La sua posizione politica è complessa: pur avendo legami con la sinistra, Pasolini non ha esitato a criticare il Partito Comunista italiano, accusandolo di aver tradito i valori della rivoluzione e dei subalterni.
“La televisione ha unito gli italiani nella stessa ignoranza.”
La morte di Pasolini, il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia, non è stata solo la fine di un uomo, ma un evento simbolico che ha segnato la storia italiana. Ucciso a bastonate e investito con la sua stessa auto da un diciassettenne, la versione ufficiale di una rissa per un approccio sessuale.
Tuttavia, le incongruenze processuali, le dichiarazioni ritrattate e la violenza dell’agguato hanno alimentato per decenni l’ipotesi dell’omicidio politico, di un mandante per silenziare la voce più scomoda del paese. In seguito, il responsabile dell’omicidio ha ritrattato, parlando di altre persone presenti.
Un mistero irrisolto che nel tempo è diventato la metafora perfetta di un’Italia che non ha voluto o potuto fare piena luce su se stessa, su quel groviglio di potere, corruzione e doppiezza che Pasolini ha descritto.
“L’omologazione è la nuova forma di totalitarismo.” ‒ da Scritti Corsari
Pier Paolo Pasolini è stato una delle voci più alte della cultura italiana del Novecento. Intellettuale poliedrico, dallo sguardo attento e dalla spiccata sensibilità, ha dato alle sue opere un indirizzo che ha attraversato poesia, narrativa, cinema e impegno civile. La sua vita e la sua opera hanno celebrato la libertà, la marginalità, la bellezza della lingua e della cultura popolare, sottolineando che l’arte può essere insieme strumento di conoscenza, denuncia e speranza.
È stato il poeta che ha cantato i perdenti, il regista che ha esplorato il sacro e il profano, il pensatore che ha visto nel conformismo la più grande minaccia alla libertà.
In un’epoca di omologazione globale, di social media che tendono ad appiattiscono il pensiero e di un consumismo che tutto divora, le sue parole risuonano più potenti che mai. Della sua presenza rimane un insegnamento importante, ovvero di guardare il mondo con occhi nuovi, riconoscere la dignità anche negli ultimi, e cercare verità e bellezza anche negli angoli più remoti e nascosti dell’umanità.
“Continuo a combattere le stesse battaglie, ma sono sempre più solo.” ‒ Ultima intervista, ottobre 1975
Written by Carolina Colombi