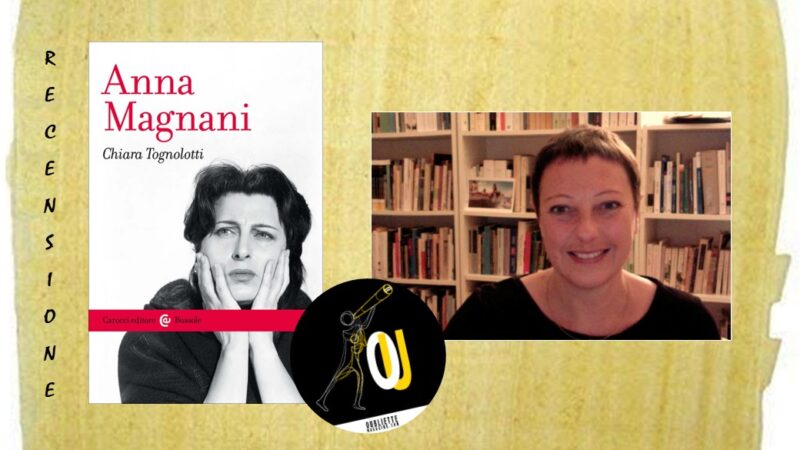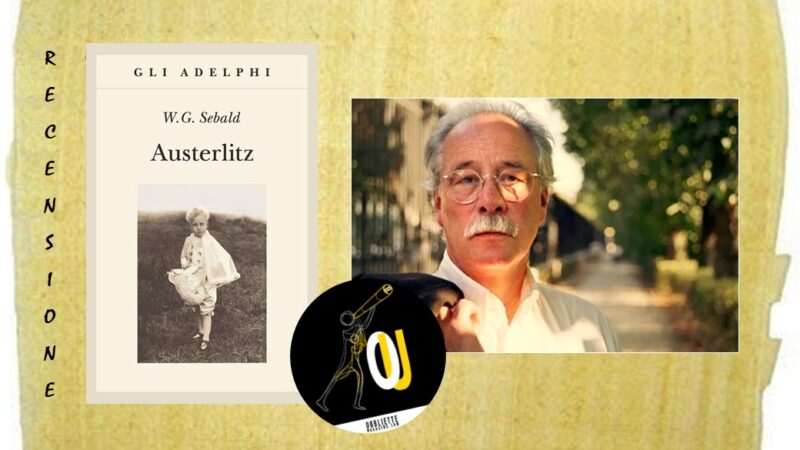“Come gli assiderati ricordano la neve” di Alessio Alessandrini: questa è l’ora di piombo?
Per fortuna esiste la poesia. Per fortuna esistono i poeti. Quante volte un pomeriggio storto può essere raddrizzato dalla lettura di versi potenti, catartici, puri e bianchi, anche quando questo bianco viene dal dolore!
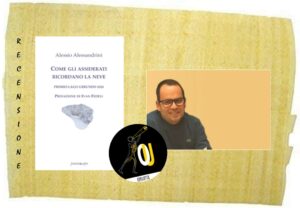
Ciò si evince dal titolo Come gli assiderati ricordano la neve di Alessio Alessandrini, edito per Puntoacapo Editrice nel giugno 2025.
Il titolo è mutuato dalla lirica di Emily Dickinson “Dopo un grande dolore viene un senso sublime” e in particolare dalla parte finale che recita così: “Questa è l’ora di piombo, e chi le sopravvive/ la ricorda come gli assiderati/ rammentano la neve”. Cito questi versi dalla traduzione italiana di Margherita Guidacci riprodotta nell’Edizione speciale dei versi della Dickinson ristampata a cura di RcsMediaGroup nel 2019.
Questa silloge di Alessio (è un collega e lo chiamo per nome, anche perché è un nome bellissimo!) è risultata Vincitrice del Premio Lago Gerundo 2024. Del libro colpisce la copertina bianca, scelta tipica della casa editrice da un lato, ma anche perfettamente in linea con la raccolta in oggetto.
Il volumetto Come gli assiderati ricordano la neve presenta una prefazione di Ivan Fedeli, alcune pagine di anteprima, quattro sezioni poetiche (Il freddo; Stupefazione; Infine, cedere; Gente, un’Appendice, i Ringraziamenti e le Note).
Vorrei partire dall’appendice: essa infatti, nonostante sia posta alle fine, costituisce il nucleo logico da cui deriva tutto il resto. Tale supplemento ha come sottotitolo Il lungo giorno bianco. I testi probabilmente sono stati composti durante quel lungo giorno bianco costituito dal Covid19 che, da un lato è stato senza fine, una somma di giorni tutti uguali, dall’altro è stato finalizzato a ottenere quel biancore, ovvero quella purezza caratterizzata dall’assenza di contagi, unico mezzo di salvezza fisica, ma anche motivo di disumanizzazione; il bianco richiama l’immagine delle mascherine, della disinfezione quotidiana la cui maniacalità, solo chi lavora nella scuola può comprendere. Ho insegnato per un anno nell’istituto in cui Alessandrini è vicepreside ed era un periodo ancora piuttosto delicato, nonostante i vaccini. Mi ricordo quanta attenzione venisse data (giustamente!) all’igiene.
Eppure, dove ha portato tutto ciò, per quanto utile e nobile nelle intenzioni? Così risponde l’io lirico nel componimento di apertura di questa sezione.
“Quel lungo giorno bianco/ che ci chiede di amare/ all’arma bianca.// Quel lungo giorno bianco/ che non si stanca di albeggiare/ e conta i suoi morti come passeri nel cielo.// Non chiedermi dov’ero/ seguo la rondine ed ecco/ anche la primavera avrà un suo nido.// Il lungo giorno bianco infinito è finito/ e poi il bacio, l’abbraccio, dolce il riso.”
L’anaforico “Quel lungo giorno bianco”, il parallelismo costituito dal “che” (vv. 2 e 4), il campo semantico del chiarore potenziato dal verbo “albeggiare” (v. 6) conferiscono al tema del bianco un carattere pervasivo, totalizzante, impediente, che si scioglie solo alla fine nell’ antitesi “Il lungo giorno bianco infinito è finito” a cui seguono, per ellissi, le conseguenze: “e poi il bacio, l’abbraccio, dolce il riso”; tale scioglimento conclusivo non deve far dimenticare i momenti bui come si legge in alcuni versi di un’altra lirica (la quinta della predetta sezione): “Il lungo giorno bianco/ si adagia agile e senza agio/ e compie il lavoro di sorte/ e sottrazione“.
L’iterazione dell’espressione “Il lungo giorno bianco”, formulare nell’appendice, l’allitterazione tra i sintagmi antitetici “si adagia agile” e “senza agio”, il richiamarsi anaforico della catastrofe “e… sorte/sottrazione”: tutto ciò è stato l’orrore di fronte a cui unica, disperata, irrazionale, ma autentica è stata la risposta del cuore: “Forse ci resta solo/ il coraggio dell’amore”.
A partire dalla suddetta aggiunta si possono apprezzare meglio, a ritroso, le altre parti dell’opera, poste prima e collegate tra loro mediante nessi sottili. Prima di tutto c’è Il freddo (sezione 1), in cui sono sinesteticamente accoppiate esperienze sensoriali diversi, come si evince da uno dei testi: “Vogliono cieli convulsi/ convulsi occhi d’amore, poi/ mettono la testa/ come struzzi nel biancore:/ quanto è pacifica questa/ assenza di/ calore/colore”.
L’esito del freddo è la Stupefazione (titolo della seconda sezione). Tra le poesie ne evidenzio una che presenta uno stupore talmente sui generis da spingere l’io lirico a richiamare Leopardi: ma è tutta fuffa, il tunnel del bianco è ineludibile e ci fa restare disumani, come ci siamo abituati in tempi di asetticità forzata: “Questi giorni dai colori netti/ accesi da un sorpasso di luce/ candidi come abiti da sposa/ nella loro pura vertigine.// Per poco il cor non si spaura// Ma dobbiamo impavidi/ entrare/ nel biancore”.
Nel testo di Alessandrini la citazione del Recanatese è graficamente e spazialmente distinta dagli altri versi. Alla fine, leopardianamente, occorre arrendersi “all’apparir del vero” e dunque, come pare suggerire Alessandrini nella sezione terza dal titolo Infine, cedere, occorre credere che il bianco sia solo purezza apparente: “Nel biancore si sfiorano le epidermidi/ incagliate in una brama di contatto/ Risale in superficie un grumo di sangue/ unico e presente e vivo// ha la forma di crepa, il cuore”.
Il biancore delle nostre mani, spaccate dal gel disinfettante durante l’emergenza sanitaria, spesso mostrava con maggior contrasto il rosso delle ferite, unico, presente e vivo, come “la presente stagione” dell’Infinito di Leopardi: era un varco che veniva dal cuore, immerso nel mare di Leopardi alias il mare di dolore cruento per la noia della pandemia: il legame è solo sulla carta, solo nei versi dove qualche polisindeto abbraccia le solitudini (“unico e presente e vivo!”); ma nella realtà resta la paura allitterante delle crepe del cuore.
E non esistono legami tra la Gente (titolo dell’ultima sezione) comprendente, in modo simbolico, solo una lirica, La gente: “Siamo gente./ Siamo la gente./ Siamo la gente là,/ quella là.// Siamo gente che raglia// (? Gentagia?)// Siamo niente/ Siamo il niente:/ voce (im)paglia (ta).// Voce impigliata/ a questa irreale// irrealtà”.
La simmetria tra gente e niente, le paronomasia sui generis (impagliata-impigliata), l’ossimoro a distanza (irreale/irrealtà), gli spazi e le risoluzioni grafiche del testo, restituiscono i temi di assenza, solitudine, straniamento, connessi alle varie forme di confinamento che hanno reso ancora più alienata la nostra società.
Ovviamente la Poesia del Nostro prof. ha valore universale: quello della pandemia è solo un esempio delle tante solitudini, del troppo bianco, della troppa distanza fisica a cui siamo costretti.
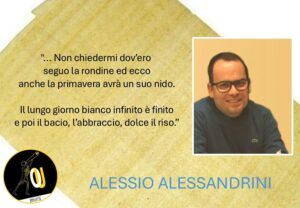
Ascoltavo l’altra sera nel programma In altre parole di Massimo Gramellini lo psichiatra Paolo Crepet che raccontava l’assurdo: i ragazzi di oggi si fanno i selfie, ma non si abbracciano.
La speranza è che la poesia di chi i ragazzi li conosce bene, come Alessandrini, possa aprire nelle loro anime un varco di speranza per permettere loro di sentirsi parte di un Tutto che li lega tutti tramite l’Amore.
Chi insegna deve amare i propri studenti, ascoltarli, capirli, leggere loro le poesie, consentire loro di scriversi lettere di carta in cui si scoprono e non si camuffano come quando mettono filtri nelle foto dei lori cellulari: perché il bianco delle mascherine, per quanto necessario, ha già fatto troppi danni alla prorompenza genuina dei loro bellissimi volti colorati e coloriti, da una corsa, da un sorriso, da un bacio, dal timido trucco, dal rossetto rosso.
E in effetti anche Alessio non rinuncia, nei suoi testi, a dar voce a una delicata e raffinata sensualità erotica: ma a questa chicca rinvio i nostri interlocutori affinché siano incuriositi ancor di più ad acquistare e leggere la silloge. Ad maiora, semper!
Written by Filomena Gagliardi
Bibliografia
Alessio Alessandrini, Come gli assiderati ricordano la neve, Puntoacapo Editrice, 2025