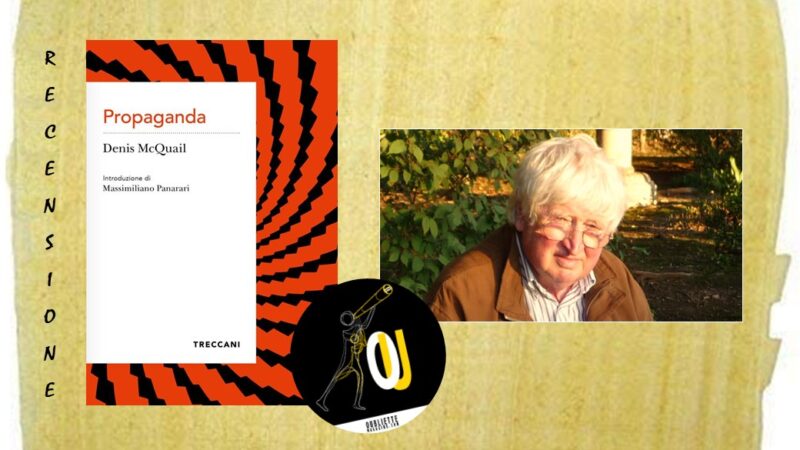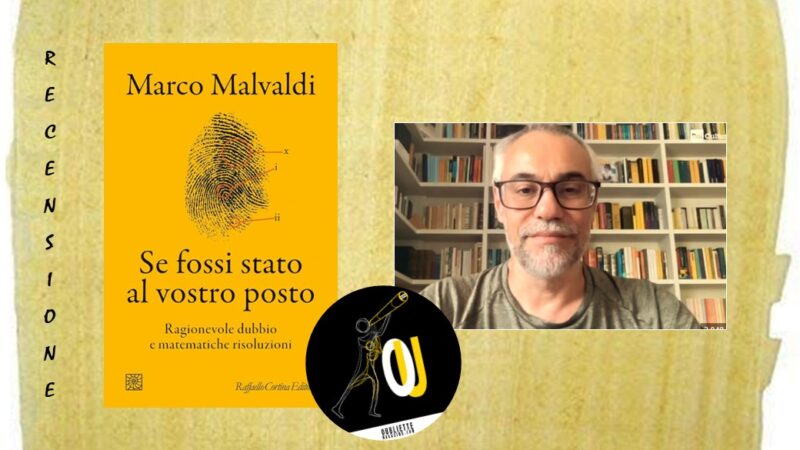“Sistemi democratici comparati” di Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi: il meccanismo dell’Occidente
“Sistemi democratici comparati”, il volume pubblicato ad inizio 2025 da il Mulino, si colloca nell’ambito disciplinare delle Scienze Politiche. È essenzialmente un’analisi comparata dei sistemi politici di cinque fra le più significative democrazie del mondo: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Sistemi democratici comparati presenta molti elementi di interesse, data l’attualità del tema affrontato. Il taglio del libro, pur essendo fondamentalmente di tipo accademico, è abbastanza pragmatico, in modo da fornire strumenti utili anche a chi abbia solamente un interesse civico o istituzionale verso questo tema.
Concordo con Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi sul fatto che per valutare al meglio i diversi sistemi democratici, il metodo migliore da adottare sia quello comparatistico. I due autori, con questa analisi, approfondiscono la conoscenza dei meccanismi di formazione dei governi, il loro funzionamento e il rapporto tra potere esecutivo e legislativo, senza dimenticare il sistema dei partiti, altrettanto importante.
Gli autori hanno scelto i cinque stati sopra riportati poiché ciascuno di loro rappresenta una categoria più ampia: gli Stati Uniti per i sistemi presidenziali; la Francia per i sistemi semipresidenziali, il Regno Unito per il governo del Primo Ministro; la Germania per il cancellariato e, infine, l’Italia per un modello parlamentare particolare, direi unico.
Il volume, dopo una prefazione iniziale degli stessi autori, si sviluppa in otto sezioni tematiche che prendendo il via dallo stato attuale delle cinque democrazie passa poi all’analisi dei comportamenti elettorali, alla formazione e dissoluzione degli esecutivi, al funzionamento dei governi, ai sistemi dei partiti e alla qualità delle democrazie. L’ultima sezione è dedicata alle buone pratiche di ingegneria politica necessarie ad affrontare le sfide contemporanee ai sistemi democratici nel modo più adeguato.
Ma cosa s’intende per democrazia? Sembra una domanda banale, ma non lo è, data la situazione esistente nel mondo, nella quale tanti regimi che di democratico hanno ben poco, pretendono di esserlo. Un’interessante definizione la troviamo nel primo capitolo de Sistemi democratici comparati [p.23]: «Democrazia è pluralismo. Pluralismo di opinioni, di scelte, di diritti (e doveri), di partiti, di assetti istituzionali. Fermi restando alcuni principi essenziali, a cominciare da elezioni libere, competitive, periodiche».
Per Pasquino e Valbruzzi non sono mancate le sfide a nessuno dei cinque sistemi politici oggetto della presente analisi, mai tali, comunque, da impensierire più di tanto. Con un’eccezione però, l’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021, a opera dei sostenitori dello sconfitto Presidente Donald Trump. Ciò nonostante, i due concludono il capitolo sostenendo che non vedono nessuna significativa regressione democratica.
Visto che il libro è uscito ad inizio 2025, non credo che al momento della sua stesura i due autori fossero al corrente della nuova vittoria di Donald Trump, ma soprattutto delle sue iniziative prese nei primi mesi di presidenza. A partire dal rapporto instaurato con la giustizia e a tutti i poteri a lui ostili, ma soprattutto riguardo alla grazia concessa direttamente da Trump ai suoi fans che assalirono Capitol Hill. Quest’ultimo atto è stato per me un vero e proprio schiaffo alla democrazia.
Il metodo comparato dagli autori permette comunque di individuare specifici oggetti e casi, scegliendo di volta in volta le metodologie più adeguate di confronto, non solo istituzionale.
Ad esempio, facendo riferimento alla Veto players theory, sviluppata dallo scienziato politico greco-americano George Tsebelis, Pasquino e Valbruzzi procedono ad una corretta classificazione dei sistemi politici in oggetto, considerando anche il numero di Veto players, ovvero di: “tutti quegli attori, istituzionali e partitici, il cui consenso è necessario affinché venga presa una decisione, vale a dire affinché lo status quo venga «spostato» o modificato” [p.65].
Andando poi all’analisi dei comportamenti elettorali, gli autori sviluppano una riflessione su come gli elettori decidono di votare, prendendo in esame soprattutto il tipo di sistema elettorale, il sistema dei partiti e le eventuali coalizioni.
Introducono inoltre la distinzione tra voto sincero e voto strategico nei sistemi proporzionali e maggioritari. A scanso di equivoci, meglio precisare cosa s’intenda con questa distinzione. Ogni volta che l’elettore, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, vota per il partito o per il candidato preferito, il suo voto è da considerarsi sincero. Nel caso in cui l’elettore, invece, voti non per il partito e/o candidato preferito, ma per un’altra opzione, con le motivazioni più disparate, si può parlare di voto strategico. Questa distinzione tra voto sincero e voto strategico viene analizzata alla luce dei diversi sistemi elettorali.
Viene preso anche in considerazione il caso del voto di scambio o clientelare, soprattutto in Italia quando era previsto il voto di preferenza. Ciò che tuttavia mi meraviglia è che Pasquino e Valbruzzi, nell’analisi dei comportamenti elettorali, non abbiano preso in considerazione il fenomeno dell’astensionismo, sempre più in aumento negli ultimi anni in molti paesi a tradizione democratica. Ritengo che l’astensionismo sia una delle patologie più gravi che possono colpire le democrazie nella contemporaneità.
Un altro degli elementi di criticità riportati, riguarda in particolar modo per l’Italia la possibilità di conoscere in anticipo la coalizione che si propone per il governo. In diversi casi l’aggregazione del governo è stata decisa dopo le votazioni, indipendentemente dalla volontà espressa degli elettori.
Le modalità di formazione degli esecutivi vengono prese in esame e descritte sia nei sistemi parlamentari sia in quelli presidenziali e semipresidenziali. Si analizzano i modi di formazione dei governi, ma anche le diverse possibilità di sfiducia degli esecutivi stessi. Si approfondiscono meccanismi come la sfiducia costruttiva (Germania), il modello Westminster (Regno Unito), e le particolarità di Francia e Stati Uniti.
Naturalmente si evidenziano anche i diversi problemi di funzionamento che si determinano nei diversi sistemi presi in esame. Come ad esempio: il governo diviso negli USA; la coabitazione in Francia; l’instabilità e l’indecisione nei parlamenti. Il confronto tra Regno Unito, Italia e Germania risulta particolarmente efficace per evidenziare punti di forza e debolezza nei sistemi parlamentari.
L’analisi include anche i sistemi di partito, le modalità di competizione o di aggregazione esistenti tra i partiti, e gli strumenti di intervento per migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei sistemi partitici. La riflessione si collega anche alla governabilità, valutando sistemi presidenziali e parlamentari in termini comparati, per comprenderne in modo approfondito la qualità democratica.
Nella parte finale, i due autori propongono la loro idea di ingegneria politica: diretta a far fronte alle sfide contemporanee attraverso scelte istituzionali sagge e informate, favorendo governi stabili, processi decisionali efficaci e sistemi democratici resilienti.
Sistemi democratici comparati si presenta complessivamente come un testo scientificamente rigoroso, ciò nonostante accessibile, ovviamente per chi abbia un minimo di conoscenza delle basi della teoria politica. È arricchito da numerosi esempi di casi concreti, di confronti diretti tra i diversi sistemi presi in esame e di riflessioni teoriche.
Written by Algo Ferrari