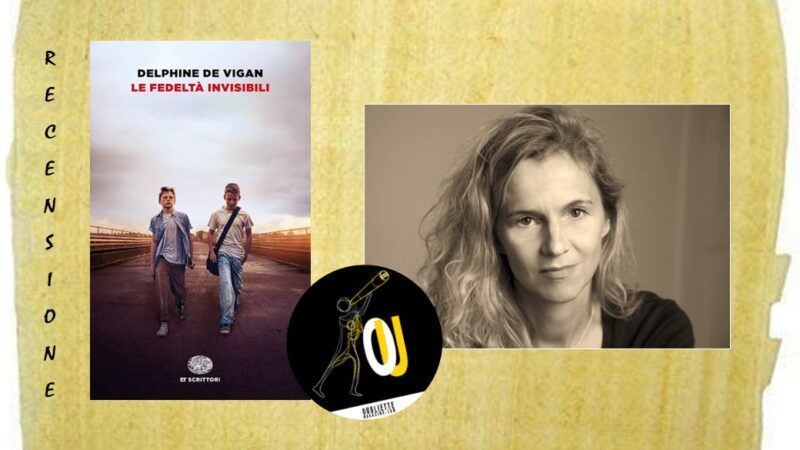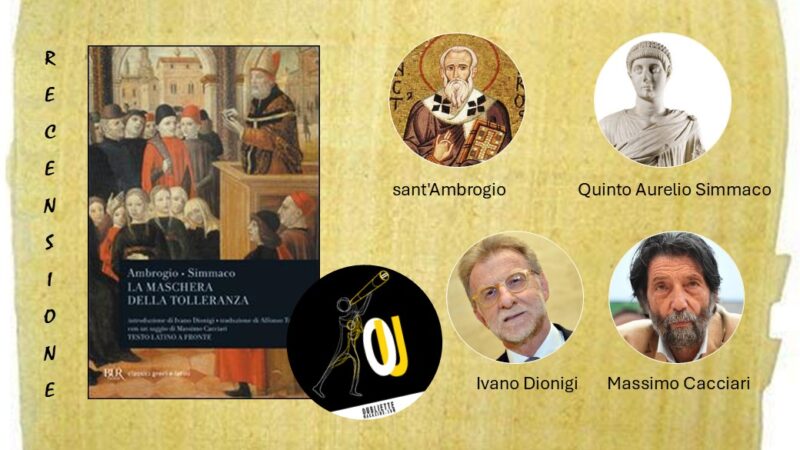“Anime Baltiche” di Jan Brokken: tante storie per un quadro unitario
Anzitutto, con Alessandro Marzo Magno, condividendo la sua postfazione, ritengo indispensabile un approccio a questo libro libero dai più sedimentati pregiudizi o anche dai più reconditi stereotipi sulle popolazioni baltiche.

I paesi presi in considerazione da Jan Brokken, scrittore e viaggiatore olandese, ne “Anime Baltiche” (Iperborea, 2014) sono: Lituania, Lettonia, Estonia e Kaliningrad (la vecchia amata Koninsberg di Kant), ma anche le regioni della Curlandia e della Livonia, con le loro peculiarità.
Si, perché «i paesi baltici non costituiscono una struttura unitaria né per quanto riguarda il passato né oggigiorno, non in chiave politica e neppure in quella economica, ben poco dal punto di vista culturale e per nulla affatto dalla coscienza delle popolazioni locali»[1]
Non a caso, Jan Brokken ha scelto come forma di imbastire questo libro quello del puzzle.
Solo alla fine della lettura, come d’incanto, si scopre un quadro unitario, composto di tante storie, di tante immagini, mai scontate.
Sono storie complesse, spesso dimenticate, difficili da ricostruire, immagini multidimensionali dove le etnie e le culture s’incontrano, a volte confliggono e a volte si combinano tra loro.
Sono terre dove le dominazioni si sono succedute e dove spesso i confini si sono modificati.
Cosa meglio delle storie personali e delle saghe famigliari possono raccontare questo mondo?
Emergono dal libro “Anime Baltiche” tanti nomi, ovvero tante “anime” della cultura mondiale nate nei paesi baltici: Mark Rothko, Hannah Arendt, Arvo Pärt, Roman Gary, Janis Roze, Gidon Kremer, Mikhail e Sergej Eisenstein, per citarne alcuni.
Nel primo capitolo del testo dal titolo: “Orgoglio”, Brokken parla di come il viaggio fatto quasi per caso in una piccola città portuale del golfo di Riga, costituisca la scintilla iniziale per scrivere il suo libro. Sulle prime, infatti, fu il suo amico Huig, marinaio di lungo corso, a fargli cogliere la bellezza dei luoghi, a cominciare dal mare.
Secondo i marinai il mar Baltico è il più bello di tutti. Ciò che lo rende speciale è la sua luce, morbida e calda. Una luce che in autunno s’infiamma.
«La calma del Baltico, l’orgoglio dei baltici, quella fierezza che Huig, con l’occhio accorto dell’uomo di mare, aveva saputo cogliere con tanta sicurezza al primo sguardo»[2], hanno dato la spinta a Brokken a voler approfondire la sua conoscenza di queste terre e di questi uomini.
Scrive tuttavia l’autore ne “Anime Baltiche”: «L’orgoglio non ha nulla a che vedere con il nazionalismo, lo sciovinismo o l’arroganza. Essere orgogliosi del proprio paese significa credere in tutto ciò che lo rende speciale, diverso, unico. Significa avere fiducia nella propria lingua, nella propria cultura, nelle proprie capacità e nella propria originalità. Questo orgoglio è la sola risposta adeguata alla violenza e all’oppressione».[3]
Al secondo capitolo, dedicato alla storia del libraio Janis Roze e della sua famiglia, Brokken ricorda una data molto importante, quella del 23 agosto 1989 (anniversario del Trattato Ribbentrop/Molotov) quando estoni, lettoni e lituani si presero per mano per formare una catena umana di seicento Km. sulla Via Baltica, da Tallin a Vilnius. Con quella pacifica manifestazione di massa costrinsero il Cremlino a concedere l’indipendenza.
Nel terzo capitolo si racconta della dinastia Eisenstein. Tra gli architetti più famosi dell’Art Noveau che hanno operato a Riga, vi era, infatti, anche Mikhail Eisenstein, il papà del famoso regista cinematografico Sergej Eisenstein, nato appunto a Riga e autore di capolavori di epoca sovietica di grande valore iconico, come, ad esempio, La Corazzata Potemkin e Ottobre.
Mi ha poi colpito particolarmente il capitolo nel quale l’autore racconta della Königsberg di Immanuel Kant e di Hannah Arendt, quella città che purtroppo non esiste più e che ora si chiama Kaliningrad, in pratica un’enorme base militare navale russa riempita di testate nucleari e casinò.
Scrive Brokken: «La città di Hanna Arendt non c’è più. I palazzi monumentali, le università, il castello, i teatri, le sale da concerto, le stradine e i negozi sono scomparsi; dei magazzini dal profumo di tè, delle dimore patrizie della città anseatica non rimane più nulla.»[4]
La responsabilità della distruzione della vecchia e romantica Königsberg va suddivisa tra diversi soggetti. Dapprima la responsabilità fu dei nazisti, che si trincerarono in un enorme bunker dietro le mura del castello conferendo alla città l’aspetto di un’enorme fortezza, secondariamente ai bombardieri alleati, successivamente ai sovietici e oggi ai russi.
Scrive l’autore: «In poche città la luce dell’illuminismo splendette più intensa, in poche città si spense altrettanto bruscamente»[5].
L’unica consolazione è che lo spirito di Königsberg continua a vivere nelle idee che Immanuel Kant e Hannah Arendt ci hanno trasmesso.
Un altro capitolo che mi ha appassionato molto è quello dedicato a Mark Rothko, un pittore le cui opere io adoro. Brokken racconta del suo viaggio in treno verso la cittadina lettone di Daugavpils, che letteralmente significa “Castello sulla Daugava”.
Dal finestrino egli osserva i due colori dominanti: il rosso del cielo e il verde dei boschi. Sono superfici quelle che vede, in alto e in basso, sono contrasti che hanno bisogno uno dell’altro. Praticamente ciò che l’autore vede è un quadro di Rothko.
Marc Rohko nacque il 25 settembre 1903, da genitori ebrei, con il nome di Marcus Rothkowitz a Dvinks (il nome russo di Daugavpils) dove visse fino a dieci anni, per poi partire con la famiglia verso l’America.
Il padre volle sfuggire con la famiglia alle tremende violenze che ebrei, socialisti e rivoluzionari subivano in quegli anni dallo Zar. Nel capitolo Brokken racconta nel dettaglio tutta la travagliata storia della famiglia Rothkowitz in quella parte di Russia che attualmente è divenuta Lettonia.
In America, Marcus si sentì fin da subito un emarginato e tale rimase, a suo dire, per tutta la vita. Solo nel 1938, dopo un quarto di secolo dal suo arrivo negli States, ottenne la cittadinanza americana. Nel 1940, su suggerimento di un mercante d’arte newyorchese cambiò il suo nome in Mark Rothko.
Brokken riporta ciò che disse il collezionista svizzero Ernst Beyeler della pittura di Rothko: «Le tele pongono domande all’osservatore e lo inducono alla meditazione. Se cerchi le forme abbastanza a lungo, alla fine rimescoli i colori e trovi la luce che hanno dentro.»[6]
Una luce che possiede una dimensione mitica e mistica. In altre parole: sacra.
L’ultimo capitolo del libro “Anime Baltiche” riguarda la vita e le opere di Arvo Pärt, compositore estone abbastanza famoso nel mondo. Dopo gli esordi, in cui il suo linguaggio utilizzava tecniche come la dodecafonia e il collage, fu coniato proprio per la sua musica il termine di minimalismo sacro, di cui è un riconosciuto esponente assieme ad autori come Henryk Górecki e John Tavener.

Arvo Pärt nacque l’11 settembre a Paide, piccola città a settanta chilometri a sudest di Tallin. La sua vita, anche dal punto di vista dell’impegno politico e religioso fu abbastanza travagliata. Nel 1968 aderì alla chiesa russo-ortodossa e compose “Credo”. Per Pärt che non proveniva dalla minoranza russa d’Estonia ma dalla maggioranza estone, battezzato luterano, fu una scelta dirompente per il sistema comunista vigente, che imponeva l’ateismo. Come scrive Brokker: «non era la musica in sé a creare problemi, ma l’ideologia. Il pezzo aveva una forte connotazione religiosa.»[7]
Negli anni ’70 le autorità sovietiche spingevano gli ebrei a emigrare in Israele. Siccome Nora, che Pärt aveva sposato in seconde nozze nel 1972, era ebrea, anche loro, nel 1980, decisero di partire. Sennonché a Vienna, Arvo Pärt ricevette dalla Universal Edition un invito a rimanere a Vienna e così fecero. Anche se dopo poco decisero di trasferirsi a Berlino ovest, dove restarono anche dopo la caduta del Muro.
Dopo l’indipendenza ottenuta dalla Lettonia, Arvo Pärt si recherà regolarmente a Tallin per tenere concerti ai massimi livelli.
Vorrei concludere questo resoconto del libro con la bella esortazione di Jan Brokken che viene riportata anche sulla quarta di copertina: «Perché viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare a se stessi.»
Written by Algo Ferrari
Note
[1] Ralph Tuchtenhagen, “Storia dei paesi baltici”, 2005
[2] Jan Brokken, “Anime Baltiche”, 2014
[3] Ivi c.s.
[4] Ivi c.s.
[5] Ivi c.s.
[6] Ivi c.s.
[7] Ivi c.s.