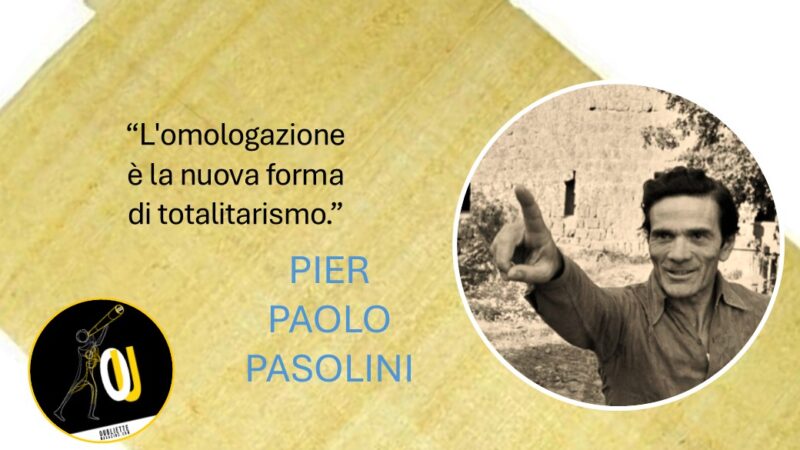Adelina Tattilo: Mrs Playmen, la pioniera dell’erotismo elegante
“Adelina riporta la bellezza sulla terra.” ‒ Leslie Child, The Sun
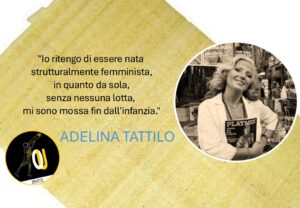
Ideata da Mario Ruggeri e presentata in anteprima al Festival del cinema di Roma, il 12 novembre 2025 è uscita su Netflix “Mrs Playmen”, serie in sette puntate che ripercorre la storia di Adelina Tattilo, l’editrice che negli anni Settanta diede alla luce la più nota rivista erotica italiana, con la libertà morale e l’audacia dell’outsider. A darle corpo, l’attrice romana Carolina Crescentini.
Ma chi è la donna che osò sfidare sul suo terreno Hugh Hefner, il magnate di Chicago che aveva ideato la rivista patinata men only “Playboy”, e il cui attico romano fu a lungo uno dei salotti più ambiti dell’alta società capitolina?
“Gli Stati Uniti sono un matriarcato. Penso che sia questa la ragione per cui gli uomini americani preferiscono le donne con seni esagerati, giovani balie asciutte dal rassicurante aspetto materno. La donna americana dovrebbe pensare a liberare se stessa, dal proprio mito che minaccia di schiacciare il maschio americano.”
Se voleva far infuriare Hugh Hefner, Adelina Tattilo non poteva utilizzare parole più efficaci di quelle apparse il 18 gennaio 1971 su “Time”, il prestigioso settimanale che le dedicò un articolo di due pagine dal titolo “Donne, non ragazze”.
Fu un attacco improvviso quello della proprietaria di “Playmen”, un’incursione corsara in terra nemica che celava una strategia precisa e puntigliosa: scalzare le “conigliette” della rivista americana dall’immaginario erotico maschile, sostituendole con un modello più aderente alla realtà.
Nata a Manfredonia in una famiglia di lontane origini aristocratiche, terza di otto fratelli, dopo aver ricevuto la tipica educazione ancorata ai valori della tradizione cattolica, Adelina si imbatte nel tipico coup de foudre innamorandosi di un fascinoso vicino di casa, Rosario “Saro” Balsamo, marchese di San Felice e sedicente discendente di Cagliostro, con il quale convola a nozze poco più che diciottenne.
Insieme al marito, ammaliatore carismatico in possesso di un ego di magnitudo infinita, si trasferisce a Roma, iniziando un’intensa vita sociale con finalità di pubbliche relazioni. Mentre Adelina si occupa della casa, secondo la migliore tradizione meridionale, Saro, già organizzatore di manifestazioni canore ed eventi mondani, si affida al suo fiuto non comune nell’anticipare lo Zeitgeist dando vita prima a “Big”, testata nata nel 1965 per dar voce al mondo giovanile e assurta al rango di rivista cult con tirature fino a ottocentomila copie, poi a “Men”, uscito in edicola l’anno dopo a imitazione di “Le Ore”, l’innovativo settimanale che, a partire dal 1953, ha riunito firme come Antonio Ghirelli, Alberto Bevilacqua, Luciano Bianciardi e Morando Morandini.
Poi, nel 1967, ecco l’intuizione della vita: “Playmen”. Progettato con la complicità sorniona di Guglielmo Solci, Paolo Bernobini e Bruno Modugno, Balsamo individua nell’erotismo intelligente il nuovo terreno di conquista su cui piantare la bandiera della liberazione sessuale, e nel giugno di quell’anno la neonata rivista fa capolino in edicola al costo di 500 Lire, presentandosi al pubblico con il sorriso ammiccante di una ragazza bionda in un casto déshabillé, e annunciando al proprio interno articoli di Emilio Servadio e John Schlesinger Junior, a cui si aggiunge tale Homerus S. Zweitag, un improbabile filosofo canadese che altri non è se non il funambolo Franco Valobra, un ex collaboratore di “Le Ore” con il dono del pensiero laterale e beniamino di colui che diventerà il deus ex machina della rivista, il direttore Luciano Oppo.
È una redazione composita quella di Balsamo, che aggrega personaggi come Francesco Cardella e Massimo Balletti, Mario Castellacci e Pierfrancesco Pingitore (futuri ideatori del Bagaglino), con l’aggiunta di tipi estemporanei come il barone bibliofilo Enrico De Boccard.
Un inner circle eccentrico, refrattario ai diktat dell’intellighenzia mainstream, e che si compiace di condividere una certa sfumatura di affinità, sempre all’inseguimento delle linee più estreme del pensiero. Il risultato è una rivista che, coniugando edonismo e costume, cultura e giornalismo d’inchiesta, si incarica di far evaporare i miasmi che circondano l’erotismo per regalargli un respiro più ampio. Nelle mura del comune senso del pudore nazionale si apre una breccia, e la reazione clericale e benpensante, a cui dà man forte quel giustizialismo alla Torquemada che ha sempre grufolato e sguazzato nella fanghiglia della pruderie (non si conteranno i sequestri giudiziari della rivista presso le edicole), porta a uno scontro sul terreno della libertà di parola, vessillo difeso da firme come Mario Soldati, Dacia Maraini e Luciano Bianciardi, che arrivano a proporre l’abolizione dell’art. 528 del codice penale, caposaldo della legislazione giuridica inerente la pornografia.
Quando poi, come pervaso da un’indomabile urgenza di grandeur (fra truffe bancarie, lusso smodato, follie notturne al casinò, infedeltà varie con corollario di violenze domestiche), la vita di Balsamo scivola sul piano inclinato della dissolutezza, per sopravvivere alle cose che accadono l’editore non trova di meglio che ritagliarsi un’esistenza da latitante fra Svizzera e Costa Azzurra.
E mentre il matrimonio va a rotoli, con conseguente tumultuoso divorzio, come capita a molte donne Adelina Tattilo scopre dentro di sé quello spirito battagliero che fino a quel momento era rimasto stretto in un angolo di silenzio e irrilevanza. Così, nel 1969, acquista le azioni dell’ex marito, fonda la Tattilo Editrice s.p.a., chiude “Big” (e in seguito “Men”) e punta tutte le sue fiches sul tavolo della roulette “Playmen”. Smettendo di essere satellite e diventando pianeta, l’ex ragazza silenziosa cresciuta nell’ombra di un marito egomaniaco prende saldamente il timone e conduce il progetto ancora più in là, nel mare aperto in cui da tempo naviga indisturbata la corazzata “Playboy”.
Perché è la rivista di Hugh Hefner il modello di riferimento, la prima a coniugare erotismo e letteratura, quella che ospita racconti di Ian Fleming, Arthur G. Clarke e Alberto Moravia, articoli di Alfred Kazin, Leslie Fielder e Nabokov, e interviste a nomi come Fidel Castro e Malcom X.
“Playboy”, che in America vende cinque milioni di copie; la rivista patinata uscita nel dicembre del 1953 con in copertina Marilyn Monroe, e che vanta un’ampia foliazione di pagine dedicate alla letteratura.
“Spero che Playmen contribuisca in modo intelligente a modificare certi atteggiamenti arcaici degli uomini e delle donne italiani nei confronti dell’amore e del sesso”, afferma la Tattilo, femminista moderata e sui generis, che inserisce due suoi periodici (prima “Stress”, poi “Libera”) nel dibattito dei movimenti femminili e che è vista con sospetto da quella parte intransigente del movimento che strizza l’occhio al Cell 16 di Boston e al suo testo di riferimento, “Il Manifesto per l’eliminazione dei maschi”, di Valerie Solinas (1968), la bibbia atea del femminismo da battaglia più radicale, dove si legge che “il sesso è il rifugio dei poveri di mente, e più la donna è povera di mente, più profondo è il suo incastro nella cultura maschile”.
È un guanto di sfida estetico quello lanciato dalla Tattilo all’illustre rivale; le donne che appaiono in copertina su “Playmen” sono più snelle e raffinate, più reali, verrebbe da dire. Hefner propone il genere della biondona ipervitaminizzata, che riflette una sorta di distorsione pornografica, perché nell’indirizzare il desiderio verso un modello femminile distante e irraggiungibile inevitabilmente asseconda un piacere effimero e illusorio, che ha come ritorno indesiderato il senso di frustrazione, che altro non è se non il beffardo effetto boomerang restituito dalla realtà.
Tuttavia Hefner non sta a guardare, e dopo essere sbarcato in Italia facendo nascere il “Playboy” italiano edito da Rizzoli, intenta una causa contro la Tattilo per concorrenza sleale e contraffazione del marchio. E la vince. Il tribunale di Milano delibera infatti l’inibizione all’utilizzo del nome Playmen, costringendo l’imprenditrice pugliese a bloccare le riviste in preparazione e a ritirare quelle distribuite.
Siamo nell’estate del 1972. Ma Adelina Tattilo non è donna che si dà per vinta facilmente, il ruolo di Davide che sfida il Golia a stelle e strisce la esalta, e allora risponde nelle aule giudiziarie con l’appello alla sentenza del tribunale di Milano, preparando intanto in gran segreto uno scoop pronto da tempo: le foto di Jaqueline Kennedy in costume adamitico scattate nell’isola di Skorpios, dove l’ex first lady statunitense trascorreva un periodo di vacanza con il consorte Aristotele Onassis.
E così, mentre in appello la situazione viene clamorosamente ribaltata (la quaestio verte sul termine “playboy”, che in primo grado viene ritenuto originale al punto di tutelarne il marchio, mentre in appello è considerato di uso corrente, registrato nel vocabolario ben prima che la rivista sbarcasse in Italia, pertanto non suscettibile di appropriazione esclusiva), decisione successivamente confermata in Cassazione, nel numero di dicembre del 1972 appare il sevizio su Jaqueline Onassis, e l’effetto è quello di un gancio improvviso che manda al tappeto il rivale.
“Playmen” va a ruba e raggiunge le 450.000 copie vendute, più del triplo rispetto alla tiratura normale, surclassando “Playboy”. Ma se la battaglia è vinta, la guerra si preannuncia lunga e difficile, vista la potenza economica di Hefner, in possesso di una propria distribuzione e di una superiore capacità di penetrazione. Eppure, i riscontri in edicola non sono soddisfacenti, e dopo il boom iniziale “Playboy” decresce intorno alle 50000 copie vendute, non insidiando “Playmen”, che viaggia ben oltre quota centomila.
Poi, con l’arrivo di Paolo Mosca alla direzione, la rivista di Hefner riesce a smarcarsi dal rigido controllo editoriale della casa madre assumendo dei connotati più conformi al modello della rivista rivale. Il duello diventa allora più equilibrato, e continuerà a esserlo negli anni successivi, perché alla potenza economica del rivale la Tattilo risponde con le sue truppe d’assalto, forti di fotografi come Mimmo Cattarinich, Franco Marocco e Roberto Rocchi, di firme come quelle di Franco Bevilacqua, Alberto Moravia, Giovanni Arpino, e capaci di interviste a personaggi come Andy Warhol, Henry Miller, Gabriel García Márquez e William S. Burroughs.
Dai salotti glamour della sua redazione, Adelina Tattilo, colei che Henry Kissinger definì “Smart and gorgeous”, allargò i confini del comune senso del pudore approfittando dell’erotismo charmant della sua rivista per trattare non solo le pulsioni che covavano sotto il fard del perbenismo ma anche i temi scottanti del dibattito contemporaneo, dai rapporti di coppia al divorzio, dall’aborto alla liberazione sessuale. Fu in un certo modo un impegno civile, il suo, rivolto a un pubblico imbevuto di cultura religiosa, con l’ambizione di stimolarne i pensieri e mutarne la direzione. Erano i Settanta, anni di libertinismo e ossessione sessuale, se è vero che Roland Barthes scriveva che “la vera oscenità era evocare il sentimento amoroso”.
Da allora, sembra trascorsa un’èra geologica, e in questa nostra epoca di consumismo sessuale in stile YouPorn e di immagini di nudo generate dall’intelligenza artificiale, la domanda che sorge spontanea è se quell’epoca di rivoluzione sessuale, più che cambiare il rapporto con il sesso, non abbia in qualche modo annunciato la deriva di gran parte dell’immaginario erotico dominante.
Written by Maurizio Fierro
Bibliografia
Dario Biagi, Adelina Tattilo. Una favola sexy, Odoya edizioni