“Angela Davis” di Raffaella Baritono: icona della rivolta antirazzista
«Volevo continuare il lavoro accademico, ma sapevo che non ne sarei stata capace se non mi impegnavo politicamente. La lotta era la forza vitale, la nostra sola speranza di sopravvivere»[1], ebbe a scrivere Angela Davis di ciò che viveva nel 1967 quando da Francoforte tornò negli Usa, a san Diego, in California.
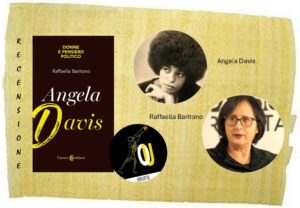
Angela Davis, nata nel 1944, in Alabama, nel cuore del Sud della segregazione razziale è la protagonista di questo breve saggio compreso nella serie dedicata a Donne e Pensiero Politico dalla Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini di Torino e pubblicato dalla Carocci. È un progetto che vuole valorizzare il contributo delle donne nella storia del pensiero politico.
L’autrice di questo volume: Raffaella Baritono, insegna Storia e politica degli Stati Uniti all’Alma Mater Studiorum– Università di Bologna, ed è membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna nonché autrice di pubblicazioni relative alla storia politica e intellettuale americana e del femminismo.
Per quelli della mia età, che hanno vissuto il periodo della contestazione studentesca degli anni ’70, Angela Davis è stata quasi un mito, una di quelle icone che avevano assunto un carattere simbolico della rivolta antirazzista di quegli anni. Spesso, nelle camere di noi adolescenti, faceva mostra il poster di Angela Davis, casomai a fianco di quello di Che Guevara. Che poi, in realtà, di Davis sapevamo ben poco, come dice Francesco De Gregori nella sua canzone del 1974: Informazioni di Vincent.
Anche nel caso di Angela Davis, come in tutte le donne storicamente impegnate in ambito politico–culturale riprese in questa collana, si evidenzia lo stretto legame esistente tra vita e opere. In Davis ciò si riscontra ancora di più, essendo lei stata, in primis, una militante e una dirigente di movimenti che si battevano per la causa dei neri e degli oppressi in generale. Angela Davis si può ritenere oggi una delle più influenti intellettuali americane viventi nell’ambito del femminismo afro-americano.
La questione fondamentale sulla quale, ancora giovanissima, Angela Davis inizia a scontrasi, deriva dalla presa di coscienza della duplice discriminazione a cui i neri erano sottoposti negli Stati Uniti, negli anni ‘50/60: da un lato quella di classe e dall’altro quella della razza. Successivamente la sua formazione politica fu molto influenzata dall’incontro che ebbe alla Brandeis University, nel Massachusetts, con Herbert Marcuse, di cui divenne allieva. Raffaella Baritono ci ricorda che Marcuse la definì come la migliore fra gli studenti che aveva avuto nei suoi trent’anni d’insegnamento.
Sempre a Brandeis, Angela Davis poté ascoltare lo scrittore afroamericano James Baldwin e Malcom X, leader del Black Power, il movimento che, come scrive Raffaella Baritono: «denunciava il modo in cui si erano prodotti quei meccanismi attraverso cui gli afroamericani avevano interiorizzato l’inferiorità razziale, fondati sulla legittimazione sociale della supremazia bianca»[2].
Si può dire che sia già da questa sua prima fase di formazione politica che in Davis prende piede il concetto di intersezionalità, ovvero la connessione tra razza, genere, classe, minoranze etniche e povertà.
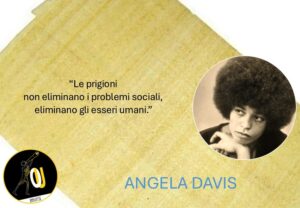
Baritono prosegue la narrazione inquadrando gli eventi principali della vita di Davis che hanno visto crescere il suo impegno politico e la sua riflessione sui temi dello sfruttamento di classe, del femminismo nero, dell’intersezionalità, dell’incarceramento di massa e dei diritti delle minoranze. Quindi il periodo universitario, l’attivismo, le incarcerazioni, e il ruolo di Angela Davis nella lotta per i diritti civili.
Baritono porta alla luce anche il contrasto che Davis ebbe all’interno dei movimenti antirazzisti denunciando la presenza di sessismo e machismo anche in quell’ambito.
L’autrice intreccia sempre gli eventi di vita personali con le riflessioni politiche, mostrando come l’esperienza concreta abbia influenzato il pensiero di Angela Davis (e viceversa).
Questo aiuta a capire che quella di Davis non è “solo teoria” ma il portato di situazioni reali, come l’esperienza del carcere. Davis denuncia come negli Stati Uniti il sistema carcerario diventi una forma di controllo sociale rivolto soprattutto ai neri e alle altre minoranze etniche.
In un’epoca in cui molte discussioni su femminismo, giustizia razziale, disuguaglianza, e diritti delle minoranze sono al centro del dibattito pubblico, un volume come questo offre strumenti per comprendere, oltre la figura di Angela Davis, le radici storiche e teoriche di siffatte questioni.
Written by Algo Ferrari
Note
[1] Davis, An Autobiografhy, Random House, 1974, p.161
[2] Barisone, Angela Davis, Carocci, 2024, p. 20


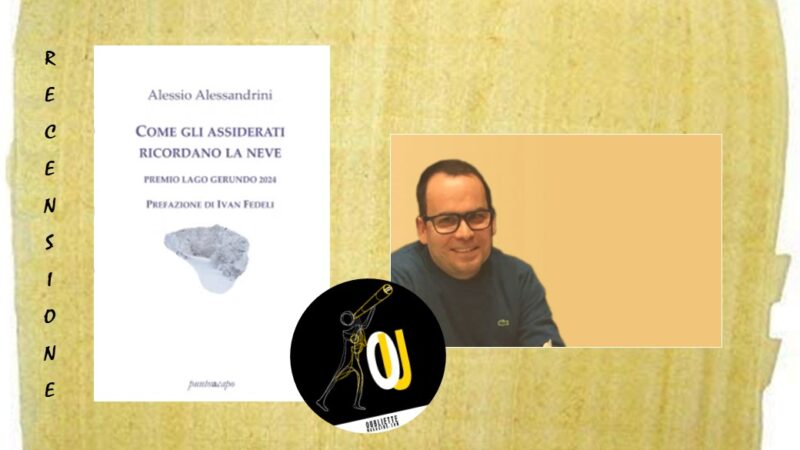
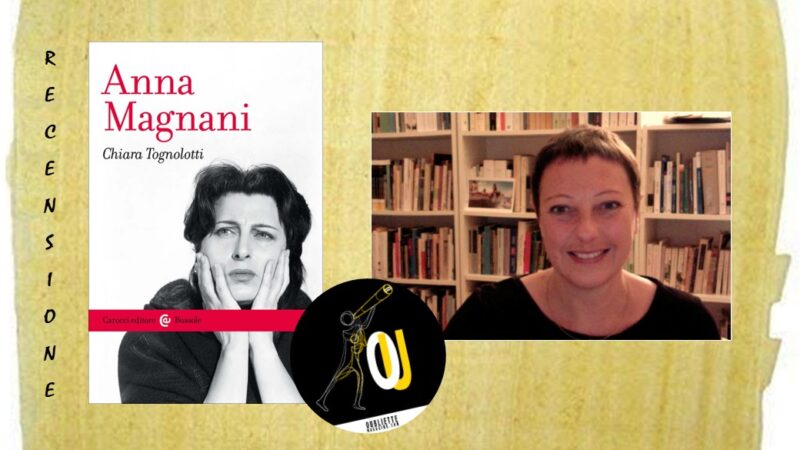
Lessi, anni fa, la sua autobiografia