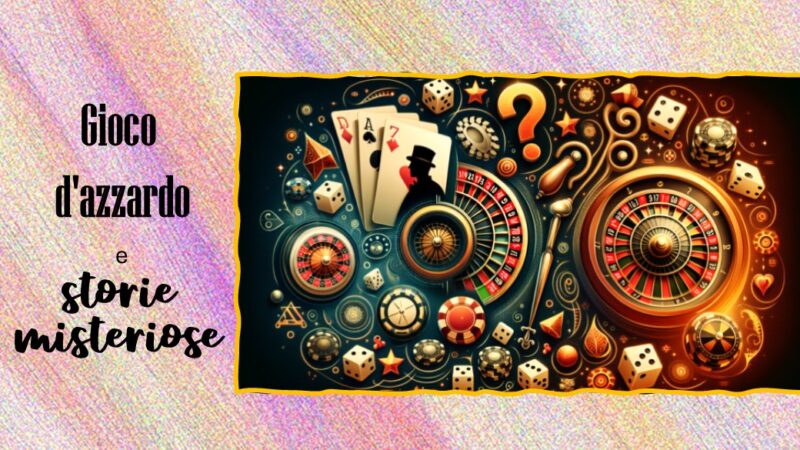L’Acqua Tofana: storia del veleno trasparente ed inodore
Dietro i vicoli assolati di una Roma ancora segnata dal morbo, sotto i tetti bruciati dal sole e il suono delle campane che ricordano i morti, si prepara una nuova epidemia. Ma non è più fatta di bubboni e febbre: è un contagio morale, invisibile, che corre di bocca in bocca e di casa in casa.
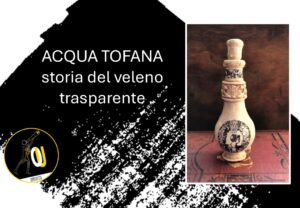
È il gennaio del 1659, e Roma sta per scoprire il volto di un nuovo terrore: quello dell’“acqua tofana”, un veleno trasparente e inodore che, secondo le cronache, avrebbe permesso a decine di mogli di liberarsi dei propri mariti.
A pochi anni dalla peste che aveva decimato la popolazione, la città è ancora immersa nel lutto, nella paura e nella superstizione. La morte, appena allontanata, torna improvvisamente sotto altra forma, insinuandosi nelle case e nei rapporti più intimi. È la peste dei sentimenti, dei sospetti, delle donne.
L’acqua tofana era un liquido tanto innocente all’apparenza quanto micidiale nella sostanza. Bastavano poche gocce nel vino o nel brodo per provocare, dopo qualche giorno, una lenta agonia: febbre, vomito, dolori di stomaco. Nulla che un medico del tempo potesse distinguere da una malattia comune. Solo il succo di limone, dicevano, poteva salvarne le vittime.
Secondo le indagini del Tribunale del Governatore di Roma, dietro questa miscela si nascondeva una rete di donne che da almeno cinque anni produceva e vendeva il veleno.
Alla fine del processo, cinque di loro vennero condannate a morte e impiccate in Campo de’ Fiori: Girolama Spana, Giovanna De Grandis, Maria Spinola, Graziosa Farina e Laura Crispolti. Una sesta, Cecilia Verzellini, fu catturata a Napoli e giustiziata l’anno seguente.
La mente del gruppo era Girolama Spana, detta “l’indovina”. Siciliana di nascita, esperta di filtri d’amore, profumi e rimedi popolari, era conosciuta nei quartieri romani come una donna capace di guarire e predire. Si diceva che avesse appreso l’arte del veleno da una misteriosa Giulia Tofana, figlia di una certa Teofania d’Adamo, già condannata a Palermo decenni prima per crimini simili. Da quella genealogia di donne sarebbe nato il nome dell’“acqua tofana”.
Ma la storia, come sempre, è meno lineare del mito. Le ricerche storiche moderne dimostrano che molti di questi collegamenti sono frutto di leggende ottocentesche: Giulia Tofana era morta molto prima dei fatti di Roma, e il suo ruolo nella vicenda fu probabilmente esagerato. Resta però l’immagine affascinante e inquietante di una tradizione tutta femminile legata al sapere dei veleni.
Ciò che sorprende, nelle carte del processo, è la totale centralità delle donne. Non solo le imputate, ma anche le testimoni, le confidenti, le clienti. Roma del Seicento appare come un mosaico di voci femminili: mogli, vedove, serve, artigiane, levatrici, venditrici ambulanti. Donne che si incontrano nei mercati, nelle chiese, nelle cucine; che scambiano confidenze, consigli, paure.
Il linguaggio delle deposizioni è rivelatore: “come si suol fare tra noi altre donne”, dice una testimone, e in quella frase c’è tutto un mondo. È un universo domestico, intimo, brulicante di relazioni e di segreti. È all’interno di queste reti che l’“acquetta” si diffonde: venduta come rimedio o “soluzione” per mariti violenti, oppressivi, infedeli.
Dietro ogni bottiglietta di veleno, c’è una storia di dolore. Le testimonianze parlano di mariti che picchiano, che rinchiudono, che tradiscono, che tolgono il denaro o la libertà. In un contesto dove la separazione è quasi impossibile e la legge appartiene solo agli uomini, il veleno diventa, per alcune, l’unico modo per riappropriarsi del proprio destino. Non un gesto di follia, ma di disperazione.
Ovviamente la giustizia non poteva comprenderlo. Il tribunale vide solo il delitto, non la sua origine sociale. E così, quelle donne divennero il simbolo del male, la prova che l’ordine andava ristabilito con la forza.
La celebrità dell’acqua tofana trova terreno fertile durante l’epidemia del 1656, quando Roma vive uno sconvolgimento totale dell’ordine sociale. Le autorità avevano imposto quarantene, chiuso chiese, sospeso riti, limitato la libertà di movimento. La morte aveva colpito in ogni casa, in ogni strada. La peste aveva abituato la popolazione a convivere con la morte e con l’invisibile; e i sintomi dell’acqua tofana, febbre, vomito, dolore, erano gli stessi del morbo.
Molti cominciarono a pensare che alcune delle morti attribuite alla peste non fossero naturali. L’abate Ruggero Caetani arrivò a scrivere che migliaia di persone, durante l’epidemia, erano state uccise non dal contagio ma dal veleno. Nasce così un mito potente: quello di una città divorata da due pesti, una biologica e una morale. La prima colpiva i corpi, la seconda le coscienze. E come tutte le paure collettive, anche questa cercava un capro espiatorio. Per cui le donne divennero il volto visibile del male invisibile. Le avvelenatrici incarnavano il disordine, la trasgressione, la ribellione alle leggi della famiglia e della Chiesa.
Il processo del 1659 fu un evento pubblico e spettacolare. Ma, curiosamente, non fu mai trattato come un caso di stregoneria. Le imputate vennero giudicate non dal Sant’Uffizio, bensì dal tribunale laico del Governatore di Roma. Era un delitto “razionale”, non demoniaco. La Chiesa, che durante la peste aveva cercato di mantenere la calma e di evitare accuse diaboliche, preferì interpretare la vicenda come un crimine umano, non come un’opera del demonio. Ciò non impedì, però, che la narrazione popolare prendesse altre strade.
Gli scrittori dell’epoca descrissero le donne come “mostri”, “sirene velenose”, “strumenti del male”. Il gesuita Sforza Pallavicino parlò del “sordo macello dei mariti”, e l’espressione divenne celebre. Altri parlarono di “acqua del benvolere”, perché, secondo la leggenda, le vittime morivano senza rancore verso le mogli. Dietro queste parole si cela un’operazione culturale precisa: ridurre le donne al ruolo di tentatrici, di creature pericolose e ambigue, in contrasto con l’immagine ideale della moglie obbediente e silenziosa. L’“acqua tofana” divenne così un simbolo della paura maschile verso il potere femminile.
Dopo le esecuzioni, Roma reagì cercando di ristabilire il controllo. Le autorità papali rafforzarono la regolamentazione degli speziali e dei farmacisti, gli unici autorizzati a maneggiare sostanze velenose. Si imposero nuove norme per gli esami autoptici e le indagini sui decessi sospetti. In questo senso, il caso segnò una svolta nella storia della medicina legale e della giustizia criminale. Ma l’effetto più duraturo fu simbolico. L’acqua tofana cristallizzò l’immagine della donna come potenziale minaccia, come figura duplice, capace di dare la vita e di toglierla. Nei secoli successivi, il mito rimbalzò nelle cronache e nella letteratura: venne citata nei romanzi, nei libretti d’opera, persino nelle biografie di Mozart, che secondo una leggenda infondata temeva di essere avvelenato con essa. Nel tempo, la storia reale si dissolse, lasciando spazio alla leggenda nera. Ma quella leggenda continuò a parlare di un tema universale: la paura della libertà femminile.
Dietro la condanna morale e la spettacolarizzazione, si intravedono dinamiche profonde: economiche, sociali, affettive. Le donne coinvolte non erano criminali professioniste, ma figure marginali, spesso povere, vedove, analfabete. In un mondo che non concedeva loro potere né voce, il veleno divenne l’unica arma possibile. Ecco perché la storia dell’acqua tofana non è soltanto un fatto di cronaca, ma una metafora potente. Racconta di una città che tenta di guarire da una peste, e finisce per inventarsene un’altra. Racconta di donne che cercano di sopravvivere in un sistema che le condanna per il solo fatto di voler vivere diversamente. Roma, all’indomani della peste, cercava ordine. Ma per ritrovarlo, dovette sacrificare chi quell’ordine lo aveva infranto. E così, tra le mura di Campo de’ Fiori, non vennero giustiziate solo cinque donne, ma un’intera idea di libertà.
Oggi, a distanza di secoli, la vicenda dell’acqua tofana continua a parlarci. È la storia di un veleno, sì, ma anche di una voce collettiva che cercava di emergere. Quelle donne non avevano strumenti politici né diritti civili; eppure, attraverso il loro gesto estremo, denunciarono un’intera struttura di oppressione.
L’acqua tofana non fu solo un liquido mortale: fu l’acqua della trasgressione, della ribellione, del desiderio di autonomia. In un mondo che imponeva il silenzio, divenne parola. Perché in fondo quella miscela velenosa nascondeva un basilare impulso universale: la voglia di libertà. Solo che, in una Roma del Seicento ancora schiava del suo ordine patriarcale, la libertà delle donne poteva avere un solo nome: veleno.
Written by Ilenia Sicignano