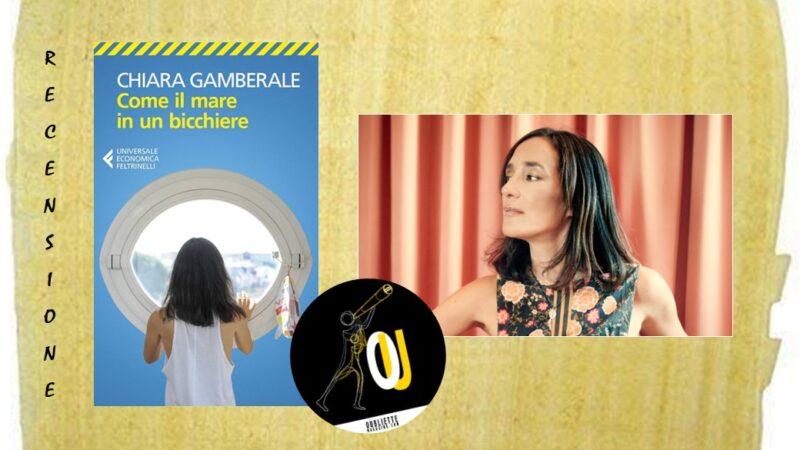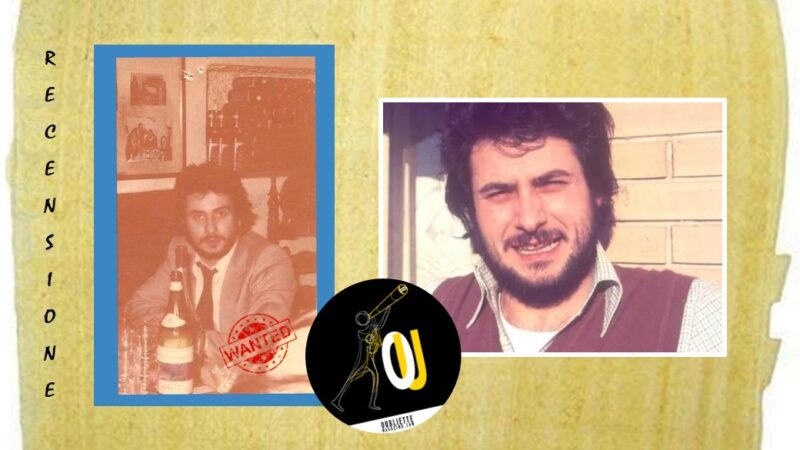“Propaganda” di Denis McQuail: il ruolo centrale nella comunicazione di massa
La propaganda, da sempre, è una forma comunicativa tra le più importanti e non solo in campo politico, ovviamente. In particolare, di questi tempi, che vedono il ritorno della guerra anche in ambiti geografici a noi molto vicini, la propaganda è tornata ad assumere un ruolo centrale nella comunicazione di massa e nelle strategie militari. Il suo scopo, ovviamente, è principalmente quello di manipolare e indirizzare l’opinione pubblica.
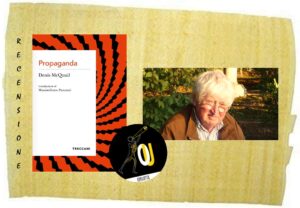
Ben venga, pertanto, quest’iniziativa editoriale della Treccani, che, a partire dal suo enorme patrimonio enciclopedico, promuove la pubblicazione di agili volumi che recuperando alcune parole chiave interpretate a suo tempo da eminenti studiosi, vengono oggi attualizzate nonché sottoposte a riflessione critica.
Il libro si apre quindi con il saggio La manipolazione della sfera pubblica secondo Denis McQuail affidato al sociologo Massimiliano Panarari, professore dell’Università di Modena – Reggio Emilia ed editorialista di alcuni quotidiani e riviste. Denis McQuail (1935 – 2017) è invece il sociologo britannico a cui la Treccani affidò nel 1997 il commento del termine propaganda. Egli è stato indubbiamente uno degli studiosi più preparati e seguiti nel campo dell’informazione e della cosiddetta comunicazione di massa.
Al saggio di Panarari segue il testo originario di McQuail, pubblicato nella Enciclopedia delle scienze sociali alla voce, per l’appunto, di propaganda.
Panarari, con questo suo saggio, illumina e attualizza il pensiero di McQuail riguardo ad un fenomeno complesso e denso di ambiguità come quello della propaganda, entrato negli ultimi anni anche a far parte a tutti gli effetti di un insorgente e diffuso registro comunicativo neopopulistico.
Il professore reggiano inizia il suo contributo riassumendo i passaggi principali del curriculum accademico di McQuail e della sua produzione bibliografica, riportando anche il tipo di scelte e di approcci teorici via via adottati dal sociologo britannico. Ad esempio, per quanto riguarda l’approccio metodologico, spiega Panarari, McQuail non si può ritenere né conservatore né progressista. Infatti, nel corso della sua attività scientifica il sociologo britannico ha costantemente mantenuto un atteggiamento critico e uno spiccato orientamento verso la ricerca empirica, considerata presupposto indispensabile delle costruzioni teoriche.
In tutta l’opera di McQuail l’analisi delle comunicazioni viene intesa nella sua estensione e dimensione di massa, nonché come processo eminentemente sociale.
Dalla prospettiva enunciata mi pare importante ricordare ciò che scrive McQuail, per cui di fronte al dilagare degli effetti della rivoluzione digitale, «l’espressione “comunicazione di massa” può sembrare demodé, legata a suggestioni “moderniste” ma la realtà alla quale si riferisce è perlopiù la stessa, solo più complessa e pervasiva».[1]
Panarari passa poi ad analizzare le varie strategie e gli apparati propagandistici adottati in Europa, sia nel corso che tra le due guerre, nonché l’evoluzione delle principali teorie relative alla propaganda ad opera di vari studiosi, come Walter Lippmann, Edward Bernays e Frederick E. Lumley.
Un altro ambito in cui si sviluppa l’analisi di Panarari è la propaganda derivata dalle varie influenze culturali riconducibili alle correnti filosofiche del positivismo e dell’evoluzionismo, per poi arrivare all’uso massiccio che ne viene fatto nei sistemi totalitari del XX secolo, a partire, nel caso italiano, dal fascismo.
In quest’ultimo uso, la propaganda emerge sempre come comunicazione ingannevole, da notizie date in modo selettivo e distorto a vere e proprie menzogne, come diremmo oggi: fake.
La propaganda, già dalle sue origini, diviene consustanziale all’ideologia, in un contesto di competizione e conflitto per l’egemonia, non solo culturale. Partendo da qui Panarari, riprendendo McQuail, esamina la comunicazione aziendale quale componente dello spazio e del discorso pubblico.
In tempi di postverità o non verità i fili che collegano propaganda, marketing e disinformazione diventano sempre più spessi, mettendo addirittura in crisi il concetto stesso di democrazia.
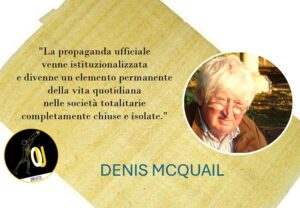
Panarari riflette ancora sul fatto che, oggi, in tempi di guerra vera, questa la si combatte anche nel campo dell’informazione, attraverso le armi della disinformazione e della contropropaganda, grazie altresì alle nuove tecnologie digitali e alla AI, con modalità e dimensioni un tempo inimmaginabili, non a caso si parla di guerra ibrida.
Da pagina 80 del volume inizia il commento originario della voce propaganda sviluppata a suo tempo da Denis McQuail. Nell’introduzione l’autore ci spiega come etimologicamente il termine significa “coltivare”, “seminare” o anche “diffondere”. Prosegue poi ricordando che fu Ferdinand Tönnies, in Kritik der öffentlicker Meinung[2] (1922), uno dei primi sociologi a definire la propaganda come il tentativo di diffondere idee senza alcuna considerazione per la verità o l’accuratezza.
Per quanto riguarda una definizione vera e propria del termine, McQuail ci dice che nell’ambito delle scienze sociali vi sono stati tanti tentativi, ma mai del tutto esaustivi. Quella che lui ci propone è la definizione proposta da Jowett e O’ Donnel nel 1986, sufficientemente ampia e inclusiva, secondo la quale: «propaganda è il tentativo deliberato e sistematico di plasmare percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere una risposta che favorisca gli intenti del propagandista».
Il discorso viene poi ulteriormente sviluppato e articolato da McQuail del quale vorrei però sottolineare una notazione, che ritengo assai importante, per cui la propaganda viene richiamata come comunicazione distorta in contrapposizione al discorso ideale o razionale.[3]
Il saggio di McQuail prosegue andando a ricordare le origini e l’evoluzione della propaganda, in particolare nelle società totalitarie, scrivendo a questo proposito:
«La propaganda ufficiale venne istituzionalizzata e divenne un elemento permanente della vita quotidiana nelle società totalitarie completamente chiuse e isolate. L’educazione, la politica, i mezzi di comunicazione, gli spettacoli e lo sport erano organizzati in modo tale da promuovere il messaggio ideologico e fornire sostegno al potere del partito dominante. L’attività propagandistica, tuttavia, era condotta in modo razionale e si basava sui principi scientifici e su una solida informazione. Essa si serviva inoltre del contributo di artisti e grafici di eccezionale levatura – si pensi all’arte grafica sovietica e ai film di Leni Riefenstahl, Eisenstein, Dovženko e Pudovkin. Nella propaganda di Hitler e di Stalin il concetto di “verità” perse in larga misura ogni significato, se non quello “oggettivamente” definito dal partito».
McQuail mette poi l’accento sull’importanza dell’affermazione della radio come mezzo di comunicazione e di propaganda sia a livello nazionale che internazionale, già a partire dagli anni ’30 e successivamente sulla sempre maggiore rilevanza dei mass media, in generale, a livello propagandistico.
È evidente come anche la ricerca abbia assunto nel tempo un ruolo sempre più indispensabile. L’autore fa riferimento alla ricerca di tipo sperimentale sviluppata dagli anni ’30 in poi, tesa a verificare, ad esempio, l’efficacia dei film e delle immagini nel rafforzare la motivazione nei soldati a combattere. Altre scuole di ricerca hanno invece concentrato l’attenzione sull’analisi del linguaggio e sulla psicologia sociale.

McQuail non usa mezzi termini per denunciare come i governi si servano del potere che hanno per fornire ai media notizie “convenienti” e molto selettive, a volte attuando una vera e propria disinformazione. Il sociologo britannico conclude il suo commento andando a rilevare gli effetti della propaganda e le forme della propaganda moderna.
Al termine della lettura di questo volume, composto da due saggi, il lettore potrà dire di avere raggiunto un livello di conoscenza del fenomeno propaganda assai approfondito ed esteso, in modo da poter riconoscere facilmente le innumerevoli pratiche di informazione strumentale e di persuasione a cui, soprattutto in tempi di guerra come questi, siamo sottoposti.
“Propaganda” sarà presentato martedì 28 ottobre 2025, alle ore 17,30, presso la Biblioteca “Rosta Nuova” di Reggio Emilia. Sarà presente il prof. Massimiliano Panarari autore del saggio introduttivo al volume, in dialogo con Algo Ferrari (sociologo). Introduce Simona Silvestri, presidente di iniziativa laica di Reggio Emilia.
Written by Algo Ferrari
Note
[1] D. McQuail, Prefazione alla quarta edizione, in Sociologia dei media, Il Mulino, Bologna, 2000.
[2] “Critica dell’Opinione pubblica”.
[3] A. Gouldner A., The dialectic of Ideology and Technology, Londra, 1976.