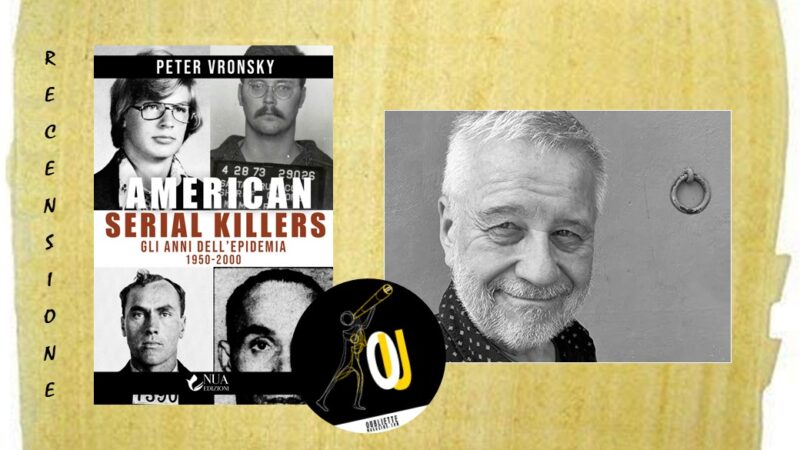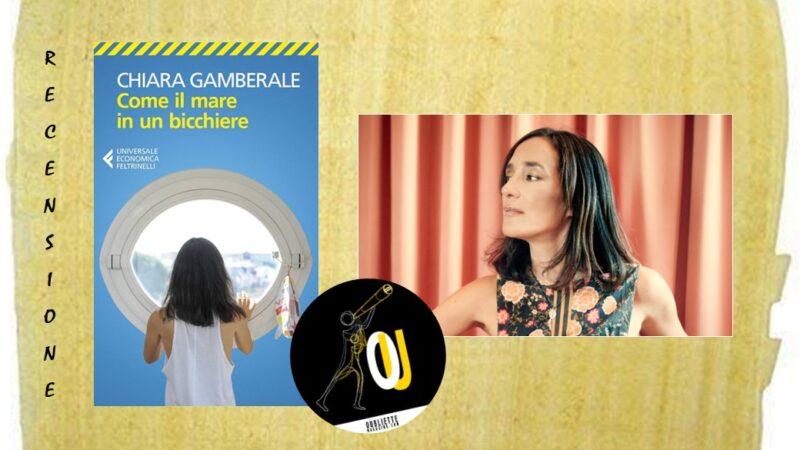“Diritti umani. Realtà e utopia” curato da Isabella Adinolfi: perché tale divario?
Diritti umani. Realtà e utopia (Città Nuova, 2004) era uno dei miei tanti volumi in attesa di essere letto. Finalmente mi sono deciso a leggerlo. Periodo peggiore non poteva esistere, visto ciò che sta accadendo a Gaza e in Ucraina. Tanto che avrei scritto un sottotitolo diverso, il seguente: realtà o utopia? Propendendo nella risposta per la seconda opzione.
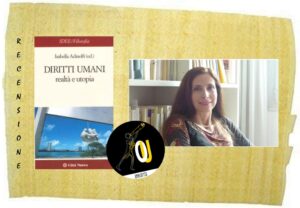
La situazione internazionale contemporanea rende di fatto i diritti umani e il diritto internazionale concetti quasi obsoleti. I confini e i trattati hanno perso gran parte del loro significato, non hanno più alcuna rilevanza. E anche gli uomini in quanto tali non possono più far valere alcun diritto.
Isabella Adinolfi, docente presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Ca’Foscari di Venezia e curatrice del presente volume, alla domanda basilare che lei stessa pone, ovvero, se i diritti umani, affermatisi storicamente con la Dichiarazione universale del 1948, siano soltanto un’astrazione ideale o operino concretamente nella vita quotidiana, risponde nel seguente modo: «i diritti umani sono dunque per un verso realtà, per l’altro verso utopia; sono insieme l’uno e l’altro, nel senso che rappresentano nella loro forma più concreta, una legislazione che non ha trovato e non trova tuttora piena e soddisfacente applicazione».
Tutto ciò nonostante anche Isabella Adinolfi condivida quanto Simone Weil faceva osservare a suo tempo: «Un diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto»[1].
Il libro Diritti umani. Realtà e utopia, complessivamente, appare come un invito a mettere in discussione le nostre certezze: i diritti umani sono ambasciatori di speranza o miraggi morali? E, soprattutto, cosa possiamo fare per renderli tangibili nel nostro vissuto quotidiano?
Il volume si presenta come una raccolta di brevi saggi in cui Isabella Adinolfi, oltre che curatrice, è anche l’autrice del saggio di apertura nel quale affronta anche la questione del fondamento dei diritti umani. A tale scopo richiama, in particolar modo, il lavoro di ricerca che Norberto Bobbio sviluppò per tanti anni su questo tema, raccogliendolo nel volume, pubblicato da Einaudi: L’età dei diritti. Bobbio, sostanzialmente, nega l’esistenza di un fondamento oggettivo, assoluto, dei diritti dell’uomo.
Anche l’autrice riflettendo sullo scarto esistente tra teoria e prassi e interrogandosi se i diritti umani possano essere considerati una realtà consolidata o piuttosto un’utopia da perseguire, pare assumere la posizione di Norberto Bobbio e di diversi altri studiosi della morale. In particolare quando questi studiosi pongono alla base della teoria dei diritti umani lo scarto esistente tra ideale e reale, tra aspirazioni e attuazioni e tra dover essere ed essere. L’autrice sottolinea, tuttavia, la necessità non solo di comprendere il perché di tale divario, ma anche i modi per ridurlo sempre più.
Un vantaggio di un libro collettaneo, come quello in argomento, è che può garantire un approccio interdisciplinare, capace di coinvolgere chi legge da più punti di vista, come in questo caso.
La raccolta di saggi, infatti, prosegue con i contributi di stimati studiosi come, nell’ordine: Francesco Casavola, Mario Tronti, Vittorio Possenti, Enzo Pace e Pier Cesare Bori, ognuno dei quali esplora il tema da una prospettiva diversa: giuridica, politica, sociologica, storico-religiosa e filosofica.
Francesco Paolo Casavola fa giustamente notare come sia sbagliato voler disegnare una linea continua tra la Dichiarazione francese del 1879 e quella universale del 1948, come fanno in molti, addirittura facendola partire dal Bill of Rights di Inghilterra e America. Il carattere rivoluzionario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 sta nel fatto di non rinviare ad alcuna filosofia del fondamento dei diritti dell’uomo e nel rivendicare, anche se ad oggi in modo assolutamente utopistico, una tutela di questi diritti al di sopra e anche contro gli stati.
Casavola pare consapevole del carattere utopico della Dichiarazione del 1948, ma considera l’utopia come il fattore più importante che può fare muovere la storia. Anche se ad oggi, vent’anni dopo di quando lui scriveva questo, non si direbbe. Anche l’auspicio che l’Europa potesse essere per il mondo un laboratorio sperimentale di straordinaria esemplarità, sapendo realizzare l’auspicio di Kant per cui il diritto, e non la sovranità dello Stato, sarà infine il potere supremo, pare sempre più un obiettivo lontano.
Mario Tronti affronta la tematica in modo critico, politico, leggendo la teoria dei diritti umani universali non tanto come utopia, ma come ideologia, in senso marxiano, quindi come falsificazione della realtà.
Scrive Tronti, citando Emanuele Castrucci: «chi è chiamato materialmente a officiare i riti della religione dei diritti dell’uomo finisce poi in realtà per decidere sulla concreta allocazione del potere, in forma di “diritti”, nei diversi ambiti spaziali in cui l’universale necessariamente si articola» [Filosofia Politica, 1/2001]
Per Tronti, in estrema sintesi, occorre pensare ai diritti umani come forma di rivendicazione e di lotta. Mai esaurita. Una posizione che mi sento di difendere. Tronti si pone quindi in modo critico contro la retorica dei diritti umani semplicemente evocati, senza conseguenze pratiche di trasformazione delle cose: un esercizio in cui si distinguono la Chiesa cattolica e una certa sinistra politica.
Vittorio Possenti si interroga sul presente e sull’avvenire dei diritti dell’uomo. Per il filosofo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è rivolta al futuro; attende una realizzazione proiettata in un domani che presumibilmente varierà secondo le aree geopolitiche. Possenti ritiene che i diritti umani siano in una fase di crescente giuridicizzazione e positivizzazione, soprattutto in Occidente, in quanto paiono scaturiti al crocevia tra tradizione ebraico-cristiana e illuminismo.[2] Per il professore la rivoluzione dei diritti umani appare proiettata nel futuro, dopo la catastrofe delle rivoluzioni totalitarie del XX secolo.
Enzo Pace incentra il suo saggio sulla questione dei diritti umani nell’Islam. Pace si dimostra abbastanza fiducioso sullo sforzo che gran parte dei Paesi musulmani sta facendo per adeguarsi al linguaggio dei diritti umani. Anche se l’attuale crisi palestino-israeliana sembra giunta ormai a un punto limite, dove non esiste più alcun diritto umano e dove la violenza ha la meglio su qualsiasi altra dimensione.
Conclude il volume il contributo di Pier Cesare Bori, storico delle religioni, con il suo invito ad un cambiamento individuale a partire da una maggior conoscenza di se stessi, attraverso tecniche e pratiche di meditazione. Questa, per Pier Cesare Bori, la via migliore per trasformare l’utopia dei diritti umani in qualcosa di più concreto e praticabile.
In conclusione, si può dire che il volume di Isabella Adinolfi riesce a mantenere un equilibrio tra rigore accademico e chiarezza del testo, rivelandosi accessibile a tutti gli interessati al tema dei diritti umani. Un libro che si caratterizza come un testo intellettualmente stimolante, capace di sollevare questioni fondamentali. I diritti umani sono finiti o infiniti? Sono praticabili o eternamente utopici? Il volume invita a una riflessione, interrogando il nostro vivere comune e le mancanze etiche del potere. Sebbene risalente al 2004, il volume conserva molti elementi di interesse e può essere occasione di aggiornamento sia per studiosi che per chiunque si interroghi sul rapporto tra etica e politica.
Written by Algo Ferrari
Note
[1] S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, Ed. di Comunità, Milano, 1973, p.9
[2] Ricordo ancora che il testo è stato scritto nel 2004. Non so se oggi il prof. Possenti si esprimerebbe nello stesso modo.