“La mite” di Fëdor Dostoevskij: l’impossibilità di essere pienamente umani
Uno dei più grandi doni della scrittura di Fëdor Dostoevskij è la percezione tangibile e prorompente della debolezza umana. Questa particolarità si ritrova in tutte le sue opere, da Delitto e castigo a I Fratelli Karamazov.
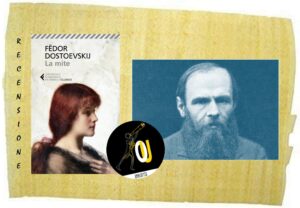
Ma è particolarmente viva all’interno del racconto lungo, pubblicato anche come romanzo, La mite, elaborato nel 1876 e inserito nella raccolta Diario di uno scrittore.
All’epoca della stesura del romanzo, ossia durante l’autunno del 1876, Dostoevskij fu colpito dalle numerose notizie di suicidio che avvenivano continuamente a Pietroburgo. Forse sulla scia tardiva dell’“effetto Werther”, molti giovani uomini e donne si toglievano la vita lanciandosi dalle finestre o sparandosi; tra queste notizie, lo colpì in modo particolare un titolo di giornale che parlava della morte di una ragazza e definiva il suicidio “mite”.
Dostoevskij, dopo aver letto l’articolo, si interrogò sulle motivazioni ‒ rimaste segrete ‒ che avevano spinto la giovane a un simile gesto. Da quella riflessione nacque l’ispirazione per il racconto, che non assume però il punto di vista della vittima, bensì si configura come una lunga confessione del suo carnefice: il marito, causa primaria della drastica decisione della moglie, soprannominata “la mite”.
La particolarità dell’opera, quindi, sta nel modo di raccontare l’accaduto. Non una fredda cronaca o romanzata narrazione dei fatti, bensì una confessione, una specie di lettera, simile a quella di Alexis di Marguerite Yourcenar. Ma se in quest’ultima il narratore svela la sua latente omosessualità in modo responsabile, fragile ma lucido, in questo racconto il protagonista spiega i fatti con estrema riluttanza, quasi a voler scagionare se stesso con la sua verità.
Ed è proprio questa la potenza del romanzo: un varco sulla debolezza umana, che mente, copre, svela, si mette in dubbio, poi ritorna sui suoi passi e solo alla fine espia le proprie colpe, ma sempre in modo estremamente narcisistico. Forse la confessione del protagonista potrebbe essere paragonata a quella di Zeno di Italo Svevo, in cui la verità non viene mai fuori del tutto, o almeno non è attendibile né oggettiva.
Del narratore non si conoscono molti dettagli: il nome viene omesso e la sua storia riaffiora a chiazze nel lungo racconto sull’incontro, sul matrimonio e sulla morte della sua “amata”. Sembra non essere interessante ai fini della sua narrazione, eppure la colpevolezza sta proprio nel suo passato: una serie di traumi, sociali e professionali, lo hanno spinto a diventare una persona fredda, silenziosa, cinica, bisognosa d’affetto ma incapace di richiederlo.
La mite è stata colpita dagli strani atteggiamenti del marito, che più che amore mostravano rifiuto, riluttanza e indifferenza. Lei cercava baci, lui le voltava le spalle. Lei cercava dialogo, lui la osservava e non le rispondeva, come se non ci fosse nessuno a proferir parola. Questa lunga espiazione ingiustificata ha condotto la donna a sentirsi umiliata, distrutta, invisibile, al punto da non tollerare più la sua esistenza.
Eppure il marito, fino alla fine del romanzo, continua a giustificarsi, a puntare il dito verso di lei, a chiamarla “mite” ma al tempo stesso a considerarla come un animale vigoroso da domare. Il suo obiettivo era quello di educarla col silenzio, salvo poi esplodere, di tanto in tanto, in eccessive dimostrazioni d’amore non richiesto. Questa confusione peggiora la precaria situazione mentale della giovane donna, che a sedici anni desiderava l’ardore e si ritrova invece in un matrimonio più simile a una stanza da tortura psicologica.
Dostoevskij, in questo romanzo, riesce a descrivere con estrema precisione la situazione tragica dei matrimoni privi di legame, concordati per convenienza e trasformati in una prigione da cui è possibile fuggire solo attraverso esiti drammatici. Al contempo, mette in luce l’incapacità umana di dialogare e di instaurare connessioni autentiche capaci di generare atti di comprensione, verso se stessi e verso gli altri.
La mite anticipa così di qualche decennio il tema dell’inettitudine, tanto caro agli scrittori novecenteschi, un motivo che si manifesta anche nel fallimentare tentativo del protagonista di raccontare l’evoluzione e l’epilogo della vita della moglie, ridotta a un semplice espediente narrativo per scaricare tutto il vittimismo di un’esistenza consumata e mai vissuta pienamente.
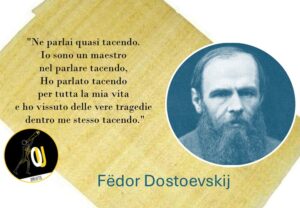
Forse l’obiettivo ultimo dello scrittore è rivelare l’assoluta incapacità dell’essere umano di comprendere pienamente le proprie emozioni e di interpretare il mondo circostante, intrappolato in un oscurantismo emotivo che offusca ogni percezione lucida della realtà. Questa cecità interiore, amplificata dalla paura del giudizio sociale e dal bisogno di conformità, conduce i personaggi a scivolare nella superficialità dei rapporti e nell’incomprensione reciproca.
La mite mostra come l’egoismo e l’autoassoluzione possano mascherare la violenza psicologica più sottile, rendendo il dolore altrui un problema marginale, accessorio rispetto al proprio disagio. Nel finale, la morte della moglie non emerge come evento legato a lei, alla sua vita o alla sua sofferenza, ma come una ferita narcisistica nell’esistenza del marito: egli si concentra esclusivamente sul vuoto lasciato da lei, incapace di empatia, di rimorso autentico o di comprensione.
Dostoevskij mette così a nudo la fragilità morale dell’uomo, la difficoltà di instaurare un contatto vero con se stessi e con gli altri e la tendenza a ridurre l’altro a semplice specchio del proprio mondo interiore. In questo senso, il racconto non è solo una critica ai matrimoni senza affetto o alle dinamiche sociali oppressive, ma un’indagine profonda sull’impossibilità di essere pienamente umani in un contesto che reprime l’autenticità dei sentimenti e la responsabilità emotiva.
Written by Ilenia Sicignano
Bibliografia
Fëdor Dostoevskij, La mite, Feltrinelli, 2013

