DNA: il codice della vita spiegato in modo semplice
“La scienza è fatta di fatti, esperienza e sperimentazione, e il DNA ne è la prova più splendente.” ‒ Rosalind Franklin
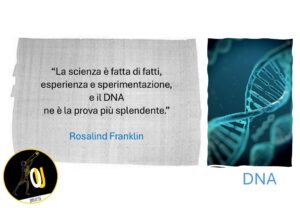
Definito il ‘codice della vita’, il DNA (acido desossiribonucleico) è una molecola incredibilmente complessa e affascinante, la cui scoperta ha rappresentato uno dei più grandi progressi della biologia moderna. E una delle più grandi conquiste scientifiche della storia.
Sono numerosi i campi di ricerca che tale scoperta ha rivoluzionato: dalla biologia molecolare a quella cellulare, dalla medicina all’agricoltura, dall’evoluzione alle biotecnologie fino all’ingegneria genetica. Nonché la disciplina criminologica.
“Siamo macchine da sopravvivenza, robot pilotati a distanza programmati per preservare quelle molecole egoiste note come geni.” ‒ Richard Dawkins, etologo e biologo evoluzionista
Molecola contenente le istruzioni genetiche per lo sviluppo, il funzionamento e la riproduzione di tutti gli organismi viventi e di molti virus, il DNA è custode di una storia antica, che nel silenzio delle cellule si ripete in ogni nuovo organismo. Tanto da essere definito la ‘sentinella’ del codice genetico. Che, come un prodigio guidato da un linguaggio inciso nel tempo, accompagna ogni respiro, ogni battito e ogni pensiero dell’esistenza degli organismi eucarioti (piante, animali e umani).
Contenente le istruzioni necessarie a una cellula per sopravvivere e svolgere le proprie funzioni, la maggior parte dell’acido desossiribonucleico è contenuta nel nucleo della cellula.
Famoso per la sua forma a doppia elica, il DNA è simile a una scala a chiocciola; con i suoi corrimani che sono formati da zuccheri e fosfati, mentre i pioli sono composti da coppie di basi azotate (composto organico) che si accoppiano in modo specifico: A con T e C con G. Dove A rappresenta la adenina associata alla timina, la guanina si accoppia con la citosina, formando così una sequenza genetica composta da due filamenti avvolti l’uno sull’altro.
A sua volta ogni filamento è formato da una sequenza di nucleotidi, unità di base del DNA, che costituisce il codice genetico e determina tutte le caratteristiche di un organismo, dal colore degli occhi alla predisposizione a certe malattie.
Ogni sequenza di nucleotidi comprende anche le istruzioni per costruire proteine, guidare processi biologici e, in ultima analisi, determinare caratteristiche che rendono unico ogni individuo. La famosa doppia elica non è soltanto un simbolo scientifico, ma un prodigio che parte da lontano.
Dal momento in cui, nel 1869, il giovane scienziato svizzero Friedrich Miescher, lavorando nel buio di un laboratorio universitario, dai nuclei delle cellule isolava una sostanza fino ad allora sconosciuta. Che chiamava nucleina, non immaginando certo di avere appena identificato un elemento che avrebbe portato alla più grande scoperta della biologia.
Poi, per decenni la molecola dell’acido desossiribonucleico è rimasta un enigma, mentre il mondo scientifico continuava a discutere se le proteine o gli acidi nucleici fossero gli artefici dell’ereditarietà.
In seguito, nel 1953 per la precisione, grazie ai dati fondamentali ottenuti da Rosalind Franklin, scienziata britannica, con la diffrazione a raggi X e la famosa Foto 51, James Watson e Francis Crick, scienziati di Cambridge, svelavano la struttura del DNA: una doppia elica avvolta su sé stessa che ricorda la struttura di un nastro a spirale.
Così scrivevano Watson e Crick in un articolo apparso all’epoca sulla rivista scientifica Nature: “Non ci è sfuggito che questo specifico appaiamento suggerisce immediatamente un possibile meccanismo di copiatura del materiale genetico…”
Una delle principali funzioni a cui è ‘obbligato’ il DNA è quella di immagazzinare e trasmettere l’informazione genetica. Funzione che contiene tutti i geni, ovvero segmenti specifici di acido desossiribonucleico, ognuno dei quali fornisce le istruzioni per produrre una specifica proteina. Tale processo avviene nelle due fasi di trascrizione e traduzione.
Durante la trascrizione l’informazione contenuta nell’acido desossiribonucleico viene copiata in una molecola di RNA messaggero, ovvero mRNA. Che altro non è se non una molecola che porta le istruzioni per la sintesi delle proteine dal nucleo del Dna ai ribosomi (presenti nel citoplasma). Dove i ribosomi sono piccoli organelli che hanno il compito di leggere l’mRNA e costruire le proteine. Che, durante la traduzione viene tradotto in una sequenza di amminoacidi tali da formare una proteina.
Laddove le proteine non sono altro che elementi essenziali per la struttura e il funzionamento delle cellule, importanti per la replicazione del DNA e sostanze atte a rispondere agli stimoli ambientali.
La replicazione, altra proprietà fondamentale, è dedicato al vincolo del DNA di duplicarsi. Questo processo, chiamato per l’appunto replicazione del DNA, è essenziale per la divisione cellulare. Infatti, prima della divisione cellulare, l’acido desossiribonucleico si duplica con precisione grazie a un complesso meccanismo enzimatico, garantendo che ogni cellula figlia riceva una copia identica del patrimonio genetico. Assicurando che i caratteri ereditari dei genitori siano trasmessi ai figli.
Perché il DNA, non contiene soltanto le istruzioni per lo sviluppo e il funzionamento di ogni essere vivente, ma rappresenta attraverso l’ereditarietà anche il ponte di collegamento tra le generazioni: in definitiva, altro non è se non la trasmissione delle caratteristiche che rendono un individuo simile ai propri genitori.
Occasionalmente, durante la replicazione del DNA o a causa di danni esterni, si possono verificare mutazioni, che intervengono a provocare alterazioni nel materiale genetico. Errori che possono avvenire durante la replicazione, o in qualche caso a causa di danni esterni, provocando mutazioni, talvolta portatrici di malattie genetiche. Fra queste la fibrosi cistica, o la distrofia muscolare.
Le mutazioni sono però anche una spinta nel campo dell’evoluzione, in quanto possono portare alla luce nuove caratteristiche genetiche che, se convenienti, si possono selezionare e trasmettere alle generazioni successive.
“Abbiamo scoperto il segreto della vita!” ‒ James Watson, autore della struttura del DNA
Il DNA ha rivoluzionato vari campi di studio, a cui in passato non si pensava neppure di potere accedere. Soprattutto ha veicolato informazioni importanti svariati ambiti, medicina, biologia cellulare e molecolare fra questi.
Anche la genealogia, e persino l’archeologia, hanno beneficiato della scoperta del DNA, le quali traggono nuove informazioni dalla lettura di sequenze genetiche.
Oggi, infatti, è possibile ricostruire storie di popoli antichi, scoprire legami familiari nascosti e risolvere misteri rimasti sepolti per secoli.
A proposito delle applicazioni biotecnologiche, il sequenziamento del genoma umano (insieme dei geni), ad esempio, ha permesso di mappare tutti i geni presenti nel DNA dell’uomo. Aprendo la strada, attraverso la mappatura del genoma, a studi sulle malattie rare: un passo fondamentale quindi per fare maggior chiarezza e conoscere nuove malattie genetiche e sviluppare terapie mirate per risolvere tali disfunzioni.
Da menzionare è la tecnologia CRISPR, che consente di modificare il DNA in modo preciso e mirato, aprendo possibilità nuove per trattare malattie genetiche, oltre che per la manipolazione genetica. Inoltre, grazie alla mappatura del genoma gli scienziati hanno recentemente scoperto varianti genetiche che influenzano l’invecchiamento e la longevità. Mentre tracce di virus antichi, che hanno lasciato segni permanenti nel DNA dell’uomo, raccontano di infezioni che la storia aveva dimenticato.
“La doppia elica non è solo bella, è talmente bella che non può che essere vera.” ‒ Francis Crick, autore della struttura del DNA
Oggi il DNA non è più un concetto confinato nei laboratori. Rappresenta l’alba di un’era in cui la conoscenza del DNA può spiegare alcune malattie rare, ma soprattutto prevenire, correggere e in alcuni casi, anticipare il destino biologico di una persona.
Nella scienza forense Il DNA ha anche rivoluzionato il campo della criminologia. Grazie alla sua unicità, come già detto, ogni individuo ha un profilo genetico unico, che può essere utilizzato per identificare persone, risolvere crimini o stabilire una paternità sospetta. Infatti, le prove di DNA raccolte sulla scena di un crimine sono uno degli strumenti più potenti nelle indagini forensi.
Infine, a conclusione di un’argomentazione davvero affascinante, sono d’obbligo alcune riflessioni sul DNA e sul destino dell’uomo. Una su tutte è il fatto che l’acido desossiribonucleico è strumento per ricordare all’uomo la sua fragilità e al contempo la sua resilienza: ogni sequenza genetica è un equilibrio tra casualità e ordine, tra mistero e comprensione. Prospettiva da cui si può osservare che la scienza non è solo tecnicismi, ma poesia, scoperta, e consapevolezza che ogni cellula è preposta a tutto ciò che un individuo può diventare. Ricordando all’uomo che ogni cellula è parte di un progetto più grande, scritto nel tempo e nel codice della vita.
“Il DNA è la molecola più famosa della biologia, l’alfabeto a quattro lettere che scrive il codice dell’esistenza di ogni essere vivente.”
La scoperta del DNA porta con sé anche domande etiche profonde.
Chi può aggiudicarsi il diritto di modificarne la struttura?
Come tutelare la privacy genetica in un mondo in cui l’essenza biologica di ciascuno può diventare informazione condivisa?
Così come ogni progresso scientifico si accompagna a nuove responsabilità, il DNA ricorda all’uomo che la scienza non è mai neutra, ma è specchio dell’umanità. Perché in fondo leggere l’acido desossiribonucleico è come leggere la storia di se stessi: un romanzo scritto in un linguaggio che l’uomo sta ancora imparando a decifrare, con capitoli che parlano di origine, malattia, resilienza e futuro.
“Il DNA è spesso definito il ‘libro della vita’, un manuale di istruzioni biologico che ogni cellula possiede e consulta incessantemente.”
Written by Carolina Colombi



