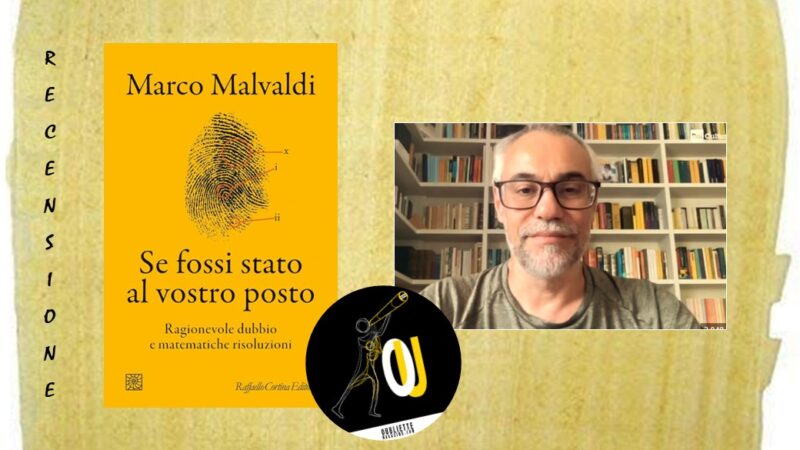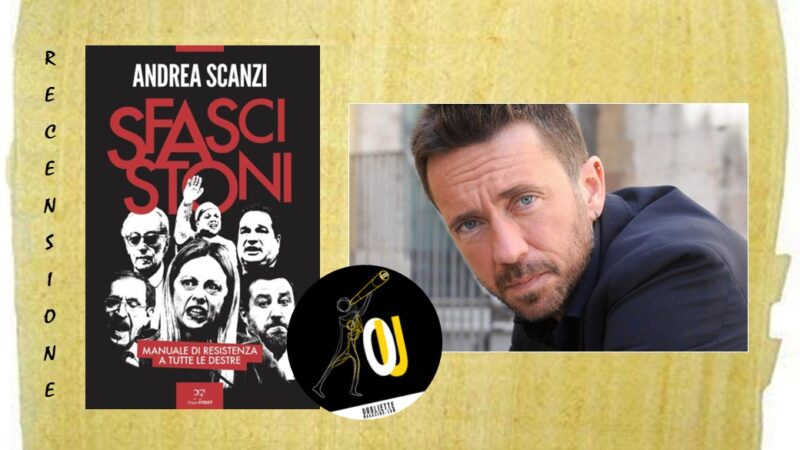“Rime di rabbia” di Bruno Tognolini: cinquanta invettive per le rabbie di tutti i giorni
Che cos’è la rabbia? La rabbia è una delle passioni più grandi che possa attraversare l’uomo. Essa può dominarci del tutto e condurci a gesti estremi. Questo non significa che essa debba essere ignorata e taciuta: anzi, una rabbia a lungo repressa può esplodere da un momento all’altro: invece saperla riconoscere, imparare a gestirla e ad esprimerla nelle giuste modalità può avere un effetto catartico.
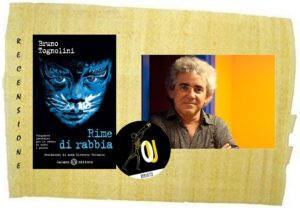
Manifestarla attraverso la poesia è sicuramente la maniera più elegante. Ed è quella percorsa da Bruno Tognolini nella raccolta poetica Rime di rabbia edita per la casa editrice Salani nel 2010.
Bruno Tognolini è un filastrocchiere che scrive rigorosamente in rima. Sarebbe impossibile riassumere qui tutta la sua produzione.
Torniamo al libro “Rime di rabbia”. Se lo sfogo della rabbia mediante la poesia è tra i più nobili, non vanno tuttavia disprezzate altre tipologie che in qualche modo si avvicinano ad essa in quanto condividono di quest’ultima l’elemento della finzione in modo che la rabbia non possa mai materializzarsi davvero fisicamente contro le persone. Una di queste tipologie viene evocata da Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeutica, nella prefazione: la lasciamo ai lettori. Il libro presenta poi delle illustrazioni tanto minimali quanto eleganti di Giulia Orecchia.
Torniamo alle liriche che sono in tutto cinquanta. Ecco la prima, sicuramente programmatica, dal titolo Rima di rabbia.
“Rabbia, rabbia/ Fiato di sabbia/ Sangue di gioco/ Fiore di fuoco/ Fiammeggia al sole/ Consuma tutto/ Lasciami tutto/ Lasciami il cuore/ Pulito e asciutto.”
La rabbia è rivolta innanzitutto verso chi più la mette a dura prova: soprattutto quella dei bambini, la cui voce viene assunta dall’io lirico. Così risulta dalla seconda lirica, Malaugurio del traditore.
“Tu che sei stato sempre vicino/ Sempre al mio fianco, sempre mio amico/ E ora sei a fianco ad un altro bambino/ Stai a sentire ciò che ti dico/Io spero proprio che tu ti ritrovi/ In un bel banco di spine di rovi/ Sempre più stupido, sempre più stanco/ Con un orango compagno di banco/ Con cinquecentoquarantasei denti/ Tutti cariati, tutti ridenti/ Che tutto il giorno ti vuole baciare/ Con una puzza terribile in bocca/ E se mi chiedi se puoi ritornare/ Io ti presento questa filastrocca/ Che ora finisce dicendo così/ Te ne sei andato? Ora stai lì!”
La lirica inizia con un’invettiva a quel “tu” il cui tradimento risulta ancora più evidente dato che compiuto proprio da chi era insospettabile, perché “sempre” vicino come esplicitato dal verso successivo (v. 2) che presenta l’avverbio “sempre” replicato all’inizio di ciascuno dei due emistichi del verso; fortemente avversativo risulta quel “E ora sei” (verso 3). Proprio lui viene apostrofato con una prolessi che serve a rendere più patetico il contenuto successivo: “Stai a sentire ciò che ti dico”. In quest’ultimo verso l’allitterazione della s (Stai a… sentire) rafforza l’attenzione richiesta dall’io lirico da parte del proprio interlocutore, attenzione amplificata dall’“io spero del verso successivo” (v. 4), con prosecuzione della s allitterante e con esposizione esplicita dell’io in forte antitesi con il tu del verso 1.
Questo ritmo binario tra io-tu è in realtà una movenza molto ricorrente in Tognolini: solo apparentemente si tratta di una semplificazione tesa a mimare il ragionamento “infantile” dei più piccoli; Bruno Tognolini è un poeta molto consapevole, molto preparato nella metrica, non solo moderna, ma anche classica, costituita proprio di alternanze, analogamente a quelle dell’io-tu riproposto in questa lirica, come in altre. Dopo il verso 4 segue la serie dei malauguri molto forti, a tratti iperbolici, che l’io lirico lancia al suo traditore, sperando che gli possano capitare i peggiori disastri. Alla fine l’io lirico ribadisce il suo intento programmatico: “E se mi chiedi se puoi ritornare/ Io ti presento questa filastrocca/ Che ora finisce dicendo così/ Te ne sei andato? Ora stai lì”.
Lo stile della maledizione, del resto, è di per se stesso antico e attestato, ad esempio, nelle prime iscrizioni latine non letterarie rinvenute tra i testi. Analogamente anche altre invettive sono molto forti, come la seguente:
“Tu lo sapevi che mi avresti fatto male/ Tu lo sapevi che per questo avrei pianto/ Era la cosa più terribile che mi potevi fare/ Lo sapevi che io ci tenevo tanto/ Però l’hai fatto, fatto tutto, fatto a lungo, fatto apposta./ E adesso scoprirai cosa ti costa/ Io non ti voglio più vedere sotto il sole/ Io non ti voglio più vedere in mezzo al giorno/ Per me tu sei invisibile, sei fumo di parole/ Sei un po’ di vento che mi soffia intorno/ Sei solo una ridicola noiosa malattia/ Vattene via, vattene via, vattene via/ E non mi importa cosa dici, non mi frega cosa fai/ Fino a domani non ti perdonerò mai” (Rima senza perdono).
Risultano forti le anafore (“Tu lo sapevi che…./ Tu lo sapevi” che dei versi 1-2) con l’intento di peggiorare la posizione dell’interlocutore (tu) il quale sapeva cosa faceva mentre lo faceva, ovvero produrre nell’io lirico “male” e “pianto”.
La contrapposizione tra il tu e l’io prosegue nei versi successivi soprattutto nel v. 3 e ancora di più nel v. 4 con la ripetizione, in varie declinazioni, dell’(hai) “fatto”, che raggiunge il suo apice (climax) con “apposta”; in tutto il verso 4, inoltre, campeggia l’allitterazione della t che si riconnette con il “fatto”.
Da qui tutte le conseguenze espresse nei versi che trovano la loro espressione massima nell’ultimo verso “fin a domani non ti perdonerò mai” perifrasi per esprimere il per sempre del non perdono.
La rabbia di cui parla Tognolini, poi, può declinarsi in tante sfaccettature: spesso anche di natura sociale. Tra queste si distingue, ad esempio, la Rima dello straniero.
L’io lirico è la voce stessa dello straniero: è lui che si rivolge a chi lo accusa di essere straniero, in un crescendo di indignazione che solo la lettura del testo integrale può restituire. Qui mi limito a riportare gli ultimi due versi: “… io sono straniero nel tuo mondo/ Ma tu sei uno straniero di te stesso”.
Ancora: si può essere rabbiosi contro il capo, ma con grazia, ovvero all’interno di una lirica di stampo socratico, nel senso che l’io lirico dapprima asseconda la gioia del capo di essere tale, fino a poi ribaltare la situazione, quando porta al parossismo e al ridicolo l’autoincensarsi del suo interlocutore. Così si rivolge a lui, infatti, negli ultimi quattro versi: “Però dimmi, quando poi rimani solo/ Quando vai in bagno/ Per un bisogno/ E non c’è più nessuno intorno a te/ Chi comandi, i rubinetti del bidè?”
In questi versi Tognolini manifesta che, quando siamo nudi, siamo tutti uguali: e allora è inutile tirarsela tanto.
La scoperta delle fragilità ed esigenze corporali di tutti abbraccia in realtà anche la natura: non a caso ci sono tre liriche parallele, Improperio del regno animale, Improperio del regno vegetale, Improperio del regno minerale. Di queste la più carina è la seconda:
“Sei una testa di rapa, un cetriolo/ Naso a patata con occhi di fagiolo/ Fiato di aglio/ Piedi coi funghi/ Le tue gambe due carciofi lunghi lunghi/ Pelle di ceci/ Pelo di carota/ Capelli di spinaci e zucca vuota/ Sei una zucchina/ Sei uno zuccone/ Sei una fava che cammina/ Un minestrone/ Ti credi bello/ Sedere a ravanello/ Sono educato/ E non parlo del pisello”.
Non credo di dover aggiungere altro se non che questo parlare per metafore può essere molto funzionale quando vogliamo sfogare la rabbia contro qualcuno che non ci sta troppo simpatico. Ora non voglio autorizzare a squalificare nessuno, ma credo che il solo ripetere a se stessi queste invettive, pensando alla persona che vogliamo offendere, possa essere un messaggio magico in grado con la sua energia di raggiungere idealmente il nostro destinatario.
Come si vede, dunque, le liriche, o direttamente o indirettamente sono sempre rivolte contro qualcuno. Quel qualcuno può essere anche se stesso, quando ci si sente tremendamente in colpa di aver fatto qualcosa di sbagliato, Rima contro se stessi.
“Io lo sapevo che era sbagliato/ Perché l’ho fatto?/ Che lì c’è un buio, dove io cado/ Perché ci vado?/ Come si può essere così tonti?/ Dove si va quando si è così fessi?/ Come si fa a dare pugni a se stessi?/ Io non ci riesco a darmi dei pugni/ Ma è anche stupido che ora mi lagni/ Meglio dei pugni c’è un’altra cosa/ Chiedere scusa/ Chiederai scusa, brutto buffone/ Dirai che tu non avevi ragione/ Chiederai scusa, subito e adesso/ Prima di tutto a chi hai ferito/ E quando hai finito/ Chiederai scusa a te stesso.”
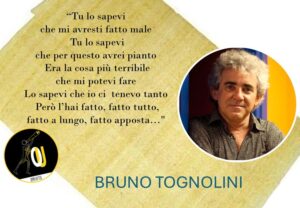
E infine vorrei chiudere con l’ultima lirica che, dati i tempi che stiamo vivendo, è ancora attuale, quasi fosse un testo distopico. E questa è per i grandi, in quanto sono loro che i piccoli imiteranno, in quanto sono loro a consegnare il mondo alle nuove generazioni. Se sarà bello o no, libero o no, dipenderà anche da loro: Ultima rima. Per i grandi. Scongiuro contro il nazismo futuro.
“Gli abbiamo detto che la rabbia non è bene/ Bisogna vincerla, bisogna fare pace/ Ma che essere cattivi poi conviene/ Più si grida, più si offende e più si piace/ Gli abbiamo detto che bisogna andare a scuola/ E che la scuola com’è non serve a niente/ Gli abbiamo detto che la legge è una sola/ Ma che le scappatoie sono tante/ Gli abbiamo detto che tutto è intorno a loro/ La vita è adesso, basta allungar la mano/ Gli abbiamo detto che non c’è più lavoro/ E quella mano la allungheranno invano/ Gli abbiamo detto che se hai un capo griffato/ Puoi baciare maschi e femmine a piacere/ Gli abbiamo detto che se non sei sposato/ Ci son diritti di cui non puoi godere/ Gli abbiamo detto che l’aria è avvelenata/ Perché tutti vanno in macchina al lavoro/ Ma che la società sarà salvata/ Se compreranno macchine anche loro/ Gli abbiamo detto tutto, hanno capito tutto/ Che il nostro mondo è splendido/ Che il loro mondo è brutto/ Bene: non c’è bisogno di indovini/ Per sapere che arriverà il futuro/ Speriamo che la rabbia dei bambini/ Non ci presenti un conto troppo duro.”
In questa mia recensione mi sono limitata a riportare i testi senza commentarli troppo: non perché non meritassero, ma anzi per non spegnerli. Essi, con il loro stile, le loro parole, il loro ritmo, i loro temi, parlano da soli. Leggendoli mi sono molto emozionata e vorrei soltanto restituire il sentore di questa emozione a chi mi leggerà, invogliandolo/a a fare come me: andare in biblioteca e portarselo a casa.
Buona rabbia poetica a tutti!
Written by Filomena Gagliardi
Bibliografia
Bruno Tognolini, Rime di rabbia, Salani editore, 2010, Milano