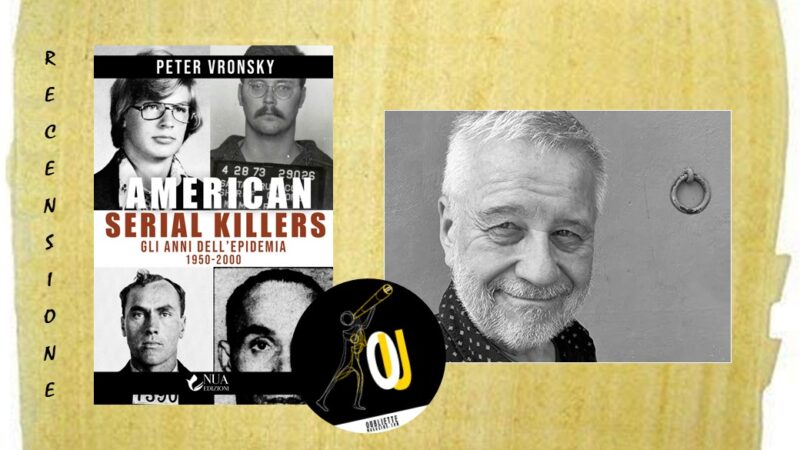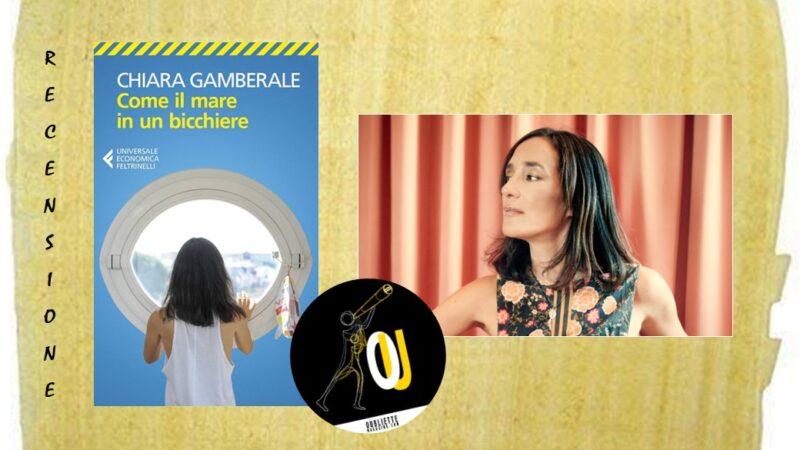“Betty” di Georges Simenon: un romanzo intenso e cupo
«Sono anni che bevo, di nascosto, perché non potrei vivere senza, perché non sono capace di essere come loro, né d’altronde lo vorrei», racconta Betty a Laure.

Figura sfuggente quella di Betty, mai interamente vittima, eppure nemmeno colpevole. È una donna giovane e seducente, ma ambigua, nella quale si rimescolano fragilità ed egocentrismo. La forza attrattiva di Betty sta proprio in questa ambivalenza, tanto che si fatica a capirla fino in fondo. Si rimane in mezzo tra un sentimento di compassione e un senso di rifiuto nei suoi confronti.
Ma a chi si riferisce Betty quando parla di “loro”? Quelli a cui non vuole assomigliare?
In primis alla famiglia, borghese e conformista, con tutti i suoi ipocriti rituali, in secundis a tutti coloro che la vorrebbero diversa da ciò che lei è, quelli che non la ritengono nemmeno in grado di allevare i propri figli.
E chi è Laure, la donna a cui Betty si confida?
Laure è colei che Betty incontra casualmente in un bar malfamato di Versailles. Vedova, più matura di lei, con una storia passata assai triste, Laure diverrà in breve la custode della confessione di Betty.
Il romanzo si struttura così come un lungo flashback in cui Betty rievoca la sua vita, i fallimenti sentimentali, l’emarginazione familiare e l’impossibilità di essere madre e moglie, fino allo scivolare in una deriva esistenziale senza ritorno. Tanto che Betty viene costantemente attirata da situazioni degradanti, quasi come se fosse votata all’autodistruzione.
Il rapporto tra le due donne, Betty e Laure, è particolarmente interessante: Laure, malata e, forse, consapevole della propria fine ormai vicina, sembra accompagnare Betty in un percorso di redenzione, ma senza mai crederci troppo. O per nulla.
Betty (1961) è tra i romanzi più intensi e cupi di Georges Simenon. Si distingue come un ritratto al contempo crudele e compassionevole della fragilità umana. Appartiene alla produzione dei cosiddetti “romans durs”, opere in cui l’autore abbandona l’investigazione poliziesca per esplorare la dimensione più intima e perturbante dell’esistenza.
Il romanzo non è una semplice successione degli eventi, ma piuttosto il modo con cui la memoria li ripropone. Betty racconta, ma ogni ricordo è intriso di omissioni, distorsioni e fantasticherie. Simenon sembra suggerire che nessuno è in grado di restituire la verità della propria vita, che ogni autobiografia è inevitabilmente una ricostruzione, se non una costruzione vera e propria, una menzogna necessaria, come ben sanno gli psicoanalisti.
In questo senso, Betty diventa anche un romanzo di approfondimento relativamente alla narrazione: sul bisogno di dire e sul rischio che ogni parola falsifichi ciò che pretende di rivelare. La soggettività, sembra suggerire Simenon, è sempre opaca, e la confessione non coincide mai pienamente con la verità. Diviene piuttosto la nuova verità.
Lo stile di scrittura è essenziale, asciutto, veloce. Come sempre. Uno stile capace di rendere l’atmosfera quasi claustrofobica degli spazi e degli ambienti di questo romanzo. Ogni pagina sembra carica di una tensione sotterranea, di un presagio di tragedia. Non c’è mai spazio per la redenzione o per un lieto fine: la parabola di Betty è segnata da un destino che la sovrasta, e ciò che resta è un senso di sconforto e di rassegnazione.
Il romanzo rimanda vagamente alle correnti dell’esistenzialismo francese del dopoguerra, pur mantenendo una sua specificità. Se anche le situazioni, l’ambientazione e i dialoghi ricordano, ad esempio, i romanzi di Sartre, il messaggio di Simenon si differenzia assolutamente da quello del filosofo francese. Per Sartre l’uomo è condannato alla libertà e ogni sua scelta implica una responsabilità assoluta.

In Betty, il discorso si rovescia: la protagonista sembra incapace di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Betty agisce, sbaglia, distrugge, ma non elabora mai una riflessione consapevole. È trascinata da pulsioni, istinti, da un bisogno quasi inconscio di autodistruzione. In questo senso, Simenon sembra opporsi a Sartre: mentre per l’esistenzialismo la libertà è ineludibile, in Simenon la libertà appare come un’illusione, e gli individui paiono governati da forze oscure e irrazionali.
In ogni caso Simenon non indugia mai nella speculazione filosofica, preferendo la concretezza narrativa che lascia al lettore il compito di interrogarsi sul senso ultimo vicende umane.
ll regista francese Claude Chabrol realizzò un adattamento cinematografico di Betty nel 1992, con Marie Trintignant e Stéphane Audran nei ruoli principali. L’ho rivisto subito dopo aver letto il romanzo. Mi è piaciuto, è un bel film, interessante. Rispetto al libro, mi pare che metta più in evidenza l’aspetto della critica sociale.
Per concludere, Betty è un romanzo che lascia addosso un senso di inquietudine durevole. Non offre rimedi, non propone morale, ma rimanda la condizione di una donna che si smarrisce in una lunga discesa verso l’inferno.
Written by Algo Ferrari
Bibliografia
Georges Simenon, Betty, Adelphi, 1992