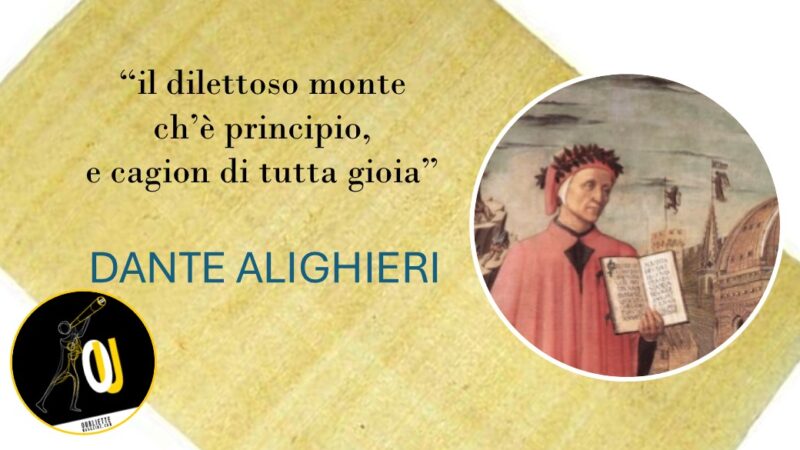Edgar Allan Poe: vita immaginifica dell’uomo che temeva il buio
Quando si sta a lungo nel buio, occorre sfruttare occhi perfezionati dall’oscurità per raccontare quello che si è visto perlustrando a fondo quel buio.

Difficile dire se i palcoscenici dove i suoi genitori (entrambi morti prematuramente a seguito delle complicazioni della tubercolosi) recitano commedie e tragedie a seguito di un’oscura compagnia teatrale, possano aver influito sul suo futuro geniale istrionismo, l’humus dove il piccolo Edgar Allan Poe intuisce che tragedia e commedia non sono che due facce della stessa medaglia, e che se una vita riesce a tenerle insieme, forse ha trovato la soluzione del proprio rapporto con la volubilità del destino.
Di sicuro, la pressione psicologica accusata da chi, rimasto orfano, sa di poter vivere grazie alla carità altrui, ne determina il carattere. Specie se questa condizione è vissuta nella Virginia schiavista e feudale di inizio Ottocento, all’interno della “Linea Mason-Dixon”, dove cresce, nonostante sia nato a Boston. Perché Edgar Allan Poe sarà per tutta la sua breve esistenza un uomo ancorato alle sue radici, e molte sue critiche al progresso, alla democrazia e alla credenza nella perfettibilità dei popoli derivano dal suo essere un “uomo profondamente del Sud”. Ma se i costumi mentali della vita virginiana ne conformano il pensiero, è invece il folclore delle storie di fantasmi e i racconti sui cimiteri e i cadaveri erranti nelle foreste di quello che in seguito sarà conosciuto come southern gothic, a determinarne l’immaginario, con ampio respiro nel campo del sovrannaturale.
Rimasto orfano prematuramente, Edgar è affidato a Frances e John Allan, una coppia di Richmond che provvede alla sua educazione insieme a quella degli altri figli naturali; dal 1815 a 1820 soggiorna prima in Scozia, poi a Londra, dove John si è trasferito per affari, e un certo folclore anglosassone non manca di penetrare nel suo già fervido immaginario.
L’ascendente di Lord Byron si fa sentire sul quindicenne bostoniano, e i suoi primi versi cominciano a rivelare i tratti di un talento precoce che si va a incastonare in un carattere orgoglioso, in cui l’eccitabilità nervosa e una certa propensione alla violenza non fanno che tradire una sostanziale debolezza. È in quel periodo che Edgar conosce Helen, la prima di una lunga serie di figure femminili idealizzate, e per questo impossibili da conquistare, un amore che durerà tutta una vita, sia pure sotto le spoglie di molti altri amori futuri. Amore segreto e sfortunato, alla luce della morte precoce di lei, a soli trent’anni. Rifugiatosi nella casa degli Allan, dove le continue discussioni col suo protettore, che lo vuole avvocato, non fanno che peggiorare il suo animo eccitabile, a nulla vale l’innamoramento, ricambiato, per una ragazzina dai riccioli biondi, Sarah Elmira Royster, costretta però dai genitori a sposare un pretendente che rappresenta un partito più affidabile rispetto a un anarchico poeta. È così che Edgar si congeda dagli Allan e da Richmond nel 1826, per intraprendere la vita da studente presso l’Università della Virginia, diventando ben presto il pupillo dei professori, che apprezzano le sue doti di lettore infaticabile di storia antica, matematica, astronomia e letteratura, ma deprecano la sua attitudine alle risse e al rum, e quando i debiti di gioco lo costringono ad abbandonare l’università, e le ricorrenti liti col patrigno protettore non gli permettono oltre una tranquilla permanenza a casa degli Allan, Edgar decide di arruolarsi nell’esercito. Dal materiale accumulato nei giorni oziosi di quell’esperienza a Fort Moultrie, in Carolina, ne scaturirà “Scarabeo d’oro”, mentre del successivo e breve soggiorno all’accademia militare di West Point, favorito dall’intercessione di John Allan, sarà “Israfel, a Helen e Leonore”. È di quel periodo un viaggio a Baltimora, alla ricerca della sua famiglia d’origine.
Per un periodo vive a casa di sua zia Maria “Muddy” Clemm, dove conosce suo fratello maggiore, tubercolotico all’ultimo stadio, che morirà poco dopo, e i suoi cugini, Henry e soprattutto la piccola Virginia, una ragazzina mentalmente poco sviluppata, che costituirà il complesso e irrisolto enigma dell’intera vita del poeta, diventandone dopo la morte John Allan prima la fidanzata, poi la moglie a soli quattordici anni.
Ancora oggi, l’ipotesi più plausibile è che il venticinquenne poeta avesse deciso di sposare Virginia per proteggersi dalle relazioni con le altre donne, mantenendole sul piano dell’amicizia, probabilmente per un’inibizione sessuale di natura psicologica, che avrebbe obbligato Poe a sublimare le proprie passioni sul piano del sogno e dell’ideale.
Siamo a metà degli anni Trenta, e fra l’assillo della fame e dalla miseria, a cui si aggiunge l’uso di alcol e oppio, necessari per stimolarne l’immaginazione nei racconti, considerati più vendibili rispetto alla poesia, Edgar si barcamena come giornalista a dieci dollari la settimana al Messanger, dove cominciano ad apparire le puntate de “Le avventure di Arthur Gordon Pym”.
Nel 1838 lo ritroviamo a Filadelfia, insieme alla moglie-bambina Virginia e a Muddy, assunto come direttore letterario dal Burton’s Magazine, successivamente rinominato Graham’s Magazine. Sono gli anni della maturità artistica, quelli nei quali vengono alla luce “Berenice”, “La caduta della casa Usher” e “Ligeia”, predominati dall’aspetto sadico e necrofilo del suo genio. Il Graham’s vende, e passa da cinquemila a quarantamila sottoscrittori sotto la direzione di Poe che, nel pieno del suo fervore letterario, decide di cimentarsi con i racconti analitici, per smontare le critiche di quanti lo accusano di dedicarsi solamente al morboso.
Nascono “Gli omicidi della via Morgue”, con l’entrata in scena di Monsieur August Dupin, suo alter ego, e “Il mistero di Marie Roget”, dove il lato morboso corre parallelamente alla fredda analisi. In quel periodo Virginia ha il suo primo attacco di tubercolosi, e la malattia di sua moglie non fa che aumentare i tratti anormali di Edgar. Le sregolatezze non si contano, come le assenze ingiustificate dal lavoro. Iniziano le fughe e i ritorni a casa in condizioni pietose, e nonostante il prodigarsi di Muddy e, per quanto era nelle sue possibilità, di Virginia, i deliri e le allucinazioni cominciano a diventare preoccupanti. Nonostante ciò, Edgar si vede assegnare il premio istituito dal Dollar Newspaper per il racconto “Lo scarabeo d’oro”, felice intreccio fra il Poe analitico con quello dell’avventura e del mistero.
Lasciata con Virginia e Muddy Filadelfia per New York nel 1844, Edgar trova nella periferia della città l’oasi ideale per portare a termine “Il Corvo”, suo ritorno alla poesia, un progetto che lo ossessiona da anni, finalmente completato nella sua versione definitiva. Corre l’anno 1845. Poe ha trentasei anni e un modesto impiego presso l’Evening Mirror, ma l’insperato e incredibile successo del “Corvo” lo trasformano nell’uomo del giorno. La misteriosa magia del poemetto, il suo oscuro richiamo, non meno della “leggenda nera” che aleggia intorno al suo autore, fanno del “Corvo” l’immagine stessa del romanticismo nel Nordamerica.
Le porte dei salotti letterari si spalancano, il pubblico accorre alle sue conferenze ansioso di sentirgli recitare il poemetto, ma, in piena apoteosi, Poe si fa sopraffare una volta di più dall’alcol, causa del successivo periodo di squilibrio psichico, che gli costa la perdita di amicizie importanti e anche dell’ispirazione, visto che da quel momento verrà alla luce solo “Eureka”.
Intanto la salute di Virginia peggiora, fino alla morte, avvenuta nel gennaio del 1847. Poe segue il feretro avvolto nel suo vecchio mantello di cadetto, e per l’ennesima volta ripiomba nell’oscurità. I demoni dell’oppio e dell’alcol tornano a fargli visita, e a nulla bastano le cure di Muddy, che deve restare per ore accanto a lui, tenendogli la mano, per la paura del buio che lo perseguita da quando era bambino; e nemmeno la presenza di Marie Louise Shew prima, e poi dell’eterea Sarah Helen Whitman, amante dello spiritismo, con la quale il poeta intrattiene una corrispondenza amorosa, riescono a liberarlo dai suoi vizi.
Lacerato da un irrisolto conflitto fra l’immaginario e il reale, Poe parte per raggiungere Helen, senza però mai giungere a destinazione. In una lettera, lui stesso descriverà il suo fallito tentativo di suicidio, con il laudano.
Nel luglio del 1849 Poe lascia New York per tornare a Richmond, congedandosi da Muddy. Arriva a Filadelfia, e ormai completamente avvolto nei suoi deliri entra nella redazione di una rivista invocando protezione. La mania di persecuzione lo sta fagocitando, i giornalisti della redazione riescono in qualche modo a imbarcarlo per Richmond, dove i pochi amici rimasti gli offrono gli ultimi giorni di tranquillità. Poe tiene un’ultima conferenza e rivede Elmira che, rimasta vedova, accetta di sposarlo, ma l’esigenza di rivedere Muddy, e con lei un editore che ha accettato di occuparsi dell’edizione della sua intera opera, lo spinge a imbarcarsi per Baltimora, per poi proseguire per Filadelfia.
Una volta raggiunta Baltimora, ciò che accade nei cinque giorni successivi sarà argomento di numerose congetture, quasi un non luogo dove la realtà incontra la finzione letteraria. Quello che è certo, è che un medico suo amico riceve un biglietto con cui lo si informa che un signore di sua conoscenza ha urgente bisogno di aiuto. Il biglietto proviene da un tipografo che ha riconosciuto il poeta in un ubriaco abbandonato in una taverna in preda al delirio. E chi scrive lo immagina così, perso in quei luoghi nascosti dell’anima in cui la penombra scolora nel buio, Edgar Allan Poe, ormai incapace di intravedere una luce nel buio della galleria delle sue paure inconsce.
«Che Dio aiuti la mia povera anima», sono le sue ultime parole prima della morte, avvenuta il 7 ottobre 1849.
“Aveva i capelli scuri, che portava molto lunghi e pettinati all’indietro. Gli occhi erano grandi e luminosi. Aveva il viso completamente rasato, il naso lungo e dritto, i lineamenti molto fini. Era pallido, esangue. Guardava in maniera triste, malinconica. Era estremamente magro, ma era elegante e aveva un atteggiamento raffinato.”
Da una lettera di una vicina di casa dei Clemm, Mary Devereaux, che, descrivendone i tratti, consegnerà il poeta all’immaginario condiviso.
Le note di questo testo sono debitrici a Julio Cortázar, che nel suo “Vita di Edgar Allan Poe” ci restituisce la complessa vicenda umana e letteraria di un autore troppo spesso confinato nei “casi patologici” della letteratura.
Written by Maurizio Fierro