“Arabesques” di Giovanna Fracassi: l’intreccio poetico
“Un filo,/ un’onda lunga,/ un barbaglio di luce/ o una linea nera.// Che importa?// È ogni cosa/ che ci unisce,/ al di là di ogni/ nostro volere/ o non volere./ È una chiamata/ o una risposta/ ininterrotta/ […]”[1]

“Arabesques” è la prima silloge poetica di Giovanna Fracassi (Rupe Mutevole, 2012), preceduta da pubblicazioni di singole poesie nel 1981 nella rivista “Incontri” e nel 2011 nel settimanale “Il foglio”. Il titolo riprende un motivo conosciuto ai più ma è significativo l’uso del plurale secondo il gusto francese (in lingua italiana plurale e singolare si presentano nella medesima forma “arabesque”) se lo si confronta con il curriculum dell’autrice, infatti, la sua tesi di laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Padova si intitolava “Il tema della corporeità nella filosofia di Jean Paul Sartre” e più recentemente, nel 2023, ha dato alle stampe un intenso saggio intitolato “Essere e corpo in J. P. Sartre”.
Un legame con la letteratura e la filosofia francese che non si palesa solo con l’uso della desinenza in -s ma che si respira nella silloge ivi presente per “[…] il baratro irrequieto/ di una voragine/ di significato/ dove, infine,/ cercare/ l’altra parte di sé”[2] tipico dei poeti decadenti e simbolisti dell’Ottocento.
Ma l’uso della parola arabesques nasconde un legame ancora più stretto tra il significato del termine e la struttura della raccolta: la ripetizione geometrica che dona alla superficie la sinuosità dell’intreccio e l’eleganza della sensazione di esistenza ed immortalità. Concetti che possono apparire complessi ma che, se osservati con la dovuta cura, riescono a palesare il parallelismo con i versi di Giovanna Fracassi.
Così come nei tessuti e negli edifici si presenta l’uso di una figura geometrica ripetuta anche nella nostra silloge si ha nella superficie una figura retorica che prevale su tutte, l’anafora, ma scavando a fondo nella lettura si osserva la sequenza di un tema ricorrente[3]: la ricerca di una via.
La maggior parte delle liriche, infatti, seppur con andamento differente auspicano la possibilità di una realtà diversa da quella vissuta, talvolta è il dolore a prendere il sopravvento tanto da non veder altro che la caduta (“[…] Inutile cercare:/ vano è ogni appiglio/ per evitare la caduta.”)[4] talaltra l’anelito viene descritto come fuoco inesauribile (“[…] come fuoco inatteso,/ piaga sanguinante/ di eterno abbandono/ marchio d’inesausta ricerca.)[5] o come illusione (“[…] È il mio respiro/ che nascosto/ si confonde/ con quello del vento/ che leggero/ ora mi accosta/ ora mi allontana/ questa profumata trama/ che mi cela/ allo sguardo altrui/ e mi illude di aver trovato/ infine rifugio/ da nessun altro/ se non da me stessa.”)[6] od ancora come labirinto (“[…] infine,/ nel mio labirinto segreto/ alla ricerca vana/ di quel filo d’Arianna/ […]”)[7] in cui i pensieri scivolano lenti.
Caduta, fuoco, labirinto ed illusione: le discordi direzioni sono accese dalla medesima passione che, bruciando con incessante impeto, sfumano in sofferenza per l’assenza della beatitudine agognata (che, invece, si raggiungerà nelle successive raccolte dell’autrice). “Una profumata trama” ‒ che diviene rifugio con la tecnica della fuoriuscita da sé[8] e con la similitudine tra il respiro[9] ed il vento ‒ estende lo spazio ed il tempo in cui vive il soggetto poetico, risultando sia creatore della dilatazione sia esclusivo beneficiario (“[…] e mi illude di aver trovato/ infine rifugio/ da nessun altro/ se non da me stessa”).
Ed è proprio in questo stato di evasione dalla mente che la parola poetica evoca archetipi di cui, talvolta, lo scrivente non si accorge perché divenuto tramite dell’eterno che, senza sosta, si manifesta. Lo si nota chiaramente nella lirica intitolata “Vieni con me”[10] nella quale l’anima invita la mente ad intraprendere l’impresa del viaggio verso il nucleo.
“Viaggio negli abissi neri/ di quest’universo in espansione./ Laggiù pulsano/ le luci di una vita/ che più non mi appartiene.// Vieni con me/ là dove/ il passato non ha più valore/ e dove il futuro/ altro non è che vuota parola.// Ti porterò/ nella passione,/ nella disperazione/ quando il cuore/ non deve bussare/ alle porte della ragione.// […]”
L’anima incita, in cinque strofe, con uno schema che vede un incipit con il verbo “Viaggio” (prima persona del presente indicativo) e segue con la successione simmetrica “Vieni con me/ Ti porterò/ Vieni con me/ Ti porterò” (seconda persona presente indicativo e prima persona futuro) trasmettendo la stabilità del viaggio perpetuo e l’incitamento all’unione in questo incedere con la “promessa” di un porto sicuro[11] dove “il cuore/ non deve più bussare/ alle porte della ragione”. L’anima rivela la sua provenienza dagli abissi dell’espansione dell’universo che, ora, non gli appartiene più perché racchiusa in un corpo mortale (secondo la dottrina platonica). In questa estensione passato e futuro sono vuote parole perché il tempo è inteso in modo circolare e non lineare.
“Vieni con me” prosegue e termina con “Vieni con me/ sulle fragili ali/ delle note incantate/ di questo mio/ infinito struggimento.// Ti porterò/ nel guscio d’argento,/ là dove/ nascondo/ le catene alla mia libertà.”

L’“infinito struggimento” dell’anima è propriamente quell’apparente distacco dall’Uno che con “le note incantate” ‒ i versi poetici ‒ si ravviva nella memoria. Nell’ultima strofa il concetto filosofico dell’uovo cosmico si rivela in tutto il suo splendore, infatti, il “guscio d’argento”[12] rappresenta per gli induisti l’uovo cosmico suddiviso in due metà: una superiore d’oro che riproduce il cielo ed una inferiore d’argento che riproduce la terra. Le catene della libertà dell’anima sono nascoste nella terra (perché l’anima è racchiusa nel corpo mortale), dunque la continua chiamata (“Vieni con me/ Ti porterò”) non è altro che la brama del cielo ‒ la brama dell’origine ‒ laddove l’intelletto è invitato ad unirsi.
Non si andrà oltre in questa breve lettura della silloge “Arabesques” anche se molteplici sono le suggestioni dipinte da Giovanna Fracassi: a voi scoprirle, a voi percorrerle.
“[…] Le mie notti/ ad interrogare Dio/ perdendomi in quel cielo/ per me straniero.”[13]
Written by Alessia Mocci
Note
[1] Giovanna Fracassi, Arabesques, Rupe Mutevole, 2012, p. 31
[2] Ibidem, p. 16.
[3] Per la sequenza di temi non si è in totale accordo con la prefazione del volume ove si legge “Arabesques gravita dunque in una situazione di reale/irreale nella quale non ci sono tematiche principali”, ma non me ne vorrà la curatrice perché sono io la firmataria della prefazione. Rileggere un’opera dopo più di 10 anni e rileggere le mie osservazioni mi han fatto riflettere sulla differenza di osservazione e di priorità, se 10-15 anni fa la mia attenzione verteva maggiormente su una struttura superficiale (con il significato: di superficie, nel senso proprio del termine, badare alla struttura visibile e dunque alla retorica ad esempio), oggi la mia analisi scava maggiormente nel profondo del senso tralasciando l’uso di figure retoriche o stilismi.
[4] Giovanna Fracassi, Arabesques, Rupe Mutevole, 2012, p. 13
[5] Ibidem, p. 32.
[6] Ibidem, p. 35.
[7] Ibidem, p. 78.
[8] Per tecnica della fuoriuscita da sé si intende quella particolare tipologia di meditazione (che si può praticare sia con l’atto della scrittura sia con il rispetto del silenzio in postura statica) che produce l’annichilimento della mente in favore dell’ascolto dell’interno di sé fuoriuscendo dallo stesso sé. Si arriva, dunque, ad una connessione profonda con ciò che Carl Gustav Jung denominava come “inconscio collettivo”.
[9] La similitudine tra respiro e vento/aria è una di antica memoria ‒ cara ai poeti ed ai filosofi di ogni epoca ‒ che riprende lo stesso etimo della parola pneuma (in greco antico πνεῦμα; in sanscrito prāṇa) con il significato di aria, soffio vitale, respiro. Nei versi della lirica “Saette” (p. 35), infatti, l’Io poetico “confonde” il proprio respiro con il vento, dilatando così la dimensione dello spazio, perché se il respiro umano ha un limite spaziale definito, il vento si espande senza confini in tutto il globo. Ergo l’immedesimazione con il vento dona la libertà dalle restrizioni materiali del corpo a favore di un ampliamento che procede verso l’eternità dello spirito.
[10] Giovanna Fracassi, Arabesques, Rupe Mutevole, 2012, p. 45.
[11] Un altro esempio di incitamento al viaggio con relativa promessa di porto sicuro è presente nella lirica “Involucro” (p. 44): “[…] Nascosto è alla coscienza/ il ghigno tremendo del caos/ che dilaga con le fauci scoperte/ per ghermire ogni spiraglio/ d’un nuovo remore:/ amore”.
[12] Si troverà il “guscio d’argento” anche nella lirica intitolata “Alcova” nella quale si legge: “È il mio cassetto segreto/ un’alcova inviolata/ un guscio d’argento/ ed una perla di solitudine// […]”.
[13] Giovanna Fracassi, Arabesques, Rupe Mutevole, 2012, p. 72.
Info
Scheda autrice su Scrittori.net


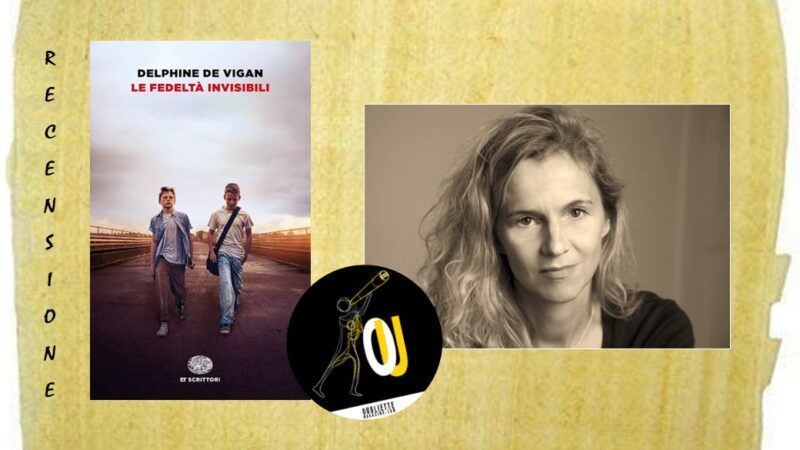
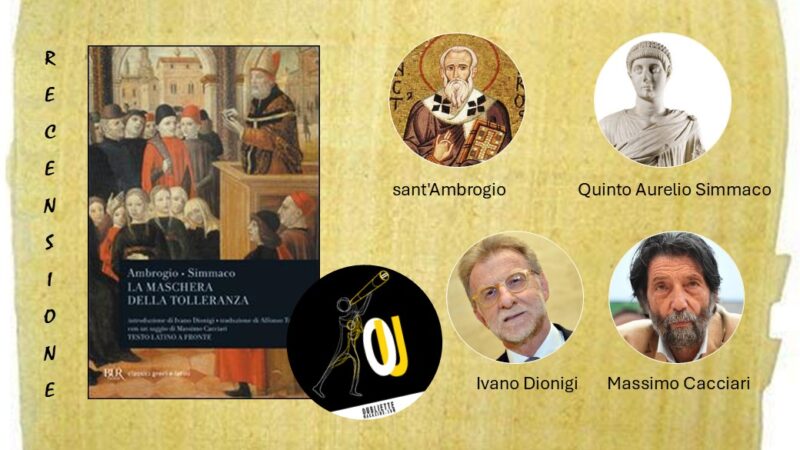
Un pensiero su ““Arabesques” di Giovanna Fracassi: l’intreccio poetico”