“Il mondo dei robot” film di Michael Crichton: non arrecare danni agli umani
È lo scrittore praghese Karel Capek il primo a parlare di robot (da “robota”, lavoratore, parola ceca diventata poi di uso internazionale) nella sua pièce del 1921 R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti), svelando la faccia oscura del progresso, minacciosa e morbosa.
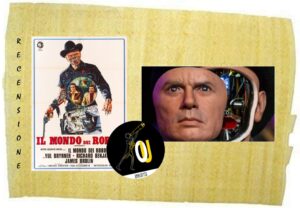
Nel dramma teatrale, i robot, costruiti dallo scienziato demiurgo dottor Rossum con materia organica, per alleviare le fatiche degli esseri umani, cominciano poi a ribellarsi e a combatterli, finendo per eliminarli dalla terra, dove poi si diffonderà il loro impero dell’ordine.
L’opera ha grande successo, viene tradotta e messa in scena in molti paesi, e negli anni Cinquanta (anni fiorenti per la fantascienza, sull’onda di riviste come “Astounding Science Fiction”, e dei racconti di Fredric Brown, Philip K. Dick, Isaac Asimov e Stanislaw Lem) lo scenografo statunitense Robert Kinoshita si ispira a Capek quando costruisce Robby the robot, protagonista su grande schermo ne “Il pianeta proibito”, e in seguito diventato un giocattolo molto diffuso fra i ragazzini americani.
C’è da immaginarlo fra le mani di un ancora adolescente Michael Crichton, futuro autore di libri da oltre centocinquanta milioni di copie e, una ventina di anni dopo, giovane medico laureato alla Harward Medical School che vanta alcuni romanzi scritti sotto pseudonimo e un primo bestseller, “Andromeda” (1969), thriller fantascientifico su una epidemia innescata da un agente patogeno alieno, da cui viene tratto il film omonimo diretto da Robert Wise.
Visto il successo cinematografico ottenuto dal suo romanzo, nell’estate del 1972 Crichton decide di mettere da parte definitivamente la professione medica per dedicarsi alla scrittura, anticipando, come già in parte aveva fatto il suo collega Richard Matheson, l’attuale mestiere di showrunner alla Nic Pizzolatto, unendo cioè sceneggiatura e regia in un unico flusso narrativo, nel quale l’autorialità fa da garante al linguaggio del pensiero.
Viene alla luce “Westerland”, anticipatore di quel “Jurassic Park” (scritto da Crichton diciotto anni dopo) da cui Steven Spielberg trarrà il famoso film, diventato mito nell’immaginario cinematografico condiviso del Novecento.
Dunque, “Westerland” (“Il mondo dei robot”). Siamo nell’anno di grazia Duemila, e la vacanza alla moda degli americani facoltosi si trascorre a Delo, un altrove permeato da una morale a bassa intensità, dove androidi del tutto identici agli umani si aggirano impersonando i personaggi dei tre settori-regni nei quali è suddiviso: Far West, Medio Evo e Antica Roma.
Una gioia, per i clienti, liberi di interpretare a giorni alterni il buono e il cattivo, lo sceriffo o il bandito, in un sottilmente perverso gioco di ruolo che ha una sola regola: il giocatore non può mai perdere, e i robot sono sempre sconfitti. Il tutto sotto la supervisione di una sala controllo gestita dagli operatori del parco divertimento. Una finzione, quindi, un mondo a parte dove finalmente la fantasia prende le distanze dalla realtà, per fluttuare libera fra il Far West e l’Antica Roma, e dove chi ha i soldi può ritagliarsi la propria illusione in un gioco su scala umana che anticipa quelli su schermo. Sembra davvero tutto cool, perché, diciamocelo, a chi non piacerebbe un parco divertimenti così, dove poter liberare il bambino che è in noi? Anche con i suoi istinti non sempre commendevoli, ça va sans dire. E poi è risaputo: fra gli americani e i parchi divertimenti, l’attrazione è di lunga data, e affonda le radici nella storia.
Il primo fu inaugurato nel 1875, a Coney Island, e già nei primi anni del Novecento si possono contare più di duemila luna park, mentre Disneyland, primo autentico parco a tema, viene ufficialmente aperto nel 1955. Forse sarà stato proprio quest’ultimo una delle fonti di ispirazione per Crichton che, forte del suo solido bagaglio scientifico che ne farà uno dei massimi autori di science fiction, ne propone una sua personale versione distopica.
Già, perché Peter e John (interpretati da Richard Benjamin e James Brolin), i malcapitati clienti di Westerland (“Il mondo dei robot”), non possono immaginare che l’avventura si trasformerà in una tragedia, perché poi un errore di sistema può sempre capitare, magari diffondendosi fra i robot e mandandoli fuori controllo, facendo così accadere l’irreparabile, con l’androide pistolero, prima di quel momento sempre sconfitto, d’un tratto diventato responsabile del proprio destino, fino a ribaltare e prendersi la scena, trasformandola in un inatteso terreno di vendetta.
“In facie legitur homo” dicevano i latini, e anche se artificiale, quella glaciale e inespressiva del pistolero Yul Brynner diventerà il prototipo per altri iconici futuri umanoidi, dall’androide Roy Batty di “Blade Runner”, al terminator di Schwarzenegger nel film omonimo.
“Westerland” è respinto da tutte le case di produzione a cui viene sottoposto, tranne una, la Metro-Goldwin-Mayer, che accetta la sceneggiatura di Crichton imponendo però una produzione a basso budget. Lo scrittore regista accetta, il film esordisce nelle sale americane il 21 novembre 1973 ed è un successo immediato.
In Italia esce circa un mese dopo con il titolo “Il mondo dei robot”. Siamo agli inizi dei Settanta, la cultura di massa non ha ancora familiarizzato con i concetti di clonazione e Dna, come avverrà dopo il successo planetario di “Jurassik Park” e del suo seguito, “Il mondo perduto”; i droni e la combinazione fra intelligenza artificiale e piattaforme robotiche per creare umanoidi militarizzati (Liut, “Furia” in ucraino, è attivo insieme ai suoi fratelli robot dalle parti di Sumy…) è ancora nella mente distopica di qualche scienziato, ma Crichton è un già maestro nell’insinuare il dubbio sulle progressive sorti del genere umano, troppo affidate alla fiducia verso uno scientismo sempre più pervasivo.
Perché allora anche i parchi giochi artificiali possono diventare luoghi poco edificanti, e i robot scappare di mano al controllo, la ribellione diventare il paradigma rovesciato fra “noi” e “loro”, e un semplice errore di sistema provocare l’infrazione delle tre leggi della robotica postulate nel 1940 da Isaac Asimov in una conversazione con il direttore di “Astounding Science Fiction” John W. Campbell.
Soprattutto la prima: non arrecare danni agli umani.
Written by Maurizio Fierro



