“Memorie dal quarto piano” di Carlo Alberto Parmeggiani: un’ironia quasi tragica
-
Ideologia e stile.
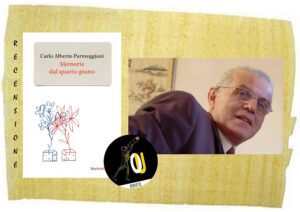
Ho sotto gli occhi l’indice delle Memorie dal quarto piano, ultimo libro del prolifico e maturo (come scrittore, nonché di anni e di esperienze cosmopolite) Carlo Alberto Parmeggiani[1]. Un indice con rubriche canonicamente introdotte dalla preposizione “di” (quella del complemento di argomento) secondo la tradizione che intende l’indice come un aiuto non disinteressato nei confronti del lettore che volesse farsi una sintetica idea di che cos’ha per le mani, e godersi la benefica anticipazione delle sequenze narrative e per decidere infine se acquistare, leggere e magari far leggere proprio quel libro lì.
Invece le rubriche del Parmeggiani non informano un granché sui contenuti dei rispettivi capitoli: si pregiano piuttosto di gustosi e quasi ludici ornamenti formali, né futili né pleonastici, qui come in tante delle trecento pagine del libro.
Soffermiamoci su questo mirabile accostamento poco giudizioso: «Di performance e di auspici di tarocchi». Performance: prestazione particolarmente valida, risultato considerevole o ammirevole; parola moderna e alla moda, esponenziale dell’ideologia efficientista, connotante un ordine costituito da chi sa e sa fare, dall’uomo fabbro della sua fortuna… ma qui accostata ai divinatori tarocchi, di cui è cultrice la credula sorella dell’Io narrante: Flora, che per dolorose esperienze pregresse (una deludente ed interrotta convivenza; la morte del figlioletto Lucio) non si sente parte dell’umanità fabbrile, ma in balia di un dis-ordine stabilito da un destino che può essere benevolo ma anche cinico e baro. Perché l’esistenza è sostanziata dall’aleatorietà: soltanto possiamo appropriarci «Di solide incertezze» un ossimoro che dà il titolo ad un altro capitolo, e che l’autore imputa, in un’intervista che più volte citeremo, alla «doppiezza di ogni cosa».[2] Si veda ancora: «Di produttività e di passaggi con passeggi». Ancora un termine attinente al campo semantico delle “tre EEE” (Efficienza, Efficacia, Economicità: «la capacità di raggiungere l’obiettivo prefissato, l’abilità di farlo, al costo minore possibile, cioé impiegando le risorse minime indispensabili»[3]) che cozza con un’enigmatica paronomasia: «passaggi con passeggi»: passaggi a un altro ufficio… con passeggi. Troveremo altre gustose paronomasie nel testo stesso: «di passare meno tempo a pensare al tempo che passava»; «ormai era quasi a tutti chiaro che la vita, come una vite fissata a una parete, poteva essere svitata da un microscopico organismo»; «perché [io] trovassi la toppa per tappare il vuoto non vuoto del dottor Fuscagni». Ma torniamo al nostro indice. Sembra che “paronomasia” consuoni con “parodia”. Ecco la dissacrante ripresa di un sintagma illustre: l’evangelica moltiplicazione dei pani che diventa «una moltiplicazione delle pene»; ecco la frusta espressione burocratica, quasi obbligatoria a conclusione di ogni rispettabile Ordine del giorno, che si rovescia in «Di varie e non eventuali»; ecco una rubrica in latino maccheronico «In girum imus nocte» che può apparire esercizio goliardico ma che per contro inaugura un capitolo tragico, dove il narratore riferisce sugli ultimi giorni e sul suicidio del padre. Ecco infine un cultismo: «Di pericoli scampati e notturnali». “Notturnale” è voce dotta e tecnica[4], denota qualcosa che avviene o si svolge di notte (qui, un amplesso, l’unico, in tutto il libro, registrato con un pudore quasi manzoniano: «… le proposi di passare insieme a casa mia la serata. A cui seguì una notte nella quale presi sonno senza le infide pastiglie per dormire»). È in ossequio al famoso tormentone diffuso subito dopo la guerra da Elio Vittorini sul suo “Politecnico” («Può un poeta ignorare il secondo principio della termodinamica?»), che Parmeggiani (il quale, fra l’altro, insegnò matematica a Ginevra) intitola il penultimo capitolo «S = k log W», la famosissima equazione dell’entropia svelata al mondo da Ludwing Boltzmann? No certo: ben altro è lo scopo. Infatti l’autore, a proposito della legge dell’entropia (lui preferisce parlare di «disordine», termine più comprensibile ai più) già nell’incipit, in una frase riportata (seppure solo in parte) anche in quarta di copertina, istituisce un rapporto tra vita e disordine:
“Sebbene la legge del disordine dichiari che pure l’universo è destinato prima o poi a scomparire, io, come egocentrico individuo associato a quella universale sparizione, trovavo la questione meschina e inadeguata al fatto che si nasca per qualcosa, per un qualche motivo che ancora non ci è dato di sapere e mai sapremo nemmeno se campassimo due vite. Inoltre, svigorita in me ogni ambizione di carriera, spenta ormai ogni passione, di fama, di far soldi, di santità cristiana, di viaggi, di notti di piaceri levantine, o d’ogni altra cosa, lecita o segreta che può desiderare il genere umano, non sapevo più che fare di me stesso, pur rimanendo nella bizzarra convinzione che di suo, la vita, ancora mi dovesse qualcosa.”
E nella citata intervista, a riguardo della vita (del protagonista narratore, dei suoi colleghi d’ufficio e delle donne che “nel privato” gli stanno più o meno accanto), Parmeggiani così chiosa: «una vita che si svita, con l’inedia che sempre la sorrade, passando da un ordine a un disordine».[5] Un disordine che l’autore autodenuncia anche a proposito del proprio stile, quando poco dopo afferma di usare «frasi un po’ a imbuto, che attraggono verso qualcosa di più profondo che non il semplice enunciato».[6] E quindi, aggiungerei, contraddicono la superficiale impressione di trovarsi davanti a un periodare classicheggiante, di un novello Cicerone, che, per ben esprimere tutto quanto va detto, sa servirsi di un’armoniosa strutturazione calibrata fra paratassi e ipotassi. L’apparente volontà di spiegare con estrema precisione l’effettivo stato delle cose, per rilevare invece il mistero che in realtà le sottende, risulta pure da altre due apparentabili ricorrenze formali, sconsigliate dalle scuole di scrittura narrativa ed emendabili da qualche troppo zelante editor: l’allitterazione e la ridondanza. Limitandoci al nostro “Indice” (e avvertendo che sarebbe antieconomico e noioso estendere l’esemplificazione all’intero testo), ecco queste (volute? cercate?) allitterazioni: «Di un’ardita trovata»; «Di particelle piccine, tossiche, e di altre parassite»; «Di andate e di ritorni in mezza giornata». L’insistita allitterazione, normalmente da evitare in prosa (e invece fondamentale in poesia), è a ben vedere una ripetizione, dunque una ridondanza di suono; ma in Memorie dal quarto piano ricorrono anche altre ben più evidenti ridondanze: quelle che, nella teoria della comunicazione, possono definirsi come «l’eccesso, in un messaggio, di elementi significativi e di informazioni rispetto allo stretto necessario per la corretta comprensione e la ricezione del messaggio stesso».[7] Di certo l’Autore non ne fa uso perché concorda con il diretto superiore del suo protagonista, secondo cui «la ridondanza può servire a vederci un po’ più chiaro». «Non c’è e non c’è mai stata»; «non mi resta e non ci resta»; «curare con più cura»; «per tutta l’intera mattinata»; «con tutta la famiglia intera»… Ecco: queste e altrettali ridondanze segnalano finalità, esigenze, situazioni che si vorrebbero piene, totali, assolute, ma che tali non sono, poiché sistematicamente rovesciate nel provvisorio, nell’incompiuto, nell’antitetico, nel discorde.
La scrittura di Carlo Alberto Parmeggiani si sostanzia di un’ironia che non nasce dal confronto tra un qualche presuntuoso Ideale e un indigesto Reale, ma scaturisce dalla convinzione che il Reale raccontato nel suo divenire (da ordine – progettato, auspicato o realizzato che sia – a disordine e/o viceversa) sottende comunque sempre una mancanza e un mistero (due parole che spesso ritornano nella citata intervista), nella convinzione che siamo nati «per qualcosa, per un qualche motivo che ancora non ci è dato di sapere e mai sapremo nemmeno se campassimo due vite». E su questo, dunque, il Personaggio concorda con il suo Autore, anche se il libro inizia con una «Premessa quasi utile» in cui il Parmeggiani ci tiene a distanziarsi da chi narrerà «queste Memorie dal quarto piano che io ho soltanto raccolto e trascritto dalla voce di un caro amico […], importante funzionario dello Stato»; si gabella per umile trascrittore, evita il discorso diretto per non dover citare nome e cognome di colui che riporta i dialoghi, non dialoga con il suo “Anonimo”, al quale affida la completa responsabilità di quanto riportato e giudicato. Tuttavia poco oltre l’Autore ripete quanto detto con un’arguta aggiunta: «ho raccolto e trascritto alla mia maniera un brano della sua vita personale» (il corsivo è nostro). Per questo non mi pare disutile aver ragionato sulla sua «maniera», su uno stile significativo di una originale concezione del mondo.
Passiamo allora a trattare di almeno due temi fondamentali di queste Memorie dal quarto piano: il lavoro e il dopo-lavoro.
2. Il lavoro.
“Sullo sfondo di “dipartimenti, divisioni, uffici territoriali, settori, sezioni, segreterie e direzioni generali”, si sviluppa una trama ricchissima di storie di ordinaria e quasi metafisica burocrazia, di pratiche, tabelle, diagrammi, percentuali e relazioni illustrative e di personaggi dagli splendidi cognomi impiegatizi e incasellati in una precisa scala gerarchica di dottori e quasi dottori, ragionieri e quasi ragionieri. […] Tra tante figure e figurine, cavilli e ripicche d’ufficio, ricerche di miserevoli privilegi, scavalcamenti di carriera e relativi rancori, la trama finisce per aggregarsi intorno a un evento che dovrebbe dare lustro al quasi importante ministero: la celebrazione dei suoi cento anni da affidare a un libro commemorativo.”[8]
Meglio di così non si potrebbe riassumere il sugo della storia, per quanto attiene all’ambiente di lavoro dell’anonimo narratore. Altrettanto precise risultano le parole desumibili della descrizione che compare nel catalogo dell’editore e nella presentazione che si legge nel risvolto di copertina. Eccone una sintesi:
“Un’intera collettività e un maturo funzionario senza nome, spettatore di vicende altrui, in un fantomatico “quasi importante ministero” di una capitale non mai nominata, dove ci si impegna, tra le tante, troppe cose, nei preparativi della celebrazione del centenario della sua fondazione. È questo il clima che, dal suo ufficio al quarto piano il protagonista, un maturo funzionario, osserva gli altri, annotandone mentalmente l’irragionevolezza, la muta o dichiarata lotta del potere, l’incoerenza, la molteplicità di identità fittizie. L’improvviso arrivo di una pandemia virale finirà paradossalmente per…”
Precisiamo, per amor di pignoleria, che il narratore non solo “osserva gli altri”: essendo un personaggio interno alla storia che racconta. Anzi, essendone partecipe e/o testimone, ha un ruolo non proprio secondario, rispetto a quello dei molti colleghi e delle poche colleghe compartecipi di oneste o ignobili faccende, presentate con i toni di una quasi ‒ ironia, di un umorismo elegante, improntato all’understatement, all’intenzionale attenuazione della realtà, sempre narrata senza enfasi e senza esagerazioni tonali, con il risultato (pienamente raggiunto) di ottenere, per contrasto, una resa ancor più efficace delle situazioni e degli eventi.
Tutto ciò premesso a riguardo delle “soglie del testo”, lasciando a chi leggerà il piacere di godersi le vicende del protagonista e dei suoi colleghi (esemplare la tragicomica storia del dottor Edmondo Fuscagni, «latinista e gran compilatore di cartoline in versi oraziani, dirottato dall’insegnamento verso la pubblica amministrazione da chissà quale scherzo del destino»), il thriller dell’editando libro commemorativo, la originale cronaca della triennale pandemia, il gustosissimo resoconto della nostra penultima crisi di governo. Mi limiterei a rilevare alcuni temi che ritornano nel libro e che riguardano determinate qualità vitali per il perfetto burocrate. Per esempio, la “perspicacia”. Che, stando al Vocabolario Treccani, è l’“acutezza nell’intendere, valutare, risolvere fatti, situazioni, problemi”;[9] ma che, nel quasi-importante Ministero dove si produce, si interpreta, si passano da un ufficio all’altro ordinanze, circolari, progetti e tabulati, diventa una dote vitale per chi deve saper trovare l’escamotage vincente, e guardarsi da trappole e lacci, e apprendere come «fare la traduzione, in un linguaggio meno macchinoso, delle notifiche arrivate dai diversi uffici o ministeri». Il protagonista ‒ narratore possiede ed esercita le «soft skills, ovvero, in lingua nostrana, le competenze trasversali, di “facilitatore” di pratiche complesse, di progetti organizzativi, di rimedi a errori involontari», che paiono ben più importanti delle hard skills, le competenze tecniche e specialistiche. L’Io narrante ha “perspicace occhio”, per dirla col Guicciardini: è un “sagace” al punto che, grazie alla sua «creatività nel suggerire scuse, contro scuse e futuri possibili raggiri» sarà accolto nel «circolo privato di burocrati sagaci, i Perspicaci, […] una piccola casta di dirigenti, consiglieri, capi divisione»: una casta che include alcuni ma che, ovviamente, esclude altri, superiori o pari grado.
3. Il dopo-lavoro.
Di fatto, l’Io narrante è individuo stimato e considerato «degno di impegni complicati, anzi necessari al buon governo del quasi importante ministero». Si ritiene perciò realizzato e appagato? No: verum et factum nel suo caso non convertono, non corrispondono perfettamente, non si identificano. La verità non si manifesta nel fatto evidente del successo lavorativo. Perché il protagonista non si sente per nulla soddisfatto di sé stesso, e tanto meno del suo ruolo sociale: la sua giornata in ufficio trascorre «sempre in equilibrio sul filo della noia o di qualche rapido pensiero suicida, fortunatamente passeggero», e riporta le vicende dell’ufficio come se riguardassero gli altri più che lui stesso, come se lui ne fosse soltanto spettatore, in grazia dell’ironia distanziante di chi è convinto che tutte le cose siano vanitas vanitatum.
L’Io narrante, «scapolo invecchiato, senza affetti e famiglia da serbare ed eternare», vive in una grande casa, troppo grande per una famiglia che si è ridotta a lui stesso e a sua sorella. Due single non più giovanissimi: lui per una scelta che non lo soddisfa del tutto; lei, Flora, separata da un compagno, Pino, con cui convisse per circa un decennio e da cui ebbe il figlio Lucio, il bambino che
“avrebbe meritato assai più di quella manciata d’anni che aveva vissuto tra scuole, obblighi, doveri di bambino fino a che uno stravento e un passo falso lungo una ferrata di montagna in gita con suo padre, dilettante, vanitoso rocciatore e scavalcatore di colline, avevano messo fine al suo futuro. Un futuro del quale ogni tanto Flora fantasticava i dettagli che spesso soltanto immaginava. […] S’immaginava nonna, Flora, addirittura…”

Il tema dell’assenza compare già dalla dedica del libro «A Olga che non c’è più»: Olga era la gatta, dichiarò Parmeggiani nella succitata intervista[10], che gli fece compagnia per diciotto anni. Dedicare un libro alla propria gatta può apparire dissacrante: lo ammette l’autore stesso, nella citata intervista, aggiungendo però che la morte della gatta Olga fu per lui motivo di autentica e non superficiale sofferenza. Come l’assenza di sua sorella Flora ancora in montagna con Pino, o quella di nessuna delle due piacenti donne (la storica ma ormai ex amante Maria Luisa detta Lulusa e la giovane collega Sabina) con le quali avrebbe potuto por fine alla sua domestica solitudine. È l’ideologia dell’assenza, del mondo caratterizzato da un «“quasi” kierkegaardiano», dove ogni cosa deve essere (ma non è) completata, dove ogni creatura, fra le tante che si affacciano sulla scena di questo affascinante romanzo, sono «personaggi “quasi”», cui «manca sempre qualcosa per essere numeri interi»[11], per ottenere una vita “perfetta”, nel senso etimologico della parola, ossia totalmente compiuta. L’assenza è caratteristica dominante nel personaggio di Flora che non sa superare il lutto per la morte del figlio Lucio, né sa separarsi del tutto da Pino, l’ex compagno di vita ed ex padre responsabile del non-più-essere di Lucio. E parecchie sono le assenze definitive per morte sopraggiunta: quella del nipotino morto in montagna, del padre suicida, della storica ma ormai ex amante Maria Luisa detta Lulusa e di alcuni colleghi stroncati dal Covid. Assenze rievocate, in queste Memorie dal quarto piano, con la rassegnata ironia quasi tragica tipica del Narratore. Quasi tragica, l’ironia, perché in questi casi sotto o accanto al particolare che scivola nell’umorismo c’è qualche svelta (a volte secca, a volte più cordiale) notazione rivelatrice di carichi emotivi fin troppo pesanti. Un esempio: la morte per Covid dell’anziana collega Ippolita Scuderi che,
“instancabile com’era, avrebbe meritato in vita più che in morte una riconoscenza assai maggiore di una lettera funebre di elogi, scritta da un malpagato tirapiedi e firmata dal pugno del suo capo [il ministro] che nemmeno l’aveva conosciuta.”
Termino con un accenno ad un altro tema che riguarda il nostro Narratore, un eroe problematico alla ricerca di qualche salvifica “occasione”. Ecco la chiusa del primo capitolo, quello che segue la “Premessa quasi utile” e che s’intitola “Di una breve gita e di un odor d’ufficio”:
“facevo un largo giro per tornare camminando a casa, sperando di incontrare un’occasione, di imbattermi in qualcosa, in un inciampo, in un incontro fortunato, in una qualunque cosa fosse stata, pur di togliermi di dosso quell’odore penetrante [quell’odor d’ufficio che mi portavo sempre dietro] e quei pensieri [di suicidio].”
L’occasione, l’anello che non tiene nella catena della necessità, il miracolo laico. E in che cosa si imbatterà? Una «gatta sanguinante sulla schiena e lamentosa» che si porta a casa, e che dà al Narratore «una qualche contentezza nel vederla soddisfatta del mangiare», come si legge nell’ultima frase del libro:
“… tornare a casa, dove la gatta, a cui non avevo ancora dato un nome, accorreva a tintinnio del cucchiaio sul piatto del suo cibo per poi, grata del dono divorato, lanciarsi d’un sol balzo sulla mia poltrona, nell’attesa che la raggiungessi per appisolarmi insieme a lei, nel soave silenzio della sera.”
Una gatta che sembra diventare l’ipostasi di un ricreato ordine, dopo il disordine dovuto alla pandemia. Perché, come troviamo scritto appena prima, nei solitari dopo cena del Narratore arriverà
“Una sorta di ricorrente considerazione che prima o poi, e poiché tutto finisce, tutto sarebbe poi ricominciato, d’incanto e per mistero, nella fugacità di un nuovo accadere, destinato a sua volta a scomparire, e via così, per cicli d’infinito.”
Written by Vincenzo Moretti
Note
[1] Carlo Alberto Parmeggiani, Memorie dal quarto piano, Marietti 1820, Bologna 2023. Carlo Alberto Parmeggiani si occupa da sempre del rapporto tra immaginario e letteratura. Dopo la formazione con Luciano Anceschi viaggia per l’Italia e per il mondo, facendo mestieri disuguali: da bookmaker per le corse dei cavalli a professore di matematica in Svizzera. Considerato da Remo Ceserani come un nuovo autore fra i più “convincenti della contemporaneità” e da Edmondo Berselli quale “sulfureo, infido, notevole scrittore”, negli ultimi tempi ha soprattutto scritto e, fra le sue recenti pubblicazioni, oltre ad alcune raccolte di poesie in antologie collettive, ricordiamo: A tempo debito (Milano 2006), La malapiega (Milano 2007), La vera storia di Leon Pantà (Rovereto di Trento 2007), Nel cuore di Giuda e Giuda nel cuore (Milano 2008) e La mezza estate (Rovereto di Trento 2009), Le parole e i numeri (Milano Udine 2013), Cifre narrative (Milano Udine 2015), Di un paradosso davanti al San Carlino (Bologna 2016), Terre deserte (Torino 2018), L’importanza dell’azoto (Roma 2020), Le Hérisson et autre bestiaire (Parigi, 2022: contiene anche il racconto Le hérisson di Roland Cailleux).
[2] Carlo Alberto Parmeggiani “Memorie dal quarto piano”, nel sito “Il posto delle parole”.
[3] Si veda Massimo Di Matteo, Efficacia, efficienza e economicità nella Pubblica Amministrazione.
[4] Notturnale. 1. Che si riferisce, che è proprio dell’ufficiatura del notturno; recitato o cantato in tale ora canonica. 2. Che si svolge di notte, notturno. 3. Pittura o disegno che rappresenta una scena notturna o un ambiente illuminato parzialmente” (in Grande dizionario della lingua italiana, ad vocem).
[5] Così nell’intervista citata.
[6] Ibidem.
[8] Articolo redazionale apparso sul giornale on line “Voce di Carpi” “Dal Palazzo cronache di metafisica burocrazia. L’ultimo libro di Carlo Alberto Parmeggiani”, 31 luglio 2023
[10] Così nell’intervista citata.
[11] Le virgolette caporali riportano le testuali parole dell’autore nella citata intervista.



